
Pubblichiamo la seconda parte del saggio scritto da Giorgio Vasta per il terzo cofanetto (uscito a dicembre) che raccoglie la produzione di Ciprì e Maresco, gli ideatori di Cinico Tv. Qui la prima parte.
Lettera di dimissioni
Il secondo e ultimo decennio di Cinico Tv è scandito da una serie di deflagrazioni. Nel 1998 Totò che visse due volte – la storia di Paletta rinchiuso in un’edicola votiva, di Fefè brucato dai topi e di un Messia coprolalico – comincia ricominciando, vivendo due volte, collocando cioè nel suo incipit quello di Lo zio di Brooklyn di tre anni prima, l’impassibile ablazione dell’occhio – una vera e propria resa (nel senso tanto di arrendersi quanto di restituire) dello sguardo – che riprende e radicalizza il Buñuel tagliente di Un chien andalou; se nel regista spagnolo l’atto del vedere è definito dalla lama-nuvola-lesione che reseca l’occhio, in Ciprì e Maresco a venire deposto è un pezzo intero di sguardo, così introducendo a una visione del mondo sempre parziale e mancante («Unica certezza la bruma»). Nel 1999 Enzo, domani a Palermo e, nel 2000, Arruso, compongono un dittico – sull’abolizione del senso e di qualsiasi possibilità di speranza – che, per essenzialità e capacità di saturazione, ha in sé qualcosa di epocale (e che vale da ratifica dell’umiliazione come struttura portante del presente).
Nel 2003 Il ritorno di Cagliostro racconta la storia di illusione e frustrazione di due sconfitti, i Fratelli La Marca, dei quali, reificati nel monumento di se stessi, «nessuno seppe più niente» (e anche in Cagliostro, incastonata nel film, o meglio in un altro film nel film, torna ancora, quietamente ossessiva, l’ablazione dell’occhio, a ribadire un presupposto elementare che è manifesto, promessa, minaccia: «Lasciate almeno un occhio, o voi che entrate in questa visione»), mentre nel 2004 Come inguaiammo il cinema italiano, nel ricostruire la pluridecennale collaborazione e infine la separazione di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, si fa leggere anche come presagio di ciò che da lì a poco accadrà proprio a Ciprì e Maresco.
Quando nel 2006 La7 trasmette le venti puntate di I migliori nani della nostra vita ci si rende conto che lo sciame di Cinico Tv sta entrando nella sua fase conclusiva. Fin dalle prime immagini si avverte che qualcosa è cambiato. Gli interni appaiono diversi, sembrano più allestiti, e si avverte un modificarsi delle ombre, dei chiaroscuri e dei riverberi. Il bianco e nero di Ciprì – che al suo interno ingloba, tra gli altri, il corpo di Gregorio Napoli, critico cinematografico del «Giornale di Sicilia», nelle vesti di presentatore «controtelevisivo», così come, ossessiva indolente minatoria, una figura seduta che una puntata dopo l’altra continua a domandare a Berlusconi (al «Signò Belluccone») di portargli una birra – si sposta dal contrasto di toni del western di John Ford in direzione di sfumature che sono quelle della tv italiana delle origini, il grigio brunito di Non è mai troppo tardi di Alberto Manzi, così simile a quello che negli anni Settanta avrebbe velato le immagini di certi Telefunken.
In questo ricalibrarsi della fotografia si riconosce anche l’estetica delle foto colorizzate degli anni Cinquanta (quelle che, dipinte a mano con l’intenzione di vivacizzare i soggetti, rivelavano invece proprio quel senso di caducità che volevano tenere a bada), così come nella grafica e nelle titolazioni si percepisce un rimando al contesto insieme vitale e angusto delle tv locali palermitane degli anni Settanta e Ottanta. È come se, dopo un tempo fotografico tarato sul Mito (e dunque su un’esistenza extratemporale), anche a Cinico Tv toccasse in sorte di cadere nel tempo. Nel databile. Gli tocca «passare alla Storia».
I migliori nani della nostra vita simula nell’impostazione le trasmissioni tv che dagli anni Novanta hanno dominato buona parte della programmazione italiana: uno studio – dove Gregorio Napoli, rivelando i temi della puntata, oppone una forbitissima capacità oratoria al tremolio opaco del suo assistente Rizzo – e una serie di quelli che in una tv canonica sarebbero stati i cosiddetti «servizi», in realtà escursioni-irruzioni in un mondo storto, mutilo e discorde, il racconto senza trama di un mucchio di fantocci vitali e malinconici che provano sempre a fare qualcosa che non sanno fare (e quando ci si immagina che da un momento all’altro arrivi il monnezzaro Modugno per condurli fino alla discarica, arrivano invece i gendarmi che, come in Pinocchio, portano via cantanti impossibili e altrettanto improbabili danzatori del ventre): di questo microesercito disarmato fanno parte Vincenzo Ferrante, jazzofilo sordo, in smarrito dialogo con la voce di Maresco («Lei è sordo?», domanda Maresco; «Solo» risponde – suppone, azzarda – Ferrante, di nuovo ribadendo, nella logica di Cinico Tv, l’impossibilità di qualsiasi comunicazione), un Totò Cuffaro che, trapelando in effigie da una parete scorticata, ricorda il ritratto – nelle macellerie sistemato subito accanto alla cassa – del nonno fondatore, e poi, oltre a un Bernardo Provenzano col pannolino (interpretato da Pietro Giordano), i maestri Giovanni Ciprì e Michele Ferrara, uno alla fisarmonica e l’altro al sassofono, le loro contrastate esecuzioni dell’inno di Forza Italia, di quello di Mameli, il maestro Ciprì che procede per marcette, chiosando e infiocchettando il suono, il maestro Ferrara che si esaspera, sbuffa, rimprovera, alza gli occhi al cielo: Stan Laurel, Oliver Hardy e la loro musica-baracca.
Le sette puntate di Ai confini della pietà vanno in onda, sempre su La7, nel 2007. Quella in cui ci troviamo, lo dichiara la voce di Maresco all’inizio di ogni trasmissione, è «la regione intermedia tra l’ignobile e l’infame, tra l’immondo e l’indegno». Emulsionando il racconto della fame senza fine di Franco Scaldati e Gaspare Cucinella (il loro protratto dialogo tutto di gola, di raschi e uggiolii) alla storia di Giorgio Castellani – al secolo Giuseppe Greco (figlio del «Papa» Michele Greco), spericolatamente reinventatosi attore e regista cinematografico (da Crema, cioccolato e pa… prika a Vite perdute) –, i ragionamenti di Saverio D’Amico sul «dialettico siciliano» al discorso carbonizzato di Cirrincione Fortunato e a una specie di album di famiglia – lo schermo diviso in quattro quadranti: un uomo nudo che ogni tanto si gratta, Marcello Miranda sprofondato in se stesso (ogni tanto un rutto), l’attore Bernardo Greco imprigionato nel suo monologo illeggibile (se non per le coordinate Alto-Destra-Sinistra-Vitellino-Maiale), Pietro Giordano che a un tratto arresta il suo rantolo muto, sputa e dissolve i corpi rinchiusi nei quadri, infine dissolve se stesso –, ci si rende conto che nel carillon rotto di Cinico Tv (un marchingegno che, come l’umano, procede a singulti) pietà e realtà sono indistinguibili («Siamo davvero pietosi» mormora ancora, sempre più piano, sempre più da lontano, Francesco Tirone).
I migliori nani della nostra vita e Ai confini della pietà possono venire considerate come la lettera di dimissioni di Ciprì e Maresco. Una puntata dopo l’altra, per due anni, ci si ritrova davanti a qualcosa che, pur continuando a essere genio inventivo, reca in sé anche un senso di estenuazione, una fatica dello sguardo che sembra alludere a una volontà di commiato (azzardando si potrebbe dire che questo bisogno di chiudere fosse già intrinseco a ciò che Cinico Tv è stato dall’inizio: quindici anni dopo il carrello che in Keller sembra disegnare una circonferenza, nel 2007 il cerchio si chiude: la polvere torna alla polvere, la cenere alla cenere). C’è addirittura qualcosa, già nel modo in cui viene filmato lo spazio di I migliori nani della nostra vita e di Ai confini della pietà, che muove in questa direzione: quanto vediamo sembra osservato attraverso un cannocchiale, un iris, un monocolo – un cerchio di penombra che scurisce il margine dell’inquadratura, l’immagine sempre alonata, circonfusa di nero: quello che accade quando lo sguardo si chiude e la percezione viene meno (quando gli occhi – l’occhio – chiudendosi torna a guardare la propria stessa infinita caligine: «Unica certezza la bruma»).
Ciò che a quel punto si fa ineludibile è la relazione tra Cinico Tv e il tempo. I migliori nani della nostra vita è un titolo che, anagrammando, gioca in modo esplicito con il capolavoro di William Wyler. La storia raccontata nel film del 1946 è quella di tre reduci che alla fine della Seconda guerra mondiale tornano negli Stati Uniti dopo aver combattuto tra l’Europa e il Pacifico. In teoria dovrebbero andare incontro al reinserimento, nei fatti constatano che il ritorno è impossibile e che la loro condizione di reduci si è trasformata in un’origine che abolisce tutto ciò che c’è stato prima (rendendolo al limite qualcosa che sta tra il ricordo vago e l’immaginazione): essere reduci è la loro unica patria.
Assorbendo ed esasperando ancora di più il punto di vista e la sensibilità di Wyler (e di MacKinlay Kantor e Robert E. Sherwood, uno autore del soggetto, l’altro della sceneggiatura di I migliori anni della nostra vita), Cinico Tv ha reso nitida una percezione della contemporaneità: quello che esiste – la cosa in cui siamo – è un dopo (dei luoghi, dei corpi, dei legami) che non discende da un suo opposto; quello che, per contrasto, dovremmo chiamare il prima – l’ex ante, la vita (vita?) che precede il dopo – non c’è mai; non perché sia stato dimenticato fuori scena ma perché non essendoci mai stato è inimmaginabile. L’ex post è l’unico tempo, l’unica cosa con cui possiamo avere a che fare. L’oggetto più autentico dello sciame – frantumato in miriadi di particelle – è il reducismo come unico tempo abitabile. La bruma come unica certezza, la cenere fredda come un’origine che non ha mai fine (mi ritrovo a pensare – non posso non farlo – ai miei tragicomici vent’anni di guerra invisibile, al mio malinconico ritorno a Itaca, alla sensazione che per qualcuno – forse per più di qualcuno – gli ultimi vent’anni siano trascorsi nel consumare e poi nell’esaurire una propulsione – individuale, collettiva – che – non me l’aspettavo, non ce l’aspettavamo – tutt’altro che infinita aveva una sua data di scadenza, e che se pure è accaduto molto non è accaduto niente: la guerra è stata così tanto invisibile da far venire il sospetto che non sia mai stata combattuta).
Cinico Mai Più
È una circostanza casuale eppure significativa: intorno al 2007, dalla cenere fredda di Cinico Tv sorge, come una mostruosa araba fenice, Palermo Is Burning, la città che celebra se stessa in un tripudio di fuochi fatui. Una città, si diceva all’inizio, sempre più domestica (se non del tutto sguattera), intimamente assorta nella sua oscura felicità. Perché, infine, oggi Palermo è (ignobilmente) felicissima. Un superlativo che non va però inteso nell’accezione che gli attribuiva Nino Basile ragionando nel 1932 sul patrimonio architettonico cittadino, quando era possibile immaginare per Palermo sorti magnifiche e progressive – cultura ed economia come giacimenti attivi e veri e propri motori sociali –, ma in un altro senso: oggi Palermo è felicissima com’è possibile esserlo quando si partecipa a una sagra di paese – passeggiando, aggirandosi tra i banchetti, facendo la spola tra i gelati, lo zucchero filato, la porchetta, lo spazio percorso riconoscendo e venendo riconosciuti, in quello stato di euforia, insieme individuale e collettiva, che discende dalla percezione della propria presenza, facendo manutenzione della propria presenza, uno stato d’animo cannibale se non autotrofo, l’impulso a rendere tutto proprio, a mettersi dappertutto a proprio agio.
Attraversando in un qualsiasi sabato pomeriggio via Ruggero Settimo e via Maqueda ci si ritrova all’interno di una città che, indifferente alla possibilità di essere qualcosa di stratificato e complesso, ha ridotto i propri codici contraendosi alle proporzioni di un paesone, lasciando che nello spazio sociale si imponesse un’atmosfera da fiera campionaria permanente, da villaggio in festa, un iperlocalismo istintivo e orgoglioso, il piacere dell’autoreferenzialità a ogni costo, l’origine intesa non come circostanza – e dunque una casuale particolare occasione di conoscenza – ma come ragione di vanto, addirittura come virtù. Andando in giro per il centro di Palermo in quei sabato pomeriggio si ha la sensazione che la regola interna della Fiera del Mediterraneo – l’area fieristica cittadina – abbia innervato, capillare e al contempo robustissima, l’intera struttura sociale trasformandola in qualcosa di piccolo e comprensibile, di ilare e risolto, del tutto espellendo ogni eventuale residuo di trauma (e di trama, di articolazione, di tessuto eterogeneo), digerendo ogni eccezione, ogni rischio, ottenendo che la città, non più «intensamente peccaminosa», dia forma a se stessa attraverso un’embricatissima maglia di «errori piccolini», quelli che il Dio della canzone di Gaber non vede perché non contano, un reticolo di piccole colpe – irrilevanti, tra l’infantile e l’adolescenziale, subito perdonabili –, di cose da poco, una minutaglia di miserie che fa da endoscheletro a una città intera i cui abitanti sono per prima cosa complici, o meglio conniventi, ognuno quotidianamente disponibile a «chiudere un occhio», tanto da arrivare a dimenticarsi di averne due, persuadendosi che la visione monoculare sia l’unica possibile, perché chiudendo un occhio il senso della profondità viene meno e tutto si riduce, si distilla, il trauma si smaltisce, le cose diventano piccole, piccolissime, le tragedie si rivelano farse, le mafie mafiucole, non c’è nulla di cui preoccuparsi, e poi in questo concorde piccolo cabotaggio ci si riconosce a vicenda così bene, con una tale soddisfazione, che non ha senso immaginare altro.
E se tutto ciò può ancora venire considerato – ma si tratta davvero di un rimasuglio – come qualcosa di ignobile, niente di grave, perché del resto in una frase come «oggi Palermo è (ignobilmente) felicissima», all’avverbio che descrive il modo tocca stare tra parentesi, intravisibile in filigrana, una specie di fantasma, mentre il superlativo fa la parte del leone.
E dunque, se Cinico Tv è stato quello che Ciprì e Maresco si sono inventati per sentirsi, con Rimbaud, «abominevolmente a disagio», se è stato il loro tentativo di essere – a Palermo e, attraverso Palermo, in relazione a un’esperienza dell’umano – i sassolini nella scarpa (non l’antidoto ma almeno l’anticorpo), ciò che adesso va constatato è che Cinico Tv ha fallito (in un certo senso perfezionando – come si accennava – un fallimento negli anni precedenti già abbozzato ma ancora aurorale) e Palermo ha vinto, ha sbriciolato i sassolini, ha smaltito lo sguardo di Ciprì e Maresco, si è messa abominevolmente a proprio agio, ed è diventata una città incantata (anche se l’incanto è quello della puntina del giradischi che continua a percorrere sempre lo stesso microsolco). E così – mentre noi diventavamo umiliati e felici, euforicamente preda della nostra indistruttibile bêtise – Cinico Tv ha chiuso (il suo occhio), Cinico Tv è finita: è diventata Cinico Mai più.
Quando il sabato pomeriggio i palermitani sciamano in festa tra via Ruggero Settimo e via Maqueda, a non troppa distanza da lì, in via Roma, può capitare ancora di incontrare Pietro Giordano. È invecchiato, è stanco, se ne va in giro lento, storto, un sacchetto di plastica stretto in un pugno, nell’altro un cellulare rotto che nella sua mano sembra una cosa antica; a volte, senza neppure dare l’impressione di deciderlo, si ferma tra il marciapiede e la carreggiata, guarda davanti a sé, muove un passo per attraversare, zoppica, non passa nessuna macchina ma lui ci ripensa, torna indietro, posa il sacchetto per terra, mette il telefonino in tasca, si appoggia a un alberello che sbuca stento da un’aiuoletta, la terra invasa di cartacce. Mentre dalle strade più in là arrivano la musica e le risate – le voci della Palermo Is Burning in cui viviamo – Pietro Giordano se ne sta lì, curvo, un braccio disteso, la mano che stringe il tronco sottile, a rifiatare, ad ascoltare Palermo felicissima tutt’intorno – il fragoroso dopoguerra cittadino – e intanto fissa la carreggiata col suo sguardo lento e convulso, fatto di bruma, il silenzio ancora masticato tra le labbra, l’amaro interminabilmente chiuso nella bocca.
Giorgio Vasta (Palermo, 1970) ha pubblicato il romanzo Il tempo materiale (minimum fax 2008, Premio Città di Viagrande 2010, Prix Ulysse du Premier Roman 2011, pubblicato in Francia, Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Inghilterra e Grecia, selezionato al Premio Strega 2009, finalista al Premio Dessì, al Premio Berto e al Premio Dedalus), Spaesamento (Laterza 2010, finalista Premio Bergamo, pubblicato in Francia), Presente (Einaudi 2012, con Andrea Bajani, Michela Murgia, Paolo Nori). Con Emma Dante, e con la collaborazione di Licia Eminenti, ha scritto la sceneggiatura del film Via Castellana Bandiera (2013), in concorso alla 70° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Collabora con la Repubblica, Il Venerdì, il Sole 24 ore e il manifesto, e scrive sul blog letterario minima&moralia. Nel 2010 ha vinto il premio Lo Straniero e il premio Dal testo allo schermo del Salina Doc Festival, nel 2014 è stato Italian Affiliated Fellow in Letteratura presso l’American Academy in Rome. Il suo ultimo libro è Absolutely Nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani (Humboldt/Quodlibet 2016).





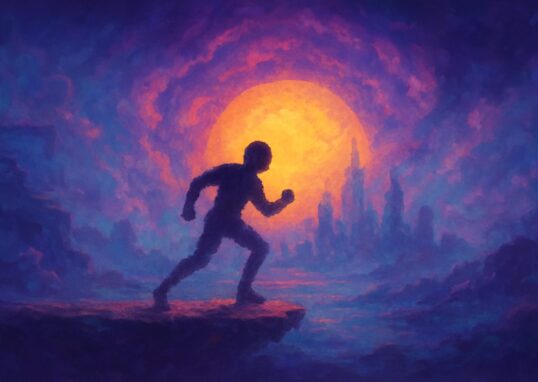

Come nell’inizio di Trono di sangue con cui Kurosawa fa affiorare e svaporare di continuo nella nebbia i suoi cavalieri che restano sempre nello stesso punto (vittime di un incantesimo delle tre steghe o incagliati in un microsolco di un disco che si incanta, appunto), Vasta scrive nella nebbia i nomi di Cinico Tv. E Palermo invece la inchioda e la fa diabolicamente equivalere a: impossibilità (annebbiante, ovvio) di nebbia.
Un saggio fin qui formidabile che fa un sopralluogo illumimante e cantato sulle periferie del visibile e dell’udibile, rende giustizia al potere di Ciprì e Maresco di fondare una staticità assoluta (nel pieno del cinema), applica (e adombra) tutta la magia presciente del linguaggio.