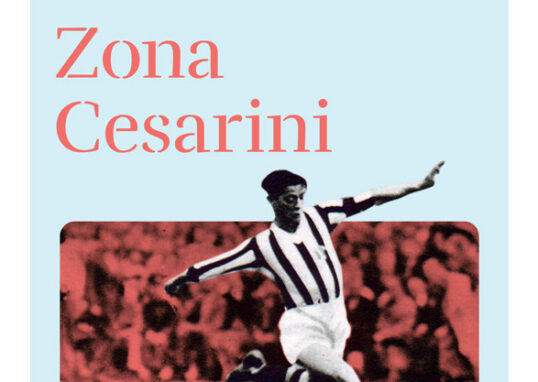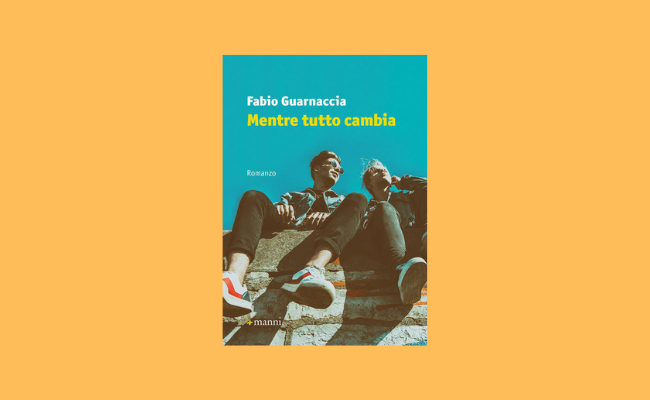
di Rossano Astremo
Età del malessere. Età dell’inquietudine. Età difficile. Queste e molte altre le definizioni date nel tempo per sintetizzare la complessità degli anni adolescenziali. Questa transitorietà e bonaccia connaturata agli anni giovanili è stata ed è ancora fonte da cui attingere per molti scrittori italiani. Lo sa bene Fabio Guarnaccia che nel suo nuovo romanzo Mentre tutto cambia (Manni, 136 pagine, 14 euro) dà vita ad una storia, ambientata durante l’estate del 1989,che ha come protagonisti un gruppo di adolescenti (il Vela, il Best, Paolino e Ivan) che scoprono il significato profondo dell’amicizia, dell’amore e della morte, avendo come rifugio, lontano dagli occhi indiscreti degli adulti, una casetta diroccata vicino a una discarica nella periferia di Milano.
Perché continua ad essere un momento dell’esistenza così tanto raccontata dagli scrittori?
“Non ne sono certo, ma credo abbia a che fare con le prime volte. Le prime volte, per esempio, che viviamo esperienze non mediate dalla famiglia, in segreto, senza confidarci, soli. Con l’unico supporto degli amici, che come noi non sanno bene cosa siano l’amore, il dolore, il disagio di un’identità scossa da quotidiani terremoti. Perché come noi vivono, sentono per la prima volta e non capiscono. Ci si torna spesso perché in quell’età, che è anche l’età della “corruzione”, accadono cose che ti rimarranno dentro per sempre. Cose che vediamo solo con la coda dell’occhio ma che non se ne vanno mai davvero. Queste emozioni congelate possono venire riprese in mano solo molti anni dopo e indagate per capire. Il racconto è l’arma più potente per farlo: solo quando si è in grado di raccontarsi le cose, si è in grado di capirle. E di perdonare, finalmente. Perdonare gli altri, gli adulti che non ci hanno capiti ma anche perdonare noi stessi, i nostri sé ragazzini. È un processo che avviene passo a passo, si fa nel mentre, come dire. Così come la scrittura si fa nel mentre, mai prima”.
Oltre al Vela e al suo gruppo di amici, un altro protagonista del tuo romanzo è la periferia milanese, che è a tutti gli effetti lo spazio eletto dei percorsi evolutivi dei ragazzi. Qual è a tuo modo di vedere il valore aggiunto di questo contesto narrativo ai fini del racconto della tua storia?
“Intanto, quello della periferia nord di Milano è il contesto nel quale sono cresciuto. Per quanto sia a tutti gli effetti un romanzo, la componente autobiografica è forte. Quel paesaggio è stato il mondo nel quale ho conosciuto le cose per la prima volta. Ma la periferia offriva, e credo offra, a un ragazzino la possibilità di nascondersi, di scoprire, di venire a contatto con un’umanità varia e vorace. E regalava un fuoricampo alle proprie ambizioni. Milano, dico nel romanzo, era come un confine invisibile, era lì, ma non ne avevamo veramente bisogno. Alla fine degli Ottanta, come all’inizio dei Novanta, i ragazzini in periferia stavano per strada. Non c’era già più il tessuto sociale che offriva una protezione, ma neppure c’era ancora quel senso di pericolo e timore negli adulti che ha portato a svuotare le strade. Allora il quartiere pullulava di questi branchi colorati di pesciolini che si mettevano alla prova ogni giorno. E ogni giorno era un continuo confronto e scontro. Stavamo pochissimo in casa, il meno possibile. Avevamo genitori al lavoro che uscivano presto al mattino e tornavano tardi a sera: quello che facevamo durante il giorno era un reciproco mistero. Noi non sapevamo nulla del loro lavoro e loro non sapevano molto di dove passavamo il tempo e con chi. Se ci penso oggi mi dico che era un eccesso di libertà, ma funzionava così. E nessuno aveva veramente paura”.
E poi gli anni ’80, laddove anche la socializzazione aveva delle modalità assai diverse rispetto a quelle di oggi. Se dovessi scrivere una storia di adolescenti nel 2021, in che modo “l’entrata in società” dei ragazzi sarebbe diversa?
“Credo che non saprei da dove partire. In fondo l’adolescenza è sempre simile a sé stessa, nei suoi cambiamenti perfino violenti, ma ogni epoca ne ha la sua personale declinazione. I ragazzini vivono l’adolescenza, la sentono, ma non la capiscono. Noi adulti proviamo a capirla ma fatichiamo a sentirla. Però ti posso dire che mi piacerebbe tanto leggere una storia di adolescenti ambientata in questi giorni di pandemia. In fondo è un po’ come nel mio romanzo, sono a confronto con qualcosa di più grande di loro, con la morte, con la colpa sempre presente di portare la malattia in casa e con l’esigenza, direi un dovere di natura esistenziale, di stare con gli altri e vivere quello che la loro età gli impone. Mi piacerebbe leggere delle trasgressioni, di tutti gli accorgimenti tattici per aggirare i doveri e i divieti spinti da una fame di vita che non si può reprimere. Qualcosa che abbia a che fare col desiderio di corpi e di socialità. E come tutto questo possa essere oggi vissuto come una colpa indefinita”.
Una domanda sulla lingua scelta. Come mai l’idea di attribuire ai ragazzi nei loro dialoghi un registro informale del parlato che però quasi mai si lascia andare a intromissioni del gergo giovanile? Non è il gergo giovanile un’altra modalità dei ragazzi di sentirsi “altro” rispetto ai modelli adulti da cui si emancipano?
“Il gergo c’è, ma usato con parsimonia. C’è il “tofa”, per esempio. Ma ho scelto la strada della parsimonia per due ragioni: la prima ha a che fare con il tono e con la lingua che attraversano tutto il romanzo, che è il tono malinconico di un uomo che giunto all’età adulta sente il bisogno di fare i conti con quella storia, con i rimossi della sua vita passata. Ne ha bisogno per capire cosa è successo davvero e qual è la sua colpa. Si addentra in quel mondo con timore, un po’ per volta, come facciamo con quei ricordi che fatichiamo a rievocare perché ci fanno paura e perché ci fanno vergognare. C’è una vena di dolore molto viva nella voce del narratore, che è il Vela ormai adulto. Ma c’è anche la gioia per la scoperta, il conforto di un mondo ritrovato, riesumato, che ha il sapore dimenticato di una casa nella quale abbiamo vissuto a lungo. Quindi il tono, come dicevo, mi imponeva di stare un passo indietro e di farli parlare in modo realistico ma senza marcare di continuo l’epoca. E qui arriviamo alla seconda scelta, che ha che fare proprio con la fine degli anni Ottanta. Personalmente non amo la nostalgia che circonda quegli anni. Non ne sono mai stato affascinato. I revival non mi piacciono. C’è pochissima nostalgia in questo romanzo, quasi per niente. Perché, come dicevo, ha il tono di chi rievocando sa che il passato tornerà in vita, sprigionando ancora la sua forza. Che siano accadute oggi o trent’anni fa, dice il narratore, le cose che ci hanno colpito di più sono sempre appena successe. Ovviamente ci sono delle marche e degli oggetti di puro desiderio di quel decennio, il Caballero su tutti, ma non volevo farne un museo. Ho usato solo quello che era strettamente necessario per connotare i personaggi e le situazioni. E lo stesso ho fatto per lo slang di quegli anni. Più che il gergo mi interessava recuperare la testa dei ragazzini, le loro emozioni e i loro schemi mentali”.
La scoperta di un cadavere morto di overdose da parte di un gruppo di ragazzi fa presto pensare a “Il corpo” di Stephen King. Ci sono dei testi narrativi che raccontano adolescenti ai quali hai guardato come modello nella scrittura del romanzo?
“Sì, hai ragione. Viene subito in mente. Ne aggiungo altri due per definire il perimetro dell’immaginario: Il giardino di cemento di Mc Ewan e American Dust di Richard Brautigan. Ma sono tanti gli scrittori che si sono confrontati con storie di adolescenti che incontrano la morte nelle sue forme diverse. Per lungo tempo ho concepito l’originalità come una specie di ossessione per il nuovo. Fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Finché alla tenera età di quarant’anni mi sono reso conto che questa idea ha più a che fare col narcisismo che con la buona scrittura. Lavorare su uno standard, che è un luogo caldo per ogni persona, mi ha dato la libertà di essere me stesso e di dare un senso diverso alla mia idea di originalità. È originale una storia autentica, che solo tu potevi raccontare. Recuperare un pezzo della tua vita, raccontarne l’unicità senza fare sconti, cercare di coglierne alcune verità che finiscono naturalmente per riguardare tutti. Credo che tutti abbiamo avuto il nostro Troisi, il nome che i protagonisti danno al cadavere del tossico per esorcizzare la paura: la forza dei simboli è questa. E credo che qui stia anche la forza della narrazione di finzione come forma di scoperta e conoscenza. E non solo di intrattenimento”.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente