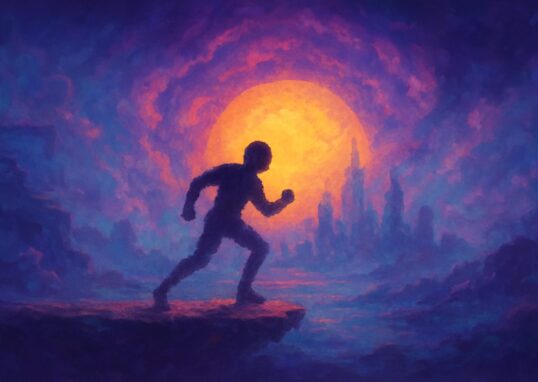di Ludovico Cantisani
Chiunque abbia seguito con discreta attenzione i notiziari dell’estate 2014 ricorderà piuttosto vividamente i video diffusi dall’ISIS e perennemente ritrasmessi, che mostravano le decapitazioni di giornalisti americani guidate dal famigerato “jihadista John”. Ora, fermo restando che in quegli anni nessuno si pose mai davvero la domanda dell’opportunità di trasmettere e diffondere quei video, di quanto il diritto e il dovere all’informazione fossero assolutizzabili e di quanto invece contribuissero a cementare una certa versione del terrorismo mediatico che dopo l’11 settembre si era affermata in ambito islamista – certo è che quei video si riallacciavano sottotraccia, nel loro significato mediatico, a un lungo discorso sulla Rappresentazione che a metà del secolo scorso aveva trovato una sua interpretazione particolarmente compatta.
Il cinema è un’arte o, quantomeno, un linguaggio – ci perdonerà Deleuze – che ha lo straordinario potere di registrare tutto ciò che materialmente sta davanti al suo mezzo tecnico, la macchina da presa. È difficile dire se delle arti, sette, nove o dieci che siano, il cinema sia la più materialista o la più spirituale: certo è che, come diceva un altro filosofo francese del calibro di Derrida, il cinema rappresenta anche “l’arte di rievocare fantasmi”, soprattutto quando con fare cinèphile e più o meno filologico si recuperano film vecchi di decenni e si viene tutt’a un tratto raggiunti dalla consapevolezza che tutti gli attori che si affacciano sullo schermo sono passati a miglior vita. Ne resta il simulacro, l’eidolon e tutto ciò che nella tradizione del pensiero occidentale designa, con variegate sfumature morali, la traccia, l’apparenza, ciò che si mostra ma che non è (più).
È proprio rispetto alla rappresentazione della morte, e non alla morte extrafilmica degli interpreti ma alla morte diegetica che passa sullo schermo, che, facendo un po’ di archeologia della critica, riemerge presto alla memoria un testo teorico quanto mai prezioso per la ricchezza delle sue implicazioni – un testo che si riallaccia tanto col nostro presente e l’omnipervasività mediatica che lo caratterizza, quanto col passato più remoto della nostra civiltà. Datato 1951, si tratta di Morte ogni pomeriggio, uno dei più noti saggi brevi di André Bazin, fondatore dei Cahiers du Cinéma e passato alla storia del cinema come mentore dei giovani Truffaut e Godard, e di tutta la Nouvelle Vague. Se una ventina d’anni dopo Roland Barthes, sfogliando le foto della madre defunta fino a risalire all’unwitnessed infanzia della donna, avrebbe identificato la duplice specificità della Fotografia nella considerazione oggettiva dell’è stato e nel richiamo soggettivo alla pietà, il saggio di Bazin prende le mosse da una considerazione simmetrica rispetto al linguaggio della macchina da presa. “La morte è uno dei rari avvenimenti che giustifichi il termine di specifico filmico: il cinema, arte del tempo, ha il privilegio esorbitante di ripeterlo”, scrive Bazin, e poi subito puntualizza: “ora, se è vero che per la coscienza nessun istante è identico a un altro, ve n’è uno sul quale converge questa differenziazione fondamentale: quello della morte… il momento unico per eccellenza”.
Scrivendo Morte ogni pomeriggio, Bazin avverte che, rispetto a suoi articoli coevi in cui si interrogava sulle implicazioni ontologiche del cinema e su una possibile moralité del piano sequenza rispetto al découpage classico, si sta muovendo su un terreno pericolosamente escatologico. È delle cose ultime che sta parlando e delle cose ultime nel momento in cui passano attraverso un linguaggio che, con la sua capacità di replicare fedelmente il reale, richiede una grande asciuttezza e una particolarità selettività di sguardo. Le successive affermazioni si collocano tutte attorno a quella sottile riga che sta tra il banale e il folgorante. “La morte non è altro che un istante dopo un altro: ma è l’ultimo. Senza dubbio nessun istante vissuto è identico agli altri, ma gli istanti possono somigliarsi come le foglie di un albero; di qui proviene il fatto che la loro ripetizione cinematografica è più paradossale in teoria che in pratica: l’ammettiamo nonostante la sua contraddizione ontologica come una sorta di replica oggettiva della memoria. Ma due momenti della vita sfuggono radicalmente a questa concessione della coscienza: l’atto sessuale e la morte”. Il fondatore dei Cahiers, scrivendo in una Francia degli anni cinquanta dove era ancora vivo l’eco di Henri Bergson, riconosce all’orgasmo e all’ultimo respiro un’importanza ontologica a sé stanti, come due momenti di “negazione assoluta del tempo oggettivo”: di conseguenza, dato che, almeno agli occhi di questa curiosa figura di cattolico di sinistra e para-bergsoniano, l’amore lo si deve vivere, non rappresentare, e quando lo si rappresenta si sfocia nell’osceno. Un po’ manicheo, ma conseguenziale – e lo stesso vale per la morte.
A questo punto Bazin si rivela profondamente ancorato alla produzione cinematografica del suo tempo, e meravigliosamente lontano dal prevedere gli esiti splatter e “stragisti” che molti filoni cinematografici, soprattutto quelli bene o male aderenti agli stilemi del cinema di genere, a partire dagli anni settanta assumeranno: “la rappresentazione della morte reale è anch’essa un’oscenità, non più morale ma metafisica: non si muore due volte. La fotografia a questo punto non ha il potere del cinema, essa non può rappresentare che un agonizzante o un cadavere, non un passaggio impercettibile dall’uno all’altro”. E come noi, pensando all’irrispettosità e all’oscenità della ripresa di una morte vera, fatalmente ci ricordiamo di certi video dell’ISIS, Bazin rivolgeva la mente a materiali analoghi a lui vicini nel tempo: il cinegiornale che documentava l’esecuzione di alcune supposte spie comuniste a Shangai, prima che Mao prendesse definitivamente il potere, con tanto di pistola che si inceppa costringendo un poliziotto a premere il grilletto più volte. “All’ordine, ad ogni spettacolo, quegli uomini erano di nuovo vivi”, commenta scioccato il fondatore dei Cahiers, “il buffetto della stessa pallottola colpiva loro la nuca… Spettacolo intollerabile non tanto nel suo orrore oggettivo quanto per una specie di oscenità ontologica”, che gli lascia pregustare, come suprema “perversione” cinematografica, la proiezione all’inverso di un’esecuzione, che parodisticamente riporti il morto invita.
Il dogmatismo di fondo con cui Bazin si esprime fa sorridere, e rivela più cose sulla cultura francese di quegli anni “prima della Rivoluzione” di quante forse sia necessario saperne. Lo spunto per giunta gli era venuto, e questo spiega anche il titolo che si richiama al saggio di Hemingway sulle corride in Spagna, al documentario La course de taureax di Pierre Braunberger, all’epoca molto in voga in Francia, in cui si mostravano ripetutamente le agonie dei tori, quando ancora era vivissima l’eco della morte sul campo del leggendario torero Manolete. “Grazie al film, si può violare oggi ed esporre a volontà il solo nostro bene temporalmente inalienabili. Morti senza requiem, eterni ri-morti del cinema”. Morte ogni pomeriggio è uno dei testi più noti di Bazin, certo uno di quelli più appassionanti, ma a volerlo prendere sul serio risulta al tempo stesso come il suo proposito più disatteso, in primis dai suoi discepoli della Nouvelle Vague.
Bazin ovviamente non specifica se per lui è oscena – e, in quanto tale, deve restare “fuori-scena” – la rappresentazione di una morte reale, o la rappresentazione della morte in sé, anche quando è recitata: ma, pur facendo esempi di film e cinegiornali che mostrano la morte effettiva di uomini o di animali, non è ingiustificato il sospetto che estenderebbe il malessere di Bazin nei confronti di ogni imago mortis, reale o immaginata che sia. Crash di David Cronenberg è stato conseguentemente indicato da alcuni come il film anti-baziniano per eccellenza – e forse questo nuovo Titane di Julia Ducournau è destinato ad essere anche da questo punto di vista suo epigono. Ma quest’insofferenza di Bazin nei confronti della rappresentazione filmica della morte rappresentava la versione aggiornata al XX secolo – e forse passata attraverso Walter Benjamin – di quella forma mentis tutta greca che escludeva la messa in scena esplicita di fatti di sangue sulla σκηνή, destinando tutti i momenti più truci delle tragedie a un fuori-scena.
Cercare di tracciare parallelismi tra questo o altri saggi di Bazin, e gli esiti pratici che nel decennio successivo ebbero i primi film dei registi della Nouvelle Vague, sarebbe giocare in casa. Cambiando contesto geografico e facendo un passo in avanti di un ulteriore decennio, il testo di Bazin si trova al tempo stesso contenutisticamente rispettato e stilisticamente ribaltato in uno degli ultimi film di Michelangelo Antonioni. Il film in questione è Professione: Reporter, il film di Antonioni con Jack Nicholson, e la scena pericolosamente “baziniana” è, nello specifico, il piano sequenza finale.
Andalusia. C’è un uomo con troppe identità, e una donna senza nome. L’uomo le ha appena finito di dire tutto quello che aveva da dire, la storia, dissonante e amara, di un cieco suicidatosi dopo aver iniziato miracolosamente a vedere, poi le ha ingiunto di andarsene. Probabilmente sa di essere condannato. Incautamente, guarda fuori dalla finestra, e di lì a poco noi ci troviamo a guardare con lui, con la macchina da presa che, inaspettatamente e letteralmente, prende il volo e, al posto del protagonista, attraversa la grata da cui lui non sa sgattaiolare. Fuori, sulla piazza, davanti ai resti di un anfiteatro romano mai inquadrato nella sua interezza, passano passanti di ogni età, all’apparenza innocui ma soffertamente estranei, come quelli che una dozzina d’anni prima si profilavano nel finale de L’Eclisse. Eppure succede qualcosa, nel frattempo: quando la macchina da presa si riavvolge su sé stessa, e l’inquadratura da un’implicita soggettiva torna ad essere un’oggettiva, il protagonista David Locke è morto, e due diverse donne lo piangono dopo aver a stento conosciuto questo transfuga dell’esistenza.
In questo piano sequenza finale, ma anche in altre scene vivide come quella della mancata intervista che Locke provava a fare a un supposto stregone africano, Professione: Reporter appare, da un certo punto di vista, come un laboratorio a cielo aperto – un’interrogazione inesausta, e condotta sul corpo vivo dell’opera, circa le possibilità dell’immagine, della macchina da presa, della visione filmica. Qualcosa di simile, di meno chiaro ma anche di più sfumato rispetto a quanto Antonioni stesso pochi anni prima aveva fatto in Blow-Up, tanto da farli indicare a Lino Miccichè come due film complementari e consequenziali, in cui “la mise en situation di David prende avvio dove si conclude quella di Thomas”; e non per nulla lo stesso Blow-up, a voler semplificare, era tutto giocato su un “vedo/non-vedo” a proposito di un omicidio già avvenuto, o forse solo fantasticato. Anche l’altra grande scena di morte del cinema di Antonioni, quella che chiude Il Grido, era giocata tutta di tagli, e l’urlo che dà il titolo al film non è quello del protagonista Aldo, che si getta da una torre come corpo muto, bensì quello della sua vecchia amante Irma, responsabile peraltro del suo pellegrinaggio e del suo suicidio. Per vie sue, e certo non per schematica adesione a stilemi critici d’oltralpe, Antonioni condivide con Bazin un implicito orrore per l’istante aoristico della morte: ma anche la tendenza del regista ferrarese alla sequenzialità di campo, eternata in Professione: Reporter ma presente sin da quell’opera prima criticamente sconcertante che fu Cronaca di un amore, lascia intravedere una convergenza con Bazin che va al di là della contingenza di una singola scena madre. Non per nulla Jean-Luc Godard, già affermatosi su un piano internazionale, volle personalmente intervistare Antonioni per i Cahiers, nel 1964; e Antonioni a quell’allora giovane regista lasciò una delle sue dichiarazioni di poetica più nette: “sento il bisogno di esprimere la realtà in termini che non siano del tutto realistici”.
Tendente ai limiti della sequenza continua, e insofferente verso i confini di qualunque tipo – la sconfinatezza degli ambienti rurali, contrapposta all’horror vacui urbano, è una delle prerogative del suo immaginario visivo – Antonioni, questo spaesaggista, non si è limitato a scrutare i limiti morali e ontologici della rappresentazione del Morire, ma ha articolato tutto il suo percorso, soprattutto negli ultimi sei film, nella direzione di un’indagine puramente ontologica del mondo che ci circonda, delle sue forme, delle sue strutture. La tecnica dell’ingrandimento che dà il titolo a Blow-Up, e che avrebbe fornito la matrice anche del percorso di Antonioni come pittore, non è che un mero punto di partenza, per una progressiva decostruzione, e parallelamente per un’epistemologica individuazione, del Reale nella sua forma pura, svelata. E se registi simmetricamente opposti come Terrence Malick e Lars von Trier hanno indagato l’essere-nel-mondo in una prospettiva fondamentalmente spirituale, volta rispettivamente ora a riconoscere “la divina presenza, che alberga in ogni uomo e in ogni donna”, ora invece la più totale e totalizzante assenza di Dio dal mondo e indifferenza beffarda della natura, Antonioni è stato forse l’unico che,
In questa visione tendente al metafisico del sociale e del reale tout court Antonioni manifestava inevitabili affinità visive con Giorgio de Chirico, che efficacemente Jean Cocteau ne Il mistero laico definiva “l’umanista inumano”. I suoi personaggi appaiono in tutta la loro fragilità, fagocitati da malcelate ipocrisie, intrappolati in un flusso vitale privo di slancio, che costringe a una festa borghese potenzialmente senza fine e senza eschaton, come ben dimostra La Notte. Eppure, il suo è un cinema umanista, umano: non si avverte né la presenza né l’assenza di Dio. L’afflato metafisico di Antonioni si volge da un’altra parte, non in Dio e in quella metafisica burocratizzata che è la teologia.
Che Antonioni fosse un maestro nei finali lo dimostravano, già prima di Professione: Reporter, quell’amplesso beffardo che chiude La Notte, la partita a tennis con l’invisibile su cui si esaurisce Blow-Up e l’esplosione parcellizzata del consumismo su cui deflagra Zabriskie Point, ma è al finale dei finali, al finale del suo ultimo film, che è affidata una meta-rivelazione meta-cinematografica che serve a far luce su tutto il cinema antonioniano. Come se il regista, coadiuvato sul set di Al di là delle nuvole da Wim Wenders, dopo aver plasmato i momenti più alti del suo cinema come critica delle forme e del linguaggio stesso in cui si esprimeva avesse deciso in ultimo di fare la definitiva analitica di tutto il suo itinerario, in barba ai critici più superficiali che non erano riusciti ad andare oltre la categoria dell’alienazione e dell’incomunicabilità. La sequenza finale di Al di là delle nuvole venne concepita e girata da Wenders, ma riprendendo fedelmente il passaggio centrale di una dichiarazione che Antonioni aveva rilasciato già anni e anni prima. Il regista protagonista di quel film testamentario a cui presta il volto John Malkovich, che abbiamo fino a quel momento accompagnato in giro per l’Europa alla ricerca del soggetto per il prossimo film, scruta un’ultima volta i personaggi che ha immaginato nel suo percorso per poi sancire in voice-over: “noi sappiamo che sotto l’immagine rivelata ce n’è un’altra più fedele alla realtà, e sotto quest’altra un’altra ancora, e di nuovo un’altra sotto quest’ultima, fino all’immagine di quella realtà assoluta, misteriosa, che nessuno vedrà mai”. Se non è metafisica questa…
Cinema sempre e per sempre di ricerca, corpo a corpo filmico coi limiti della tecnica e del linguaggio filmico stesso: Antonioni scrisse un significativo articolo su Hegel e i colori, ma sarebbe interessante rileggere il suo cinema anche attraverso un prisma kantiano, fra le propaggini regolative che ispirano Professione: Reporter e il sovratesto epistemologico che si dischiude in Blow-Up. Ma cos’è in fondo quel movimento di macchina che prima si allontana dal corpo morituro di Locke e poi lo ritorna a piangere assieme alle “pie donne”? È pietà? È freddezza? Certo non è indifferenza. Certo è che questo girare – letteralmente – lo sguardo della macchina da presa, lasciando la morte di Locke in un feroce fuori campo, si riallaccia a una coscienza millenaria della sacralità e dell’oscenità, congiunte, del morire – ma al tempo stesso è una metafora stilistica, potente e ricchissima nella sua scarnificazione, del movimento stesso dell’evasione, dell’estasi, se vogliamo, se davvero l’anima al momento della morte abbandona quella prigione che è il corpo — non scordiamoci la leggerezza con cui la macchina da presa attraversa la grata. Certo è che, con un solo movimento di macchina, Antonioni dischiude molte più implicazioni teoriche di quanto a volte facciano intere filmografie. E se Bazin tremava, davanti alle possibilità pratica e all’impossibilità teoretica di filmare la morte, di filmare l’inifilmabile – Antonioni fa qualcosa di più: esorcizza la morte nella tecnica, esorcizza la morte nello stile, esorcizza la morte, in fondo, nel Linguaggio.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente