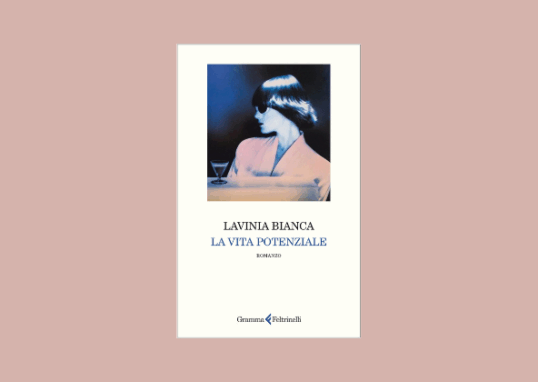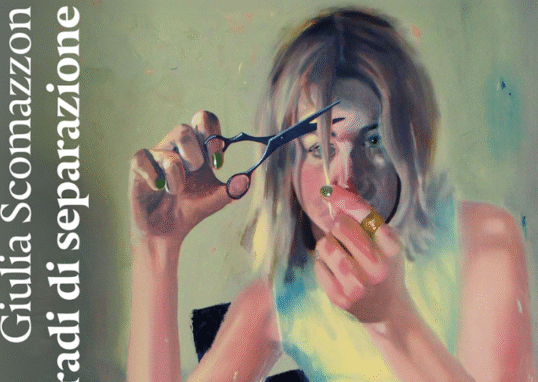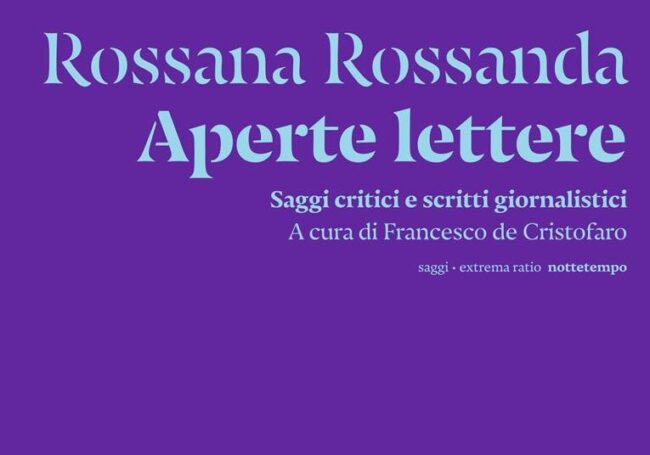
Sabato 25 marzo, in occasione di Libri Come, Aperte lettere verrà presentato in un incontro con Francesco de Cristofaro, Daniele Balicco, Guido Mazzoni e Alice Valeria Oliveri.
di Maria Rita Paratore
Eloisa, Virginia Woolf, il principe Myškin, Medea. Di lettera in lettera, di recensione in recensione, la lettura è vorticosa, autori e personaggi prendono e pretendono spazio nella cinesi del pensiero dell’autrice. Critica letteraria e giornalista, dirigente di Partito e femminista, allieva di Antonio Banfi, il pensiero militante di Rossanda si mostra apertamente in dissenso con le compagne del movimento femminista della differenza e con i compagni del Partito Comunista. Quando recensisce Antigone non può fare a meno di appellarsi alle compagne della Libreria delle donne di Milano; nell’istante in cui riflette sul ‘tramonto in una tazza’ della puritana Dickinson, non nasconde le distanze dai marxisti critici sull’interpretazione dialettica della storia. È il ritratto di un’intellettuale del presente quello che emerge in Aperte lettere, edito da Nottetempo. È nella rassomiglianza fra i suoi e i nostri interrogativi che se ne ricava un pensiero aperto, capace di problematizzare le categorie strutturali della cultura politica occidentale: potere e crisi, rivoluzione e degenerazione, storia e movimento.
Quando scrive “Chi ha paura di Virginia Woolf? Io” e “Donne e potere”, Rossanda si misura con lo spazio lasciato vuoto dalle compagne femministe separatiste – lo spazio del potere. L’argomentazione è serrata, le distanze dal femminismo della differenza decisive. Le compagne sono complici e vittime di un paradosso: convinte che il potere sia nemico, preferiscono l’indifferenza alla lotta di classe. Ma per Rossanda la cifra distintiva del movimento femminista è stata non tanto la scoperta dell’oppressione femminile da parte del potere maschile, quanto la consapevolezza di essere portatore di un’altra esperienza, che però, spoglia della lotta come concorrente specifica e alternativa al potere patriarcale, rischia di “diventare merce” (p.126).
Chiuso nella woolfiana ‘camera tutta per sé’, il femminismo della differenza entra nelle spire del processo di mercificazione, che proprio della differenza fa “femminilizzazione del costume: nell’abito, nella casa, nell’ambiente, tutti dolcemente ma tenacemente risospinti alle ‘fragilità’, non funzionalità, superfluità – il pane e le rose – degli oggetti; è il trionfo d’una visione merlettistica dell’ambiente” (p.126). La dimensione della lotta collassa in uno spazio conchiuso e futile, teatro di un separatismo impolitico – una ritrazione nel terreno privato lascia spazio di riproduzione ai meccanismi del potere patriarcale e del capitalismo. In questa autoreclusione privatistica, le meno fortunate sono costrette a un aut-aut, come “l’emancipata furibonda, che dalla finestra di Virginia Woolf lancia proiettili su ogni maschio che si avvicina e intanto compete con lui e con le altre”, oppure, come chi, a volte, esce “anche per buttarsi nel fiume”. “Ecco perché io ho paura di Virginia Woolf, compagne ed amiche che la amate tanto” (p.129), chiosa epigrafica.
In questo suo richiamo alla politicità, Rossanda non occulta mai il tragico del politico: il potere non è buono. Nel commentare L’idiota di Dostoevskij, annota: “Che è dunque la bontà? L’assoluta disponibilità all’altro”. La bontà è più che cristiana: è cristiana ortodossa. Non si corrompe nel mondo: “Il mondo è del male. Il peccato ne è la prova. La bontà è inutile. O almeno non appartiene all’universo dell’utilità” (p.26). Nel prisma del suo realismo, secondo cui l’opposto specifico della bontà è il peccato, il potere politico si innerva precisamente in questo piano di realtà. Laddove Medea “sa che ogni potere poggia su un misfatto, focherello assassino alimentato da ambizioni basse” (p.152), l’interrogativo di Creonte in Antigone (“come governerò – dice Creonte a un certo punto – se tratterò allo stesso modo il giusto e l’ingiusto?” – p.106) rimane apparentemente inevaso. La lacerazione tra Antigone e Creonte, tra etica e diritto è risolta nel movimento dialettico dei rapporti di classe. Nota, Rossanda:
Pensano, le mie amiche, che come nella novella di Andersen basti gridare ‘Ma l’imperatore è nudo’ perché quello sprofondi. Invece non sprofonda affatto. La cognizione del potere non ci rende liberi da esso, come quella del dolore non ci risana. O il potere viene spezzato oppure gridargli ‘Sei ridicolo, non ci sei, non ti vedo’, non è più che l’indispettito colpo di spillo d’una infelice signora inglese (p.135)
Lo stesso tenore critico innerva la nota di Rossanda su La storia di Elsa Morante. Ai compagni che plaudono a un romanzo in cui la disparità tra coloro che fanno la storia e coloro che la subiscono non viene risolta, in cui Hitler risulta uno sconfitto ma non una vittima, in cui i subalterni sono gli unici portatori di valori ‘di natura’ ma relegati all’atmosfera del magico, Rossanda incalza: “E noi, rivoluzionari di professione o presunti tali, ad applaudire: ‘Ma bene, proprio così, quel che andava finalmente detto?’” (p.193), e puntualizza, “Mi si lasci dire: ‘Grazie, no’” (p.194). La descrizione rassegnata di una storia in cui ‘niente cambia e non ci resta che il pianto’ non è moderna, non descrive il progresso. La storia, con tutta evidenza, sconta un deficit di marxismo: “ma che Marx insegni qualcosa sui meccanismi della società, mi dia una chiave della storia meno ‘schematica’ e ‘formulistica’ che non ‘i poveri sempre poveri saranno, e i potenti sempre potenti’, di questo sono sommessamente certa” (p.194).
E nell’Italia postbellica i comunisti italiani estranei non lo sono stati. Sono stati l’avamposto democratico della penisola, racconta. Il fascismo e il conflitto bellico scardinano i criteri del giusto e l’ingiusto, cancellano la prevedibilità, interdicono il lutto: “’Da domani non posso venire più a scuola, sono ebrea’ (…) e invece che gridare mi scoprii a tacere come gli altri” (p.159). In questo contesto, la Resistenza e il Comitato Nazionale di Liberazione guardano al PCI come un modello di democrazia avanzata. È decisiva la presa in carico democratica delle istanze delle classi subalterne tanto che, laddove i sistemi democratici ne eludano la domanda, essi si espongono alla propria degenerazione.
Insomma, il leitmotiv delle considerazioni più politiche di Rossanda è la codipendenza tra spazio pubblico, lotta di classe e cultura. Sullo sceneggiato RAI Anna Karenina, gli strali di Rossanda colpiscono la sciatteria e l’incultura: “ci offende perché ci ha gabellato per Tolstoj quello che non è” (p.72). Possono essere interessanti, al contrario, alcuni shorts o lungometraggi sovietici, che riescono a promuovere “una sollecitazione alla riflessione storica, modesta ma attenta” (p.73). Neanche la letteratura per bambini rende conto di questo, dacché risponde a un’esigenza di condizionamento e controllo, volto oscuro del pur chiarissimo allargamento dei diritti. Il risultato è la proposta di “come la società vorrebbe o avrebbe voluto che diventassero i ceti subalterni e le donne, cioè quelli che in grande massa non accederanno alla cultura vera” (p.79). Alla cultura come strumento di assoggettamento delle classi subalterne, ella contrappone l’idea di una scuola di massa strumento di emancipazione e di cittadinanza: “Non sarebbe l’ora di aprire il discorso sulla scuola procedendo non dallo ieri all’oggi, bensì dall’oggi allo ieri, e sempre mettendo nelle mani dei bambini i grandi testi? Non tutto sarà subito chiaro, ma nulla sarà inutile; e là dove il pensiero ‘aggancia’ sarà una formazione autentica, non l’accumulo di pseudoconcetti che chi poi studia davvero deve liquidare” (p.77).
Lettori attenti non riusciranno, forse, a celare anche solo un moderato imbarazzo verso queste posizioni tanto dirompenti nella loro portata politica quanto inattuali. La postmodernità si innesta nella crisi del politico quando “sbiadisce la necessità di esorcizzare i mostri della storia europea, e assieme si dubita di potersi definire e agire su un futuro” (p.165). Imbarazzata è anche Rossanda, la quale non dissimula il fastidio per la degenerazione culturale postmoderna, come nel caso di Bienveillantes di Jonathan Littell che fa della deportazione ebraica un romanzo con sole finalità di mercato. È categorica: “sarebbe più interessante capire come siano diventati ss, anche senza esserne costretti, uomini non mascalzoni in partenza, problema che dà da pensare non solo agli storici ma a chiunque di noi. Nel lavoro di Littell esso non è sfiorato” (p.221).
Nella riflessione della ragazza del secolo scorso si impone un principio di responsabilità che accompagna tanto le riflessioni sulla cultura, quanto quelle sulla politica. Il figlio del secolo di Scurati, che racconta l’ascesa al potere di Benito Mussolini, sottolinea la tiepidezza con la quale l’Italia ha permesso che il fascismo si sviluppasse. Sono puntuali i riferimenti alla degenerazione della politica: “serve di più, mi sembra, a capire i pericoli attuali del salvinismo, e a misurare la debolezza di una reazione anche soltanto ‘politicamente corretta’ delle attuali opposizioni. E quindi, si pone il problema delle responsabilità dei permanenti rinvii di una presa di posizione netta sul fascismo” (p.224).
La tensione etica si manifesta vivida, prima, in una lettera del 9 maggio 1982 a Gabriel Marcia Marquez. Non a caso definisce Crónica il romanzo della responsabilità. Di fronte alle contraddizioni dei socialismi reali a Cuba, in America Latina, scrive:
molti non osano denunciarlo perché temono di perdere con esso quel nocciolo di verità che sta dietro a ogni “imperativo” morale o sociale? Non tacciamo davanti agli esiti delle rivoluzioni, cui abbiamo dedicato la vita, per paura che cada l’idea di rivoluzione, e così la lasciamo assassinare e assassinarsi, divenuta fragile perché simile all’avversario? Chi crede che la rivoluzione era un’utopia, può tacere; ma chi non lo crede, non è simile a tutti coloro che tacciono davanti alla morte annunciata ed evitabile? (…) Il mito è consolatorio, la verità non sempre lo è. Rincorrere la rivoluzione quando le rivoluzioni sono brutte a vedersi non è facile. Ma possiamo sfuggire a questo dilemma, noi che ci crediamo ancora? (p.220)
E il calore della firma: “Ti abbraccia Rossana”.
Rossanda mette a nudo tutte le contraddizioni interne alla politica militante nel momento in cui si scontra con la caduta e la distruzione del mito – la promessa di libertà socialista diviene regime illiberale. Che fare? Lo ricorda alle compagne del femminismo della differenza e mi pare emerga qui con una forza lirica senza eguali: non è sufficiente gridare che il re è nudo. Sembra che la tensione morale assuma una torsione duplice: una trazione verso il mito, la fede politica, la rivoluzione, da una parte; un debito etico verso il reale, dall’altra. Non può esserci unidirezionalità, sostiene Rossanda. Fra il mito e la verità, Rossanda consapevolmente sceglie la dimensione della responsabilità, solo strumento capace di conservare la fede.
Laddove al silenzio consegue la perdita di una fede astratta, logica, imperativa, qui la denuncia, l’assunzione di responsabilità conserva la fede, ovvero davanti alla corruzione di una rivoluzione, lo slancio all’agire pubblico non è cooptato. “La guerra è fuori della porta, svoltato l’angolo del Medio Oriente, forse anche più vicina; lo Stato è già dentro la porta. Per la società delle estranee le iscrizioni sono chiuse, io credo, dal 1914. Alle donne bisogna dirlo. Devono, anche se non ne hanno voglia, spellarsi le mani e demolirsi il cervello rispondendo anche loro a tutte, ma proprio a tutte le domande. Non c’è più un orto concluso dove rifugiarsi” (p.135).
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente