
Il padre della sposa fa parte dell’epica della cinematografia americana e non solo, girato da Vincente Minnelli nel 1950 ha dato forma grazie alla celebre interpretazione di Spencer Tracy all’ideal tipo del padre americano ovvero del padre contemporaneo. Ansioso, ancora in carriera, padre e protettore della sua famiglia che è sì di stampo patriarcale, ma si sarebbe detto all’ora senza ombra di dubbio democratica.
Il film lavora abilmente attorno ai cliché della relazione padre figlia (qui interpretata da una giovanissima Elisabeth Taylor). Il padre della sposa è uno che subisce; subisce il tradimento della figlia che gli preferisce il suo futuro sposo e della moglie che è entusiasta di quello che lui interpreta come un vero e proprio tentativo di liberazione. Il personaggio è buffo, ansiogeno (ovviamente grande bevitore di superalcolici), ma tanto tanto buono e generoso. A distanza di settant’anni pur risultando ancora capace di far ridere e di far commuovere il film tradisce inevitabilmente la rigida società patriarcale a cui appartiene e che tutt’oggi resiste e lotta (insieme a loro verrebbe da dire, ma anche insieme noi sarebbe più corretto ammettere).
Katherine Angel con il suo pamphlet Bella di papà (tradotto per Blackie edizioni da Veronica Raimo e Alice Spano) svela con esattezza e precisione i tic maschilisti e l’evidente spadroneggiare alle volte in chiave esplicitamente violenta altre con un atteggiamento più mimetico che il padre, il patriarca esercita sulla figlia obbligata e cresciuta con l’obiettivo più o meno evidente di diventarne l’occulta sposa per non dire all’occasione serva e badante.
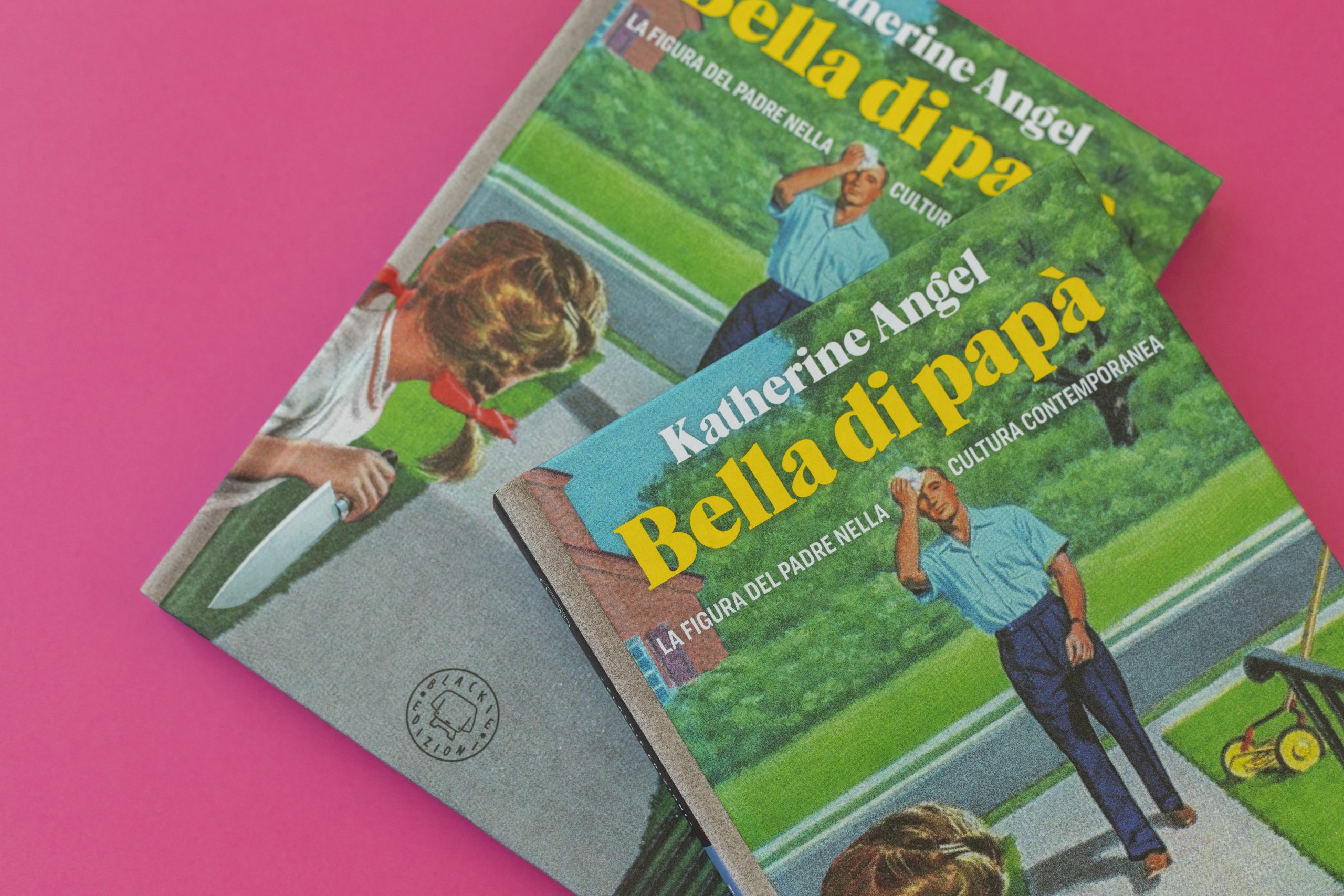
Angel tra i molti esempi della produzione culturale degli ultimi anni cita la versione de Il padre della sposa girato da Charles Shyler nel 1991 con Steve Martin (poi diventato anche serie tv) che per certi versi appare ancora più assurda visto che i tempi come spesso si dice ormai erano cambiati.
Anche qui il discorso retorico si appoggia sulla bonarietà e la sobria simpatia di Steve Martin per far passare occultamente una forma di regicidio: l’abbandono del padre da parte dalla figlia. Anche in questo caso il cerchio si chiuderà con il ritorno alla famiglia ovvero alla nuova famiglia che vedrà a quel punto in allegra competizione padre e genero quali prosecutori del sistema patriarcale. Aspetto che risulta ancora più evidente con il sequel del 1951 sempre per la regia di Vincente Minnelli, Papà diventa nonno. Dove appare sempre centrale, in ogni movimento che la storia assume il padre quale unico e vero protagonista dal titolo fino alla conclusione della saga famigliare.
Verrebbe da domandarsi se al buon Vincente Minnelli non sia mai venuto qualche dubbio in merito al rapporto padre figlia che metteva in scena, visto anche quanto sarebbe stato complicato e a tratti feroce quello con sua figlia Lisa nata nel 1946.
Angel è efficace ed implacabile nel rivelare soprattutto ai maschi – che siano padri o meno non conta – i meccanismi di una relazione che pretende di controllare, chiudendola a chiave o sotto una teca di vetro, la figlia che al padre deve sempre mostrarsi bella e premurosa.
In poco più di cento pagine l’autrice appoggiandosi a Donald Winnicott definisce il percorso di una relazione che troppo spesso genera sofferenza e subalternità nella figlia. Tuttavia sorprende che non sia stata segnalata – tra le varie opere citate – quella che forse meglio di tutte negli ultimi anni rappresenta una relazione padre figlia: il romanzo di Philip Roth, Pastorale americana. Nel romanzo il buon americano, lo svedese Seymour Levov – brillante esempio di sogno americano (quindi maschio) perfettamente riuscito – si trova di fronte alle incomprensibili scelte della figlia rivoluzionaria Merry vera agente e protagonista di tutto il romanzo.
Merry, dal balbettio che l’accompagna dall’infanzia fino al suo tentativo di liberazione svela il dramma e la perversione della relazione paterna. E nell’incapacità di Seymour di comprendere che proprio nel tentativo di ricostruire ad ogni costo il nido paterno – generatore ultimo che manderà tutto e tutti in pezzi – sta tutta l’impossibilità di un amore schiantato dal conformismo sociale maschilista. Philip Roth – nonostante fosse Roth come si usa dire oggi – l’aveva capito benissimo e ha saputo raccontarlo ancora meglio.
Giacomo Giossi è responsabile editoriale di cheFare. Scrive per quotidiani e riviste.




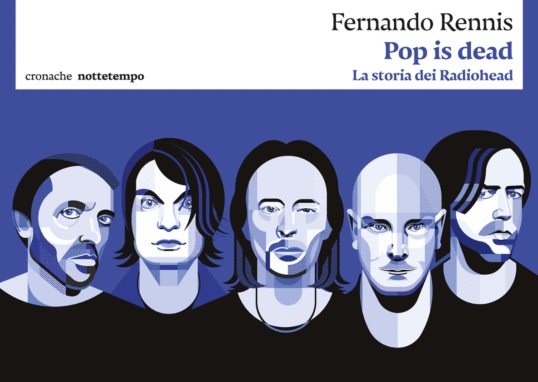


bella recensione di un libro interessante che cercherò (da padre…) di procurarmi.
p.s.: forse è meglio correggere quell’ “un’amore”