
Pubblichiamo un articolo uscito su Linus, che ringraziamo.
Nell’Italia del primo dopoguerra, nella penombra magica del centro storico di Roma, un ragazzino vive strani giorni.
Di mattina è uno scolaro devoto, religiosamente attento alla dottrina del Padri Scolopi, somministratagli nelle grandi aule nel palazzo cinquecentesco del Nazareno. Tra messe mattutine, quadri pieni di floride madonne e diavoli fascinosi, si abbandona al suo misticismo infantile. Nel pomeriggio, il giovane scolaro esce dalla quiete meditativa del più antico collegio di Roma, per infilarsi in un grande studio fotografico, al civico 197 della vicinissima Via del Tritone. E’ il regno di sua madre, Elda Luxardo, la più importante fotografa italiana dell’epoca. E’ qui che il ragazzino ama rannicchiarsi in silenzio, in un angolo del camerino, e fantasticare. Ogni giorno, inesorabilmente, la sua quiete solitaria viene sconvolta dall’arrivo di donne meravigliose, come Alida Valli e Isa Miranda, Silvana Pampanini e la giovanissima Claudia Cardinale, la Lollo e la Loren.
Maggiorate in culotte e Miss Italia fresche di corona, starlette e dive, scese dal grande schermo per venirsi a spogliare e rivestire a un metro dal suo naso. Riempiendogli le narici dell’odore stordente, dolciastro, del rossetto d’epoca, fragranze delicate di sudore, profumo, cerone, cipria e belletto.
Estasiato, le vede denudarsi frettolose, togliersi vestiti da contadinella per infilarsi in abiti da sera, divinamente indifferenti ai suoi sguardi furtivi, al turbamento di quello che considerano solo un bambino innocuo.
Ma quello scolaretto dagli occhioni gotici, che già somiglia un po’ a Poe, innocente non è quasi per nulla. Si chiama Dario Argento, ed è in quei pomeriggi perturbanti che nascono le ossessioni del suo cinema a venire. A partire dal feticismo del corpo femminile, spiato nell’ombra, nella soggettiva del voyeur, o del maniaco omicida. Passando per il culto del volto di donna, cancellato e ricreato dal trucco, illuminato e rimodellato dalle luci dosate da sua madre, con rituale meticolosità.
E’ la prima direttrice della fotografia che vede all’opera. Ne erediterà la cura estrema, il gioco illuministico che attenua i difetti, ridisegnando espressioni ed emozioni, esaltando volti che Dario non dimenticherà mai. In omaggio al suo bimbo interiore, tornerà a cercarli da adulto, da regista ormai acclamato. Come un detective improvvisato, simile a molti protagonisti dei suoi film, raccoglierà indizi e si spenderà in ricerche ostinate. Alla fine ritroverà le sue amate dive: quasi irriconoscibili, coperte di rughe, cadute in povertà. O addirittura già morte. Con tutta la morbosità del suo amore, riuscirà, a volte, a riportarle nell’alveo della storia del cinema, con un’operazione bissata molti anni più tardi da un altro maniaco cinephile, Quentin Tarantino. Travaserà nel proprio mondo di cineasta quei miti d’infanzia, cucendo ruoli da strega assassina sui corpi di quelle fate invecchiate, ancora piene di espressività. Gli impiastrerà gli occhi di trucco, alla sua maniera, per restituirgli una sinistra bellezza e farle brillare ancora, come demoni, un’ultima volta.
E’ uno dei tratti esoterici della sua poetica: il cinema come evidenza dello scorrere del tempo, traumatica morte al lavoro, che infierisce sui corpi. In un cortocircuito in cui Clara Calamai e Alida Valli vengono strappate al bianco e nero marmoreo dei telefoni bianchi, e trasformate, per sortilegio nel livore cupo degli anni settanta, in sanguinarie streghe ai limiti del punk.
Argento respira e mangia cinema, fin dalla prima infanzia: suo padre Salvatore è un produttore cinematografico, che ne spalleggerà i progetti per tutta la vita. In famiglia è già un alieno, magro come un chiodo, incurvato, accanito coltivatore di fantasie solitarie. Ogni giorno, al riparo da occhi indiscreti, fruga compulsivamente nella sterminata biblioteca domestica, tuffandosi nelle morbosità decadenti del Piacere dannunziano. Le Mille e una notte, saranno invece il viatico per le prime masturbazioni. Divora senza freni anche le copie rovinate dei gialli, reperite clandestinamente, ma l’attrazione più forte resta l’amato Edgar Allan Poe, e il suo mondo di persone sepolte vive, di gatti murati, rivelatori di cadaveri, di denti e cuori di persone amate strappati via dai corpi.
Anche la scuola diventa un set per giocare a spaventarsi. Il Palazzo del Collegio Nazareno è impressionante, pieno di pareti affrescate, statue e ritratti di vescovi e condottieri. E corridoi di marmo, lunghissimi, tetri: “In certi pomeriggi invernali, quando faceva buio presto, rimanevo lì per il doposcuola. Gli Scolopi si ritiravano nei loro appartamenti, e noi ragazzini eravamo liberi di girovagare nei sotterranei bui. Scoprimmo anche una specie di fogna, piena di topi: era molto bello”. Set recuperato anni dopo, per il film Inferno.
Il primo, violento colpo di fulmine con il cinema d’orrore scocca d’estate, in villeggiatura a Monguelfo, sulle Dolomiti. In un’arena all’aperto, a otto anni, assiste a Il fantasma dell’Opera, di Arthur Lubin. Rapito dal technicolor aggressivo e dalla sofferenza psichica del protagonista, un grande Claude Rains, violinista fantasma, con il volto sfigurato coperto da una maschera. Il piccolo Argento finisce per identificarsi con la malinconia del mostro, alle prese con un amore impossibile. Mezzo secolo dopo ne farà una sua versione, con sua figlia Asia e Julian Sands protagonisti.
Dario ama precocemente la sala cinematografica, col solito feticismo, in ogni suo dettaglio: dalle tende rosse e pesanti da attraversare, ingresso difficoltoso in un mondo onirico, in quella penombra azzurrata di fumo, con le narici che si intasano dell’odore di dolciastro, di sigarette e polvere, tra il chiacchericcio troncato di botto dall’apparizione dei titoli di testa. Trangugia entusiasta le verità del neorealismo e lo sfavillante cinema di genere americano, d’avventura e poliziesco. Senza disdegnare i capolavori disneyani: come Woody Allen, è più eccitato dall’aria da mistress della Regina cattiva, che dalla gatta morta Biancaneve.
I suoi occhi avidi si posano anche sulla realtà sulle suggestioni inquietanti degli spazi urbani. In viaggio con papà, in una piovosa notte d’inverno, s’innamora di Torino: “Portici, lastroni bagnati, luci gialle dei lampioni che riflettevano sull’acqua e rendevano le strade simili a serpenti luccicanti”. In quell’austerità piena di mistero, tra quelle case Art Déco, nei cortili, nelle palazzine Liberty, avvolti di luce livida e spleen carico di mistero, configura il set ideale, del cinema che comincia a fermentargli dentro. A Roma, a colpirlo è l’EUR, quartiere fantasma, emblema dello strutturalismo metafisico dell’architettura fascista, sospesa tra razionalismo e megalomania. Si avventura tra i marmi, gli obelischi e il Colosseo quadrato, e da una grande chiesa abbandonata sente frusciar via un enorme stormo di colombi bianchi. Qui da adulto girerà Tenebre, omaggiando anche l’inquietudine metafisica de L’Eclisse di Antonioni.
Il liceo finisce per stargli stretto: litiga con un professore e fugge a Parigi. Tuffandosi nella Bohème respira nell’aria il presagio di una Nouvelle Vague imminente. Si consuma gli occhi nella Cinémathèque française, tornando a Roma più febbrile di prima. Diciassettenne, nell’ultimo scorcio degli anni cinquanta, trova posto nella redazione del quotidiano L’araldo dello spettacolo, come tuttofare. Scrive di cinema, teatro e musica, firmando articoli anche per un periodico, Il giornale dello spettacolo.
All’inizio degli anni sessanta approda al prestigioso Paese Sera : ci lavorerà per buona parte degli anni sessanta. Il primo impatto è scioccante: la redazione affollata, in cui tutti urlano freneticamente, picchiando selvaggiamente i tasti delle Olivetti, gli sembra un inferno. Lo omaggerà ne Il gatto a nove code.
Il suo eccessivo entusiasmo per western e thriller stride però con la linea editoriale. Per il gotha di Paese sera, John Ford è un fascistone impresentabile e Hitchcock è fatuo divertimento, come larga parte del cinema americano. Il giovane Argento asseconda ostinatamente la sua eresia, trovando frammenti da salvare anche nei film esecrati ideologicamente dall’intera redazione. Il cinema è sempre più un desiderio ossessivo: prima comincia a scrivere soggetti, poi libera finalmente il regista che gli palpita sotto pelle. In combutta con suo padre, fonda la società di produzione SEDA (Salvatore e Dario Argento).
Il film d’esordio è L’uccello dalle piume di cristallo, uscito nel 1970. Prima delle riprese Dario disegna l’intero storyboard, includendo ogni singola inquadratura e tutti i movimenti di macchina. Sintomo di quanto abbia le idee chiare, sulla rivoluzione linguistica che sta per mettere in atto. Come ha rilevato Leopoldo Santovincenzo nel saggio Paura in città. Topografia del cinema di genere, offrendo dell’opera argentiana una delle letture più originali ed esaustive, Argento, trasfigurandola nel thriller, ha saputo catturare la violenta mutazione subita dallo scenario urbano.
Fino agli anni cinquanta, nel cinema italiano popolare, la città è un teatro perfetto per le commedie corali, avvolto da un’aria accogliente, familiare. L’azione del film si svolge in luoghi d’aggregazione riconoscibili, piazze, bar e trattorie attraversati con padronanza da protagonisti rassicuranti, ancora saldamente ancorati alla famiglia, ed ai valori tradizionali, fondamentalmente onesti e di buon cuore. Alla peggio, cialtroni in via di redenzione. Ma l’irruzione delle grandi speculazioni edilizie ha ormai prodotto incontrollabili metastasi di cemento, prive di qualsiasi disciplina urbanistica. Lo scenario urbano è diventato un luogo dai confini mutevoli, dalle forme irrazionali. Un perfetto set da thriller, come intuisce Dario Argento: eludendo lo scetticismo dei distributori, convinti che l’Italia non sia credibile come luogo ansiogeno, sceglie la sua Roma, come primo set. Accentuando in chiave orrorifica lo smarrimento della figura umana, tra architetture vuote, di Antonioni, Argento dipinge una città che appare sospesa, fuori dal tempo.
Nel suo realismo sognatone ridisegna le planimetrie, con tagli e controcampi arbitrari, trasformandola in un cupo luogo dell’inconscio. Uno spazio quasi neutro, pieno di insicurezza e paura, dove il tempo è ormai pura frenesia, nevrosi scandita dal traffico dissonante, in un luogo diventato insensatamente troppo grande, per essere percorso a piedi. In cui, al caos distorto, si alterna improvvisa l’inquietudine del vuoto. Ed è fatale sentirsi nella condizione alienata del perenne straniero.
In questo labirinto perturbante, Argento colloca il suo primo protagonista: Sam Dalmas, scrittore americano in visita a Roma, interpretato dalla fisicità nervosa di Tony Musante. Durante una passeggiata serale, nota all’interno di una galleria d’arte una colluttazione tra un uomo vestito di nero e una ragazza. Cerca di intervenire, ma l’aggressore lo rinchiude all’interno dell’intercapedine dell’ingresso, costituita da due vetrate. Dalmas, isolato dietro quella lastra vitrea, rettangolare come uno schermo cinematografico, si ritrova costretto a guardare la ragazza sanguinante, che striscia sul pavimento. Congelato nel ruolo di voyeur, esattamente come lo spettatore, è impossibilitato ad intervenire, ad entrare in quella galleria obitoriale, investita dal bianco abbagliante dei neon, piena di sinistre opere d’arte. La fotografia del quasi esordiente Vittorio Storaro si fonde perfettamente agli stridii di un Morricone atonale, accordato su Stockhausen.
Liberato dalla polizia, lo scrittore comincia la sua indagine, ossessionato da un particolare decisivo a cui ha assistito, ma che non riesce a mettere a fuoco. La sequenza dell’aggressione, in forma di flashback confuso, punteggerà l’intero film: un incubo ricorrente rallentato, zoomato, eppure sempre difficile da decifrare. E’ come se lo stesso atto del vedere fosse messo in discussione: un altro sintomo della propria epoca che Argento, con tutta la violenza che il genere consente, mostra alle folle oceaniche, che tributeranno il successo del film. La realtà sta cambiando e, nonostante l’avanzare dei supporti tecnologici, è sempre più difficile da leggere. Lo spazio in cui ci si muove appare sempre meno come un universo univoco, regolato da segni con un significato condiviso. Ogni percezione è frammentata: la somma dei singoli pezzi stenta a ricomporsi in una verità assoluta.
Argento gioca con lo smarrimento del suo protagonista, per spiazzare lo spettatore, minando la grammatica del genere, la piatta credibilità naturalistica. Mantiene un’inquietudine costante, creando un’alternanza calibrata, del tutto inedita, di vere e false soggettive, elidendo i raccordi, esibendo lo scarto tra il tempo reale e quello cinematografico.
“Mi divertiva troppo l’idea che il pubblico si indentificasse con il cattivo, ma erano soggettive senza un soggetto, come se a guardare fosse l’occhio di un essere superiore che osserva con distacco le miserie di noi umani”.
Gli interni degli appartamenti hanno forme incongrue, trombe delle scale e corridoi assumono un’espressività iperbolica, espressiva: alla fine di un viaggio all’interno di una città deformata dalla sua angoscia, Dalmas si ritrova, circolarmente, di fronte alla galleria d’arte in cui tutto è cominciato. Ma questa volta riesce ad attraversare lo schermo e affrontare l’immagine che lo tormenta. Comprendendola, finalmente. “I miei film nascono per essere visti, non per essere letti. Nascono per immagini e non per concatenazioni di storie. Nascono per essere verosimili, ma non realistici, con un cammino che prende il via dal razionale per giungere all’iperrazionale e quindi approdare all’irrazionale e, come ultima spiaggia, al delirio. Non sono quindi dei veri e propri gialli, a degli studi un po’ matematici sui tempi narrativi e sulla tensione. Trovo il thirilling uno dei modi più sfrenati di fare cinema, uno dei generi che permettono all’autore di far volare in sala sulla testa degli spettatori, per molti minuti, grandi vele di irrazionale e di delirio. Contribuisce a far vacillare solide convinzioni e tranquillità, quieti modi di vivere, banali e false sicurezze”.
Fin dai suoi primi film, percepisce di essere il primo ragazzo del suo tempo in grado di esprimere una forte idea personale, nel cinema di genere. Ha respirato cinema fin dalla nascita, ma si è risparmiato la gavetta greve del set, medaglia al valore di tutti i suoi colleghi della generazione precedente. Viene dalla cinefilia immersiva, dai film assorbiti come unico flusso. Consumare a dosi massicce, nei cineclub, John Ford e l’underground americano, Warhol, Fritz Lang e i b-movies, è servito a crearsi una propria idea di cinema, da esportare nel mondo, cestinando le gerarchie accademiche, e politiche, imposte dalle ideologie imperanti. Uscendo dalle secche provinciali, dalle imitazioni da discount dei modelli americani.
I suoi primi film sono ancora vivissimi, come veri fantasmi. Profondo Rosso, realizzato nel 1975, è forse la sua opera più compiuta, in cui le geometrie narrative di Bernardino Zapponi imbrigliano quanto basta la deriva visionaria argentiana. La Torino scoperta da ragazzo diventa, per il regista, un universo trasfigurato, efficacemente malsano. In cui far convivere il razionalismo metafisico dechirichiano e i nottambuli sotto vetro di Edward Hopper, il liberty e l’Art Déco, imbevendo tutto nella musica ipnotica dei Goblin.
Un’intuizione di Leopoldo Santovincenzo ricolloca brano portante della colonna sonora, ancora molto persistente nell’immaginario attuale, nel clima ansiogeno del tempo, nella violenza che aleggiava nell’aria, permeando la vita quotidiana.
Cominciava con una pulsazione ossessiva e poi, improvvisamente, si trasformava in una selvaggia tempesta in cui faticavi a riconoscere gli strumenti: organi, minimoog, bassi. Poi, di nuovo, si ripartiva daccapo con quel cupo sussurro del basso in attesa che si scatenasse ancora una volta la furia degli elementi. Isolava, sotto la coltre di un’apparente routine quotidiana, una nota funerea, malata seguendo la quale si accedeva a un magma incandescente che ribolliva appena sotto la superficie delle apparenze. Sembrava quasi il suono di quegli anni complicati, in cui non si capiva mai chiaramente da dove arrivava la minaccia: le “sedicenti” Brigate Rosse forse erano fascisti in maschera, gli anarchici bombaroli erano un travestimento dei fascisti, i fascisti venivano impiegati come manovalanza dai servizi segreti, i servizi segreti erano “deviati” da pezzi dello stesso Stato che avrebbe dovuto proteggere tutti.
Con Suspiria, nel 1977, Dario Argento si svincola selvaggiamente dalla trama gialla, salpando verso il soprannaturale. E’ una storia di streghe feroci, annidatesi nel lusso austero di un’accademia di danza di Friburgo.
E’ un cinema quasi puramente visivo, fatto di ritmi vertiginosi e immagini smembrate, da iconoclasta, ormai disancorate dai dialoghi.
I cromatismi vividi del technicolor di Luciano Tovoli evocano la Biancaneve disneyana, trasfigurata in una cruenta opera rock, tra inquadrature e scenografie escheriane. Il quasi metal dei Goblin, composto prima delle riprese, e sparato sul set a tutto volume, getta streghe e ballerine nel giusto, esasperato stato d’animo.
Il film è un susseguirsi senza tregua di assoli di regia, destinato a consacrarlo, per sempre, su scala planetaria, come una rockstar del cinema dell’orrore. Capace di trasformare la connessione tra schermo e platea in un’esperienza sensoriale sempre intensa, generatrice di scene di isteria collettiva nei cinema di tutto il mondo.
Un culto che non accenna a tramontare.
Giuseppe Sansonna (1977) è autore di cortometraggi e documentari, fra cui, oltre al fortunato Zemanlandia, Frammenti di Nairobi (su una bidonville kenyana), A perdifiato (su Michele Lacerenza, il trombettista dei western di Sergio Leone) e Lo sceicco di Castellaneta (sul mito di Rodolfo Valentino).



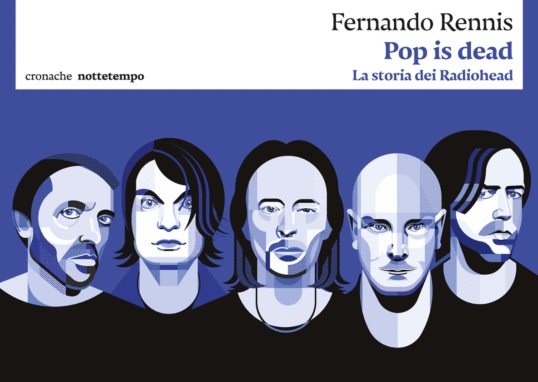



Da evitare.