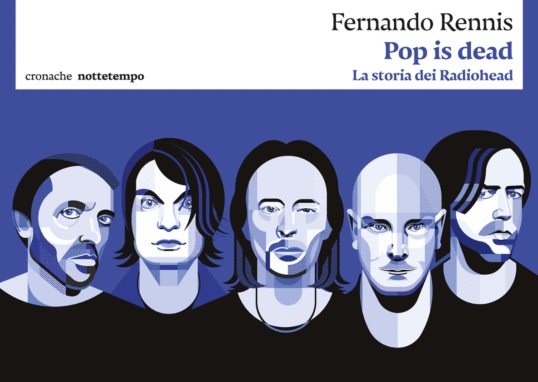Movimenti, cantieri, manifesti. O anche, recentemente: Stati generali. Nel corso degli anni più volte e da vari soggetti è stato espresso il proposito di cambiare il sistema dell’istruzione pubblica dalle sue fondamenta. Nel frattempo, alcune questioni di fondo sono rimaste le stesse, prima fra tutte quella dello spopolamento – l’abbandono scolastico oggi in Italia riguarda il 12,7 per cento degli studenti e, con la rinuncia alle possibilità di istruzione e di formazione, determina un’esclusione sociale in senso ampio dei giovani provenienti dagli ambienti più fragili. La scuola deve cambiare, dunque: è quello che si continua a ripetere. Ma puntualmente ogni volta l’attenzione si concentra assai più su cosa cambiare che su come riuscirci, cioè sul metodo da adottare e sugli interlocutori da chiamare attivamente in causa. Io credo che stia qui, almeno in parte, la ragione del sostanziale fallimento dei tentativi intrapresi finora.
Nell’ottobre 1999 cinquecento insegnanti e genitori riuniti in tre assemblee a Torino, Abbiategrasso e Lodi presentarono il Manifesto per il ritiro della riforma dei cicli e la difesa della scuola pubblica contro la riforma proposta dall’allora ministro Berlinguer e in discussione in Parlamento. Il Manifesto dei 500 (come venne chiamato) prendeva posizione contro i progetti del governo Berlusconi per il ritiro e poi l’abrogazione della riforma Moratti a favore dell’unità della scuola italiana su tutto il territorio nazionale e l’avvio di una discussione sulle conseguenze della legge sull’autonomia scolastica. Nel giugno 2001, poi, insieme ai Coordinamenti insegnanti-genitori di Roma e Firenze, si costituì un Comitato nazionale di collegamento per la difesa della scuola pubblica.
In tempi più recenti l’obiettivo di rifondare la scuola ha preso forma in due testi distinti: il Manifesto per la nuova scuola, con cui nel giugno 2021 un gruppo di docenti, esperti dell’età evolutiva e intellettuali riuniti nel movimento “La nostra scuola” formulò otto proposte per cambiare il sistema dell’istruzione italiana (l’appello venne rivolto anche al Presidente della Repubblica e pubblicato sulla piattaforma Change.org, dove raccolse più di seimila adesioni); e il Manifesto della scuola pubblica, nato da una campagna – il Cantiere scuola – promossa a livello nazionale dall’Unione degli studenti con l’obiettivo di riformare radicalmente la scuola “dal basso” e terminata con gli Stati generali della scuola del febbraio 2022. Ripartiamo da questi due documenti.
I promotori del Manifesto per la nuova scuola volevano un’istituzione nella quale il processo educativo venisse liberato dall’ipertrofia burocratica e tornasse centrale l’ora di lezione disciplinare, con l’eliminazione di ciò che non è apprendimento né insegnamento (per esempio: i pcto, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che hanno sostituito i progetti dell’Alternanza scuola lavoro, da sostituire con stage non obbligatori, decisi dai consigli di classe e da svolgersi al di fuori dell’orario scolastico; i test invalsi; i progetti giudicati non indispensabili – fra quelli invece da mantenere: la mediazione linguistica e culturale per gli studenti stranieri e lo sportello di ascolto psicologico, da potenziare e affidare a professionisti; il rav, rapporto di autovalutazione con cui ogni scuola si analizza per programmare nuovi obiettivi di breve e lungo termine; le programmazioni standardizzate e «tutti quei documenti in cui la descrizione astratta e burocratica dell’insegnamento prende il posto dell’insegnamento stesso, in una continua e paradossale certificazione del nulla»; i ptof, piani triennali dell’offerta formativa, che secondo la legge 107 del 2015 rappresentano l’identità culturale e progettuale di ciascuna scuola in rapporto alle necessità e richieste del territorio e che il Manifesto definiva invece documenti cervellotici che del territorio, appunto, prendono a pretesto le presunte esigenze).
La scuola emergeva in quel testo come luogo della relazione umana e del rapporto intergenerazionale, incentrato sulla conoscenza e sulla trasmissione del sapere oltre che sul rispetto delle esigenze psico-fisiche di crescita degli studenti, anziché sull’acquisizione di competenze – prospettiva, quest’ultima, giudicata profondamente sbagliata in quanto applica alla scuola categorie nate nell’ambito dell’azienda e della produttività lavorativa ed esclude la dimensione integralmente umana, centrale nei processi lunghi e non lineari dell’apprendimento e della crescita.
Il Manifesto ridimensionava il peso dei metodi e degli strumenti di insegnamento legati all’uso delle tecnologie digitali considerandoli semplici mezzi da utilizzare se e quando occorre condividere i contenuti oggetto di apprendimento; sottolineava la necessità di restituire spazio alla libertà di insegnamento, riconoscere pienamente il ruolo degli insegnanti (quali professionisti e intellettuali e non burocrati certificatori chiamati ad applicare passivamente decisioni prese altrove) e coinvolgerli nella riforma della scuola, accennando, senza entrare in ulteriori dettagli, ai temi della loro formazione e del reclutamento; indicava la necessità di ridurre il numero di studenti per classe, per permettere ai docenti di dedicare tempo e attenzione alle esigenze di ognuno di loro, e di rivedere per intero l’impianto dell’autonomia scolastica introdotta al tempo del ministro Berlinguer, «che ha trasformato la scuola pubblica nazionale in una serie di para-aziende in assurda concorrenza tra loro per la conquista della clientela, in inutili progettifici, in centri di potere e di proliferazione burocratica fine a sé stessa, nei quali l’ambigua figura del dirigente-manager subordina quasi inevitabilmente le finalità didattiche ed educative».
Critiche e urgenze analoghe, più recentemente, hanno dato luogo al Manifesto della scuola pubblica dell’Unione degli studenti: una proposta per ricostruire la scuola dalle sue fondamenta coinvolgendo anzitutto la popolazione studentesca e poi altri soggetti. Nelle intenzioni dei suoi autori quel documento doveva aprire un nuovo dibattito sul sistema educativo italiano e stabilire gli obiettivi basilari di una sua riforma radicale, per rispondere a necessità avvertite già da tempo e acuitesi particolarmente con l’introduzione della didattica a distanza a causa della pandemia da Covid-19. Vi si ritrovano, almeno in parte, questioni già presenti nel Manifesto per la nuova scuola: il diritto allo studio e gli investimenti sull’istruzione; l’edilizia scolastica; i pcto; la valutazione; la partecipazione e la rappresentanza; il riordino dei cicli; la salute e il benessere psicologico degli studenti… Anche il tema dell’inclusione viene toccato in punti diversi del documento, laddove si parla di piano di immissione in ruolo dei docenti di sostegno per gli studenti con disabilità, di utilizzo di strumenti acustici e libri con alfabeto braille, di progetti di inclusione e di individualizzazione dell’insegnamento (perché gli studenti hanno esigenze differenti e la didattica deve essere calibrata sul singolo soggetto in formazione), di eliminazione delle barriere architettoniche e di «creazione di un clima inclusivo negli istituti scolastici attraverso una riforma sistemica della scuola pubblica, nonché tramite la costituzione di corsi di aggiornamento per il personale scolastico e momenti di socialità interna».
È a partire da questo Manifesto che nel febbraio 2022 a Roma sono stati convocati gli Stati generali della scuola, promossi dall’Unione degli Studenti (in collaborazione con ActionAid Italia, Rete della Conoscenza, Link-coordinamento universitario, Federazione Lavoratori della Conoscenza-CGIL, Coordinamento Nazionale Precari Scuola, Sbilanciamoci, Arci, Libera, Legambiente, Priorità alla Scuola e altre organizzazioni): un’iniziativa di due giorni voluta per riflettere sul ruolo sociale e politico della scuola pubblica ripensandone il modello attraverso un processo democratico e partecipativo e mettendo radicalmente in discussione la riforma dell’autonomia scolastica e il modello aziendalista cui essa si ispira.
Ebbene: quale incidenza hanno avuto concretamente proposte e azioni come quelle descritte rispetto alle trasformazioni in corso nella scuola, decise attraverso procedure che possiamo definire democratiche ma certo non ampiamente partecipative? E perché pubblicare in tempi non troppo distanti fra loro due Manifesti che appaiono orientati da un’ispirazione quanto meno affine? Esiste un nucleo comune che possa indirizzare l’intervento sulle varie questioni sollevate? E attraverso quale metodo e quali strumenti potrebbe realizzarsi tale intervento?
I due Manifesti, poi, affermavano molte certezze ma non formulavano domande che potessero essere rivolte a tutti i membri della comunità scolastica. Per esempio: la scuola deve formare? Deve essere utile? E a cosa deve servire? Può trasformarsi anche in forza non di piani edilizi ma di un’architettura capace, attraverso gli spazi, di esprimere (e al tempo stesso alimentare) delle idee? (Giacché sembra quanto meno ardimentoso ragionare di strategie didattiche in grado di superare la dominanza della lezione frontale in aule simili a quelle di un secolo fa: cattedra, LIM e file di banchi.) Ancora: chi ha il diritto, oltre che la responsabilità, di provare a trasformare la scuola? Soltanto i ministri e i tecnici, magari anche gli insegnanti, o tutti coloro che nella vita della scuola sono direttamente coinvolti, e quindi anche studenti, personale ata, genitori, educatori, assistenti sociali, psicologi, neuropsichiatri…?
Tenendo conto dei precedenti e degli esiti, credo che occorra non solo una proposta costruita intorno a contenuti condivisi, ma prima ancora un metodo capace di definire ed elaborare i contenuti e portare a risultati non effimeri a partire da una discussione quanto più ampia possibile.
Se è vero, come per esempio si afferma nel Manifesto della scuola pubblica, che è necessaria una riforma di sistema, c’è bisogno di qualcosa di più dei corsi di aggiornamento e dei momenti di socialità interna citati in quel medesimo Manifesto. Credo che sia necessario piuttosto un ripensamento profondo di ciò che oggi riteniamo che la scuola debba essere, ben più solido degli interventi mirati a tamponare le falle a furia di slogan su formazione degli insegnanti, autonomia scolastica, peso della burocrazia che toglie tempo al lavoro effettivo nelle classi e così via. Ma per un ripensamento del genere, per le scelte che comporta e le azioni che richiede occorrono tempo e partecipazione, come accadde per esempio fra il 2015 e il 2016 con gli Stati generali dell’esecuzione penale. SI trattava di carcere, non di scuola, ma è la scelta metodologica – del tutto inedita – allora compiuta ciò che qui mi preme richiamare.
Gli Stati generali dell’esecuzione penale furono convocati dall’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando per ridisegnare il sistema penitenziario in tutti i suoi aspetti. Nel corso di un anno di lavoro vennero coinvolti oltre duecento fra avvocati, docenti, architetti, psicologi, magistrati, volontari suddivisi in diciotto tavoli tematici; vennero svolti visite negli istituti, incontri con detenuti e operatori, audizioni di gruppi di esperti. L’obiettivo, necessario e ambizioso, era riformare la riforma (quella legge del 26 luglio 1975 che non ha mai pienamente attuato i principi costituzionali) e rendere effettiva una funzione che il carcere, nel suo complesso, non riesce ad adempiere.
Il metodo adottato nel 2015 nacque dalla scelta di non solo esaminare e discutere approfonditamente dello stato delle carceri italiane, ma anche promuovere un’ampia mobilitazione culturale in ogni fase del lavoro, dall’analisi dell’esistente alla progettazione di nuove soluzioni per i problemi dibattuti. Mobilitazione senza la quale nessuna riforma ha una seria speranza di essere effettivamente compiuta e poi resistere nel tempo.
Gli Stati generali dell’esecuzione penale si svolsero nell’arco di un anno a partire dalla costituzione di un comitato di esperti (otto membri e un coordinatore) incaricati di predisporre le linee di azione. Furono individuate le questioni più rilevanti della realtà dell’esecuzione penale in Italia e vennero quindi costituiti altrettanti Tavoli di lavoro: gli spazi della pena; la vita detentiva; la presenza delle donne; i minorenni; gli affetti (e la territorializzazione della pena); i detenuti stranieri; il lavoro e la formazione; istruzione, cultura e sport; la salute e il disagio psichico; le misure di sicurezza; le sanzioni di comunità; la giustizia riparativa, la mediazione e la tutela delle vittime di reato; le regole internazionali; gli operatori penitenziari; gli ostacoli normativi all’individualizzazione del trattamento rieducativo; il processo di reinserimento e la presa in carico territoriale. Intorno a ciascun Tavolo si raccolsero interlocutori di varia provenienza in grado, per le loro competenze ed esperienze, di esprimere punti di vista, riflessioni, critiche, proposte. Per ogni Tavolo fu raccolta la documentazione relativa al tema generale e vennero quindi definiti gli specifici problemi su cui intervenire e gli obiettivi da perseguire. Si svolsero audizioni di partecipanti esterni e visite a penitenziari nazionali e stranieri, si somministrarono questionari, ogni Tavolo elaborò una relazione conclusiva e formulò proposte poi divenute oggetto di un dibattito pubblico aperto a soggetti istituzionali, associazioni, figure professionali, portatori di interesse. Da allora sono passati alcuni anni, e cosa resta di quell’ampio lavoro? Non molto, in realtà. L’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario ebbe da fare i conti con le elezioni politiche del 2018, e furono conti salati – si sa che il carcere non figura tra i temi da cui si possa ricavare grande profitto elettorale e rischia anzi di trasformarsi in un boomerang in uno Stato nel quale molti ripristinerebbero la pena di morte.
Al di là degli esiti, tuttavia, gli Stati generali dell’esecuzione penale hanno inaugurato un metodo di lavoro basato sul confronto e sulla collaborazione tra professionalità e competenze diverse ma complementari, fra culture, esperienze e linguaggi che hanno dato luogo a una rete non evanescente. Hanno sostituito la contrapposizione (spesso preventiva, “ideologica”) con una discussione mirata alla formulazione di proposte ben precise e rese più solide dalla pluralità degli interlocutori e dei punti di vista. Hanno permesso di raccogliere una quantità di materiali – indagini conoscitive condotte in Italia e all’estero, riflessioni critiche, proposte normative, indicazione di “buone prassi” e di sperimentati modelli organizzativi – che resteranno a disposizione di chi, al di là dell’esperienza del 2015-2016, voglia continuare a riflettere e a lavorare sui temi allora dibattuti. Non sono stati, insomma, un esercizio di democrazia partecipata fine a sé stesso.
Può quel metodo essere utilizzato anche per la scuola? Io credo di sì, perché in questione non è soltanto cosa debba cambiare, dunque il prodotto finale, ma prima di tutto il processo che a quel prodotto porterà. Oppure no.
Giada Ceri (Firenze, 1972) ha lavorato presso case editrici, riviste (“Exibart” e “Testimonianze”), organizzazioni del Terzo settore impegnate nell’ambito penitenziario. Ha insegnato la lingua italiana a persone straniere (soprattutto migranti e immigrate). Dal 2020 lavora come docente di materie letterarie nella scuola secondaria di primo grado. Ha pubblicato “L’uno. O l’altro” (Giano Editore, 2003), “Il fascino delle cause perse” (Italic Pequod, 2009), “Gli imperatori. Sei volti del potere” (Melville Edizioni, 2016), “La giusta quantità di dolore” (Exòrma Edizioni, 2018). Nel 2014, per la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, ha curato il Quaderno «È una bella prigione, il mondo» sui temi del carcere italiano contemporaneo. Ha scritto per volerelaluna.it e attualmente collabora, oltre che con minima&moralia, con la rivista «Una Città» e il blog «Il primo amore».