
«Questo non è un appello al ritorno in massa alla disciplina ma all’attenzione. Non alla fine di ogni spensieratezza ma di ogni negligenza. Che altro modo mi resta per ricordarvi che la salute è in ogni gesto? Che tutto è nell’infinitesimale». È il 27 marzo 2020 e su Lundimatin, rivista on line francese d’informazione, analisi politica, filosofica e sociologica, viene pubblicato un immaginario monologo, tradotto in tredici lingue, in cui è il virus SARS-CoV-2, responsabile dell’epidemia di covid 19, a prendere la parola e ammonire governi e governati, sane e malati.
In piena emergenza pandemica, qualche giorno dopo, la scrittrice e premio Nobel Annie Ernaux indirizza al Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron una lettera aperta. «In piena facoltà, egregio Presidente, le scrivo la presente che spero leggerà» è l’incipit scelto. «A lei che è un appassionato di letteratura, – prosegue Ernaux – una simile introduzione evoca certamente qualcosa. È l’inizio della canzone di Boris Vian, “Il disertore”, scritta nel 1954, tra la guerra di Indocina e quella d’Algeria. Oggi, benché lei lo proclami, noi non siamo in guerra, qui il nemico non è umano, non è un nostro simile, non ha pensiero né volontà di nuocere, ignora le frontiere e le differenze sociali, si riproduce alla cieca saltando da un individuo a un altro. Le armi, visto che lei tiene a questo lessico guerresco, sono i letti d’ospedale, i respiratori, le mascherine e i test, è il numero dei medici, degli scienziati, dei sanitari […]».
Dopo un quinquennio, è lecito chiedersi cosa rimane di tutte queste riflessioni. Quale eredità ha lasciato l’esperienza globale del covid 19, oltre a un ridefinito e doloroso rapporto con la morte, a inedite definizioni di paura e fragilità, oltre alla fatica e alla manifesta incapacità di trovare parole nuove e diverse in un orizzonte mentale capace di concepire soltanto la guerra come metafora possibile di ogni crisi? Cosa resta, in definitiva, oltre agli adesivi sbiaditi piazzati ovunque per organizzare il distanziamento sociale e qualche reparto di terapia intensiva forse potenziato, di questa prova collettiva e individuale, politica e personale che ha trovato tutti i governi colpevolmente impreparati? Sembra diffusa una percezione “parentetica” della pandemia che invece aveva aperto questioni gigantesche e più generali, avendo imposto un corpo a corpo con il collasso di alcuni diritti fondamentali, con le epifaniche e amarissime disuguaglianze di quella che era per tutti la stessa “tempesta” ma non la stessa “barca”. Rimozione e oblio sono evidentemente tentazioni potenti e già sperimentate nel caso della ‘spagnola’ d’inizio Novecento, nascosta a lungo nelle pieghe dei manuali di storia. E dunque, domanda tra le domande, la storia può essere d’aiuto?
La palladiana basilica del Santissimo Redentore, sull’isola della Giudecca, uno dei massimi capolavori architettonici del Rinascimento, viene eretta su iniziativa del Senato della Repubblica di Venezia per onorare un voto fatto durante la pestilenza del 1575-77. Nella prima metà del Seicento, superata l’epidemia del 1630-31 (la terribile peste manzoniana), nella città lagunare la protezione divina viene di nuovo invocata e rinsaldata commissionando un nuovo tempio intitolato alla Madonna della Salute, che – esattamente come il santissimo Redentore – è ancora omaggiata da una festività devozionale molto sentita. A vincere il concorso per la costruzione della “Salute” è Baldassarre Longhena, rinomatissimo, designato poi architetto di Stato di Venezia dal 1640 al 1682. Longhena metterà mano anche al monastero benedettino contiguo alla chiesa dell’isola di S. Giorgio maggiore per il quale progetta una scala monumentale e una biblioteca, iniziata nel 1654 e terminata nel 1671. Proprio tra le originali librerie in legno di quella biblioteca, intagliate dal tedesco Franz Pauc, è in corso (fino al 19 dicembre prossimo) la mostra – “Venezia e le epidemie” – che offre una lettura del rapporto secolare tra la Serenissima e le emergenze sanitarie, e traccia un paradigma di gestione delle crisi epidemiche che si rivela sorprendentemente attuale. L’esposizione curata dallo storico Egidio Ivetic riunisce materiali di notevole valore – originali di decreti e bandi, disposizioni di quarantena, terapie mediche, progetti di architettura pubblica – provenienti dalle collezioni della Fondazione Giorgio Cini, che sull’isola di san Giorgio ha la sua stupefacente sede, e da altre importanti istituzioni veneziane: l’Archivio di Stato, la Biblioteca Nazionale Marciana e la Fondazione Musei Civici. Il percorso include una video-installazione interattiva che valorizza gli archivi della Fondazione e il progetto “Venice Long Data” (Fondazione Cini – Università Ca’ Foscari), che analizza documenti storici attraverso Big Data e reti. La mostra è una delle iniziative di un percorso più ampio della Fondazione Cini dedicato al rapporto tra “Democrazia e pandemie”.
“Venezia e le epidemie” traccia il ritratto di una città-Stato che, di fronte a ripetute emergenze sanitarie, riesce a convertire la fragilità in forza progettuale e ideare contromisure che non si limitavano certo alla preghiera e alla devozione. L’approccio veneziano è una sintesi inedita di realismo politico-amministrativo, creatività organizzativa (strutture di isolamento, periodi di osservazione, documentazioni certificate) e rielaborazione culturale e sociale di una drammatica esperienza collettiva. In definitiva, è l’idea assai concreta che la salute può essere intesa solo come bene comune e diritto universale e che come tale necessita di un’azione integrata, rigorosa e partecipata dell’intera comunità.
Venezia, tesa tra oriente e occidente , è un caso interessante perché si trova ad affrontare – e governare – una contraddizione interna gigantesca: la sua ricchezza si fonda esattamente su quella circolazione di beni e persone che rappresenta il canale principale della diffusione patogena. La peculiarità di Venezia sono le fitte reti di rapporti, i confini estesi e porosi che la rendono, però, straordinariamente esposta alla minaccia epidemica. Così nel 1423 viene istituita la prima struttura di isolamento permanente al mondo sull’isola di Santa Maria di Nazareth, da cui l’origine del termine “lazzaretto”. Segue nel 1468 la costruzione del Lazzaretto Nuovo, riservato all’osservazione e al recupero, simbolo della prospettiva di guarigione. Venezia formalizza e rende operativa la prassi della quarantena, inizialmente sviluppata a Ragusa. Nel 1486 l’istituzione stabile della magistratura dei Provveditori alla Sanità, segna una trasformazione fondamentale. Venezia concepisce dispositivi che tuttora rappresentano (o dovrebbero rappresentare) la struttura portante della sanità collettiva mondiale: prima di tutto il monitoraggio epidemiologico. Introduce la separazione obbligatoria, la sanificazione metodica, il periodo di osservazione sanitaria e le Fedi di Sanità – autentici “lasciapassare sanitari” che certificano le condizioni di salute del titolare e la provenienza da zone sicure. Michele Primi, ad esempio, ne ottiene una – visibile in una teca – il 26 gennaio 1630 e può circolare liberamente nel territorio della Repubblica. Alcune Fedi di Sanità esposte nella biblioteca del Longhena sono moduli inseriti nei dispacci dei podestà (come nel caso di Chioggia del 1747) o autentiche autocertificazioni in grado di liberare l’ingresso di persone e merci. La mostra è, insomma, un catalogo di strategie e schemi operativi.
Particolarmente rilevante emerge la dimensione informativa dell’intervento sanitario veneziano. La Repubblica intuisce che per arginare l’epidemia è necessario governare l’immaginario sociale: da una parte la distribuzione sistematica di informazioni operative attraverso editti stampati, dall’altra la creazione di narrazioni simboliche esemplari, culminate, ad esempio, nell’elevazione di San Rocco a modello del cittadino cosciente che si confina volontariamente per il bene collettivo.
Un elemento centrale risiede nella capacità di Venezia di assorbire il trauma delle epidemie trasformandolo in carattere identitario. L’edificazione del Redentore e della Salute non è soltanto l’impegno di un voto, ma traduce in forma monumentale la facoltà della città di rinascere dopo ogni disastro, convertendo la memoria della sofferenza in elemento di unità civica.
C’è una contemporaneità concettuale nel metodo veneziano: la comprensione della relazione reciproca tra salute ed economia, il valore della governance coordinata, l’esigenza di un’intelligence sanitaria sovranazionale.
L’esperienza veneziana dimostra come l’eccellenza nel governo delle emergenze sanitarie non scaturisca soltanto da saperi scientifici avanzati – all’epoca certamente fragili – ma dalla facoltà di edificare istituzioni adattive, capaci di trarre insegnamento dalle emergenze e di trasformarsi. Come da titolo del libro esposto e pubblicato nel 1721 da Ludovico Antonio Muratori, ovvero Del governo della peste e delle maniere di guardarsene. È l’approccio coordinato che ci interroga. L’efficienza di un’autorità sanitaria centrale e affidabile, l’esigenza di una comunicazione chiara, il ruolo determinante del consenso sociale e della collaborazione sovranazionale. Resta la domanda decisiva per il presente: cosa implica “sanità collettiva” in tempi di tagli e logiche di mercato?
Alessandra Gissi insegna Storia contemporanea all’Università di Napoli L’Orientale. Si è formata tra la Sapienza, università di Roma, Napoli e Amsterdam. Le sue aree di specializzazione includono la storia italiana ed europea e particolarmente la storia dei corpi riproduttivi e delle politiche demografiche nell’Italia liberale e fascista. Si interessa anche di storia dei femminismi e di storia delle migrazioni. È stata redattrice della rivista della Società italiana delle storiche Genesis e nella direzione della rivista quadrimestrale Italia Contemporanea. Il suo ultimo libro: con Paola Stelliferi, L’aborto. Una storia, (Roma: Carocci, 2023) .

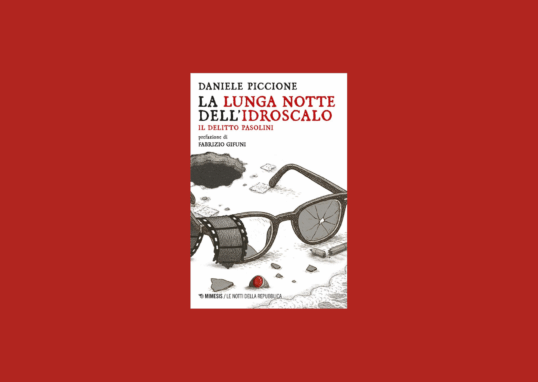
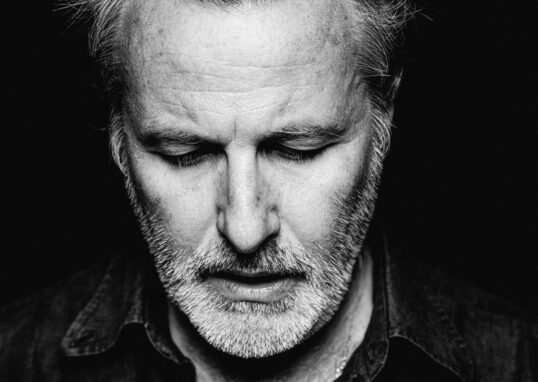


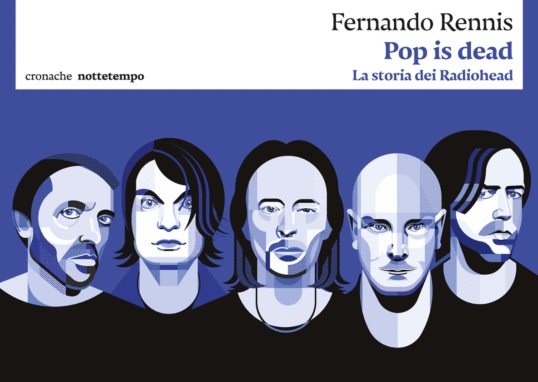

Una riflessione sui (non) effetti del covid, se non “gli adesivi sbiaditi”, e “qualche reparto di terapia intensiva potenziato” – oltre “a inedite definizioni di paure e fragilità”. Ovvero sull’effetto semplificazione, se non rimozione: della pandemia come una parentesi – un’influenza un po’ pestifera, come si voleva agli inizi. Mentre “aveva aperto questioni gigantesche e più generali, avendo imposto un corpo a corpo con il collasso di alcuni diritti fondamentali, con le epifaniche e amarissime disuguaglianze di quella che era per tutti la stessa «tempesta» ma non la stessa «barca»”.
Una riflessione propiziata dalla mostra “Venezia e le epidemie”. Che invece testimonia di una storia, una realtà politica, che si intendeva di epidemie, trafficando per i porti di tutto il Mediterraneo, e sapeva prevenirle e trattarle. Un’esperienza di secoli, che Gissi sintetizza come efficace. Intanto perché anticipa un concetto contemporaneo, “la comprensione della relazione reciproca tra salute ed economia, il valore della governance coordinata, l’esigenza di un’intelligence sanitaria sovranazionale” – che Venezia non trascurava, uno dei suoi tanti plus. Ma, soprattutto, si organizzava di conseguenza: “L’esperienza veneziana dimostra come l’eccellenza nel governo delle emergenze sanitarie non scaturisca soltanto da saperi scientifici avanzati – all’epoca certamente fragili – ma dalla facoltà di edificare istituzioni adattive, capaci di trarre insegnamento dalle emergenze e di trasformarsi”. Il contrario della realtà odierna, da Paese pure “avanzato”, di una “sanità collettiva” che si affronta con “tagli e logiche di mercato”.
Con un interrogativo anche sulla funzione della storia, della storiografia. Che a volte è lì per rimuovere invece che per scoprire – rivelare, spiegare: “Rimozione e oblio sono evidentemente tentazioni potenti e già sperimentate nel caso della ‘spagnola’ d’inizio Novecento, nascosta a lungo nelle pieghe dei manuali di storia”.