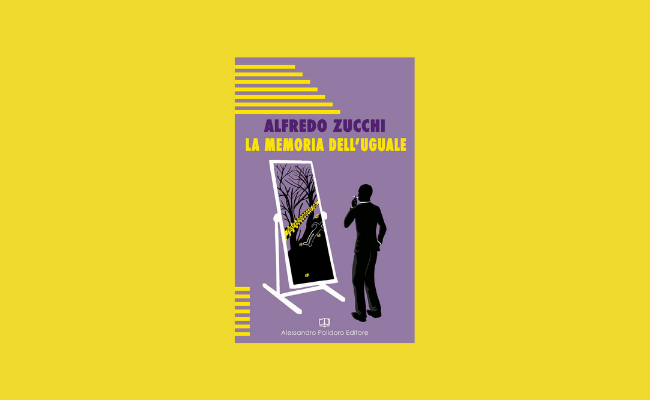
“Solo chi ha un destino
rovina.”
Niente è come sembra – Battiato
La prima volta che ho letto A. Z. era un gennaio di qualche anno fa, in una camera d’albergo in costiera per una vacanza più che meritata. A farmi compagnia c’erano le pagine della Bomba Voyeur, il suo romanzo d’esordio, e avrei voluto tagliarmi la gola per aver infilato quel libro nello zaino. Pochi giorni rovinati dalla prosa che mi si incollava sotto i denti, appiccicava le ciglia e mi impediva di vedere; non fu un caso se dopo una mezza giornata di bel tempo, contemporaneamente all’inizio della lettura, venne giù il diluvio universale. La Bomba fu un’esperienza imprevista e negativa, e questo lo dico per evitare di venir frainteso ora che inizierò a tracciare profili lusinghieri per La memoria dell’uguale. Dico tutto questo anche per sottolineare lo stato d’animo con il quale mi sono avvicinato ai nove racconti, al ciclo del ghetto, alle parole sempre inappuntabili di A. Z., alle recensioni entusiaste. Ecco, mi dicevo, adesso lo leggo, non ci capisco niente, non riesco a farmelo piacere, magari non lo finisco neanche, e mi troverò costretto a mentire. Sia ringraziato il padreterno della Letteratura perché non è stato così. Come posso riprodurre il momento in cui ho iniziato a leggere? Partiamo dall’assunto che A. Z. non si spiega né si capisce, al massimo si intuisce, si percepisce. Un atto di fede, lo stesso che si compie di fronte a Rayuela, alle ombre di Borges, alle capriole di Bolano. Se cito questi nomi, e che nomi, è perché non saprei come farvi vedere diversamente quello che significa leggere La memoria dell’uguale.
Non siete a casa vostra, non più, non siete neppure in Italia, in nessun angolo del mondo civilizzato e quello nelle vostre mani non è un libro, ma al contrario siete stesi, o forse seduti su una roccia dura e nuda, nel bel mezzo di una foresta amazzonica oppure attorno al fuoco in una notte senza stelle nel deserto, in compagnia di un vecchio saggio dagli occhi celesti, la barba nera oppure bianca, le parole che suonano come una canzone primordiale e, anche se non comprendete la lingua questo non importa, vi sembrerà di aver dilatato le pupille per la prima volta. Una storia orale e millenaria che arriva dalla profondità di un sentire comune, da quella memoria di cui A. Z. accenna nel titolo.
La sensazione di ritrovarsi di fronte a un sogno necessario, un viaggio comune dentro le vene più sottili e, nonostante l’astrazione spazio temporale che pervade ogni pagina, l’impressione che gli eventi accadano in nessun luogo e in un nessun tempo, nonostante i gesti assurdi dei personaggi, nonostante l’eccezionalità degli episodi, ho percepito in modo quasi fisico il realismo emotivo delle storie. Storie vere nell’accezione più elevate del termine. Perché se, come scriveva P.P.P., il realismo non è una questione formale, ma ideologica, quello di A.Z. è realismo nella qualità migliore. Il mio sollievo è stato ancora maggiore quando, condotto sui sentieri nascosti dei personaggi, ho ritrovato alcuni riferimenti alla Bomba. È tornata, pensavo, è tornata per assillarmi: e invece poche righe hanno permesso di chiudere alcuni cerchi e aprirne degli altri. Ho visto, saltando da un racconto all’altro, seguendo i personaggi che scompaiono e riappaiono, come il senso si sommasse nel ripetersi di assurdi che dispiegandosi spiegavano ciò che c’era prima e anticipavano quel che sarebbe arrivato subito dopo.
Ed è stata una visione inaspettata soprattutto per la natura di questa raccolta: 9 racconti che a loro volta si suddividono in 6 + 3, a causa della presenza di quella che viene definita la trilogia del ghetto. Potrebbe apparire una frattura in un’opera già frammentata per natura e invece l’effetto è stato quello di un collante biadesivo: storie che procedono dentro altre storie, non anelli di una catena, ma cerchi concentrici come in alcune visioni prospettiche del sistema solare. Pianeta dentro pianeta, completa se stesso e ingloba il prossimo. Arrivare all’ultima pagina è ascoltare la parola finale del racconto con la consapevolezza che l’eco attraverserà la foresta, farà il giro completo del deserto, bagnerà le foglie e spegnerà il fuoco prima di ritornare. Questo è un fatto, che somiglia tanto al capro di uno dei romanzi di Onetti. Il capro che ti spinge a rileggere tutta la storia non appena l’hai conclusa per trovarci qualcos’altro.
Leggendo La memoria dell’uguale ho finalmente visto quel filo, non più invisibile, che lo lega alla letteratura latinoamericana, o meglio albicelesete, a quel modo di intendere le storie. Ma prima di dedicare qualche riga alla ricerca di una similitudine appropriata, vorrei spiegare per bene quello che ho definito essere un effetto per somma di assurdi. Non mi piace andare a definire però ci troviamo tra le mani questo mezzo incompleto che è la parola e facciamocelo bastare. Somma di assurdi. Non assurdo e basta, provo a spiegarmi meglio, perché sono matematico e ci tengo ai dettagli. Per assurdo è una dimostrazione che viene utilizzata per affermare A andando a dimostrare che NON A non può essere vera: se devo dimostrare che due rette sono parallele allora mi metterò nella condizione opposta, le due rette incidenti, e procedendo con la dimostrazione andrò a scontrarmi con qualcosa che non può assolutamente essere vero.
La condizione posta come vera per assurdo, appunto, si dimostrerà assurda. Nel caso matematico è come dire che se allora quelle due rette sono incidenti ne deriva che 1+1=3, ma sappiamo tutti che non può essere vero; quindi le due rette non possono essere incidenti, ma se non sono incidenti allora sono parallele. L’emozione che si prova nella dimostrazione per assurdo è simile a un’esplosione, ma controllata. Come se avessimo accumulato materia di scarto sopra un profilo di bronzo memorabile, accumulato e accumulato, fino al punto di rottura. A un tratto il castello di scarto si sgretola, crolla in un istante, si rompe quando si raggiunge l’assurdo e il profilo di bronzo che non avevamo potuto ammirare da solo, che forse avremmo anche trascurato se apparso fin da subito, ecco che diventa memorabile e bellissimo. E necessario, soprattutto. Per assurdo infatti vengono dimostrati alcuni teoremi essenziali nella loro praticità e semplicità. Così semplici, talmente semplici, da richiedere un processo di logica inversa com’è la dimostrazione per assurdo.
In questa raccolta l’effetto è somma di assurdi dove ogni dimostrazione non si esaurisce in sé, anzi resterebbe in qualche modo monca, come se a un certo punto più di così non si potesse andare, ma per ottenere il risultato fosse necessario sommare un assurdo a un altro assurdo e ancora un altro, poi un altro, un altro, fino alla somma di nove parti che fanno un totale, una somma di assurdi che smettono di essere tali. Lì spunta quell’uguale di cui dovremmo portare memoria. Non è un profilo di bronzo sotto il peso degli scarti, ma un presepe nascosto sotto le ceneri di Pompei e poi arriva una scossa, secca, improvvisa e tutto crolla, tra la polvere spuntano le teste, poi le braccia, poi il sorriso millenario dei pastori. Perdonatemi quest’immagine natalizia, ma siamo pur sempre quel che mangiamo e il mio corpo è composto al momento dal 70% di struffoli.
L’assurdo di cui parlo, però, non è vago, astruso o oscuro, anzi al contrario è emozione pura, nitida e netta dell’essere vivi e nel mondo, in conflitto, certo, con il conflitto che esplode tra le mani. Un senso di responsabilità verso gli eventi, verso i personaggi, così vivi e così reali, da non poter lasciare insensibili al loro destino. Un destino assurdo, ancora mi ritrovo a usare questa parola, nel quale non ci ritroveremo mai, eppure ci pare proprio di essere lì, di fronte a quelle domande impossibili, a quelle scelte mortali. Azioni, fatti, situazioni dalle quali non si può scappare, non è contemplata la fuga, bensì l’accettazione, più o meno allegra, di quanto tocca fare. Sono le azioni il vettore che produce quest’effetto tanto immersivo quanto soddisfacente, al limite dell’ingiustificabile e dell’irrazionale, quasi sconfinate nell’epico: parafrasando Lukacs solo ciò che è convenzionale trova spiegazioni sufficienti nella psicologia e le storie che hanno bisogno di motivazioni hanno già perso di coerenza.
Nei racconti di A. Z. ho sentito i moventi senza bisogno di confessione, la giuria del mio pensiero e del mio cuore ha perdonato ogni misfatto perché tutto è stato compiuto per giusta causa. Dovendo riassumere tutto in pochissime righe direi che il racconto Sul bordo di un evento sia la giusta sintesi: già dal titolo percepiamo l’odore dell’effetto perché siamo sul bordo, al limite, quasi al di là e stiamo immergendo la faccia in un evento, in un fatto, in un’azione. Una sorta di dichiarazione al lettore. Così ho letto quel racconto, posto quasi alla fine del libro, nel punto giusto per darmi quella presunzione d’aver intravisto una pista nel bosco, le tracce della volpe, soddisfazione per il tartufo dei miei bracchi. Pagine piene di riferimenti matematico geometrici, etici, emotivi, in un manifesto poetico dell’intero lavoro che spinge A. Z. ad apparire tra le righe e sussurrare compiacente che c’è un limite alla pienezza prima che diventi saturazione e disgusto.
Una battuta che ho letto come risposta alla mia avversione per la Bomba che trovai così satura da disgustarmi: quello era l’effetto, A. Z.? Maledetto, ci sei riuscito. Ancora, ma questa volta hai anche il mio affetto. Perché ai testi così lavorati non posso non voler, in qualche modo, bene. Dal micro al macro è un salto necessario che in queste pagine si compie senza lasciare straniati, ma come atto fondamentale, perché la geometria dello spazio e del tempo è stata totalmente stravolta. Nulla è affidato al caso anche se il caso fa parte delle storie. Più che raccolta credo d’essere di fronte a una mitologia personale dell’autore, il suo stesso testo sacro. Ho provato stupore e reverenza per essermi ritrovato dinanzi a qualcosa che appartiene a tutti, ma di cui soltanto A. Z. conosce un almeno parziale combinazione.
Che il soggetto/oggetto di tutta la raccolta sia la morte non mi ha sorpreso, perché non c’è niente di più universale, eppure inconoscibile, della morte. Una morte che ha il sapore esotico e scaramantico, necessario e profetico, curioso e macabro, assillante e spaventoso che si respira soltanto in pochi angoli di mondo. Non ho usato per caso l’espressione albiceleste. Nella mia geografia letteraria A. Z. si pone su un altro continente, su quelle latitudini emotive che sono gemelle dell’originaria Partenope, vicine nella lontananza. Sperando di fare cosa gradita infilo l’ultima citazione, vogliate perdonarmi. L’importante in una storia è quel che non si racconta, diceva Piglia in una delle tante valutazioni a posteriori della sua opera. Ecco, allora, all’effetto per somma di assurdi si aggiunge anche quest’ultimo scarto di realtà che rende la lettura de La memoria dell’uguale un’esperienza simile a una scoperta mistica, un’illuminazione, un riconoscimento di ciò che c’è di uguale dentro di noi e di cui, fino all’attimo prima di terminare la lettura, non avevamo neppure sentore.
Non ho la sicurezza di aver capito tutto, ma neanche qualcosa, anzi, però ho percepito, ho intravisto, e questo alle volte basta per dire io credo alla tua storia, racconta, racconta ancora. Perché quel che è più importante in queste pagine è proprio quello che non c’è. Leggendo i racconti de La memoria dell’uguale si ha come l’impressione che A. Z. non scriva, bensì metta insieme delle ossessioni, guidato dalla mano invisibile di uno spirito, dall’effetto del peyote, dalla bramosia di una tazzina colma di caffè, come invasato, posseduto e poi svuotato e abbandonato da solo, incredibilmente solo, di fronte a quanto detto. Ho la netta sensazione di aver scorto A. Z., in qualche angolo del libro, a chiedersi sorpreso: cosa ho fatto? Proprio come un assassino di fronte al corpo caldo della vittima che ancora, inspiegabilmente, respira e pretende l’ultimo colpo mortale.
Francesco Spiedo (1992) nasce a Napoli, da madre ansiosa e padre operaio, sperimentando fin da subito le conseguenze dell’iperattività. Cresciuto a San Giorgio a Cremano, studia per diventare ingegnere anche se non praticherà mai. Precedentemente animatore, cameriere, concierge, addetto alla sicurezza e ad altre attività non riconosciute dal Ministero del Lavoro, inizia a scrivere su commissione e su riviste, sotto falso nome e come ghostwriter. Stiamo abbastanza bene (Fandango Libri, 2020) è il suo primo romanzo. Crede in Maradona e Woody Allen.






