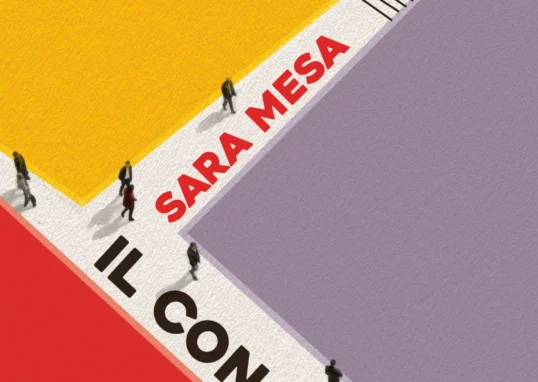Per ricordare il decennale di uno dei capolavori recenti della popular music, “Carrie & Lowell” del cantautore americano Sufjan Stevens, pubblichiamo un’anticipazione dal nuovo libro di Pierluigi Lucadei, Forever Ago. Un quarto di secolo in venticinque album, in uscita per Galaad.
Ci sono molti modi di affrontare il dolore e il lutto in musica. Sufjan Stevens sceglie di non nascondere nulla, di lasciar vedere i suoi lati più ripugnanti, come in un percorso psicoanalitico decide di mostrare la debolezza e le lacrime, l’indicibile voglia di essere abbracciato. È con questo mood che tira fuori il lavoro più apprezzato della sua carriera, eletto da più testate come miglior disco del 2015 e inserito in qualsiasi lista dei migliori dischi del millennio. “Carrie & Lowell” travalica i confini dell’arte, lo dice lo stesso Stevens: «Non è un progetto artistico, è la mia vita».
Non si può comprendere quest’affermazione senza sapere che l’uomo e la donna citati nel titolo sono in realtà la madre e il patrigno di Stevens. Carrie è morta nel 2012, dopo aver abbandonato la famiglia una prima volta quando Sufjan aveva appena undici mesi e dopo una vita segnata dalla malattia mentale e dalle dipendenze. Il padre di Sufjan, Rasjid, era un seguace del gruppo religioso Subud e fu il fondatore del culto a scegliere il nome – di origine araba – di Sufjan al momento della sua nascita nel 1975. Carrie e Rasjid ebbero quattro figli in rapida successione, dei quali il più piccolo era proprio Sufjan, che sono poi cresciuti con il padre e la matrigna, tra culti e spaesamenti vari ed eventuali. Lowell era il secondo marito di Carrie, una figura a suo modo importante con cui Sufjan iniziò a stabilire un rapporto nel 1980, trascorrendo alcune estati nella casa di Eugene dove vivevano Carrie e Lowell. Musicista, libraio e, in generale, personaggio molto intraprendente, Lowell è rimasto sposato con Carrie per soli cinque anni, ma dopo il divorzio ha continuato a mantenere rapporti con i ragazzi, in particolare con Sufjan, al quale aveva trasmesso l’interesse per la musica. Nel 1999 Sufjan e Lowell hanno fondato l’etichetta discografica Ashtmatic Kitty, etichetta che ha pubblicato tutti i dischi di Stevens, oltre a quelli di artisti come Angelo De Augustine, Helado Negro, The Welcome Wagon, DM Stith. Nella lunga intervista concessa a «Pitchfork» nel 2015, Stevens racconta per filo e per segno come sono andate le cose.
«Carrie se n’è andata quando avevo un anno, quindi non ho alcun ricordo del matrimonio tra lei e mio padre. Sentiva di non essere attrezzata per crescerci e ci lasciò a nostro padre. Fu solo quando avevo cinque anni che Carrie sposò Lowell. Lui lavorava in una libreria a Eugene, nell’Oregon, e lì abbiamo trascorso tre estati: sono stati i periodi nei quali abbiamo visto nostra madre di più. Dopo che lei e Lowell si sono lasciati, non abbiamo avuto più molti contatti con Carrie. A volte veniva a casa dei nostri nonni e la vedevamo per qualche giorno durante le vacanze. C’era qualche lettera qua e là. […] Da bambino, ovviamente, ho dovuto costruire una sorta di narrazione, quindi ho sempre avuto uno strano rapporto con la mitologia di Carrie, perché ho così pochi ricordi vissuti della mia esperienza con lei».
Paradossalmente la maggiore vicinanza tra Stevens e sua madre arriva nel 2012, quando Carrie, ormai malata in fase terminale, è in terapia intensiva e riceve la visita dei suoi figli. Nella stessa intervista Stevens descrive la morte di sua madre come un momento «davvero devastante a causa del vuoto che avevo dentro di me. Stavo cercando di raccogliere quanto più potevo di lei, nella mia mente, nella mia memoria, nei miei ricordi, ma mi rendo conto di non avere nulla».
Viene naturale pensare a John Lennon, prima cresciuto da una zia e poi costretto ad affrontare la morte di sua madre, investita da un ubriaco, quando lui aveva appena diciassette anni, e ad alcune sue canzoni, in particolare Mother, che apre l’album “John Lennon/Plastic Ono Band” (1970). Dopo essersi sottoposto per alcuni mesi alla terapia dell’urlo primario con lo psicologo Arthur Janov, Lennon riuscì a guardare in faccia il suo più grande trauma, l’abbandono dei genitori, e a scrivere la sua canzone più disperata. Il riferimento a Lennon è obbligato, anche se Stevens marca una differenza palese in termini di interpretazione. Non c’è alcun urlo alla base della rievocazione del trauma né il bisogno di cantare certe cose gridandole più forte. Non c’è alcuna spettacolarizzazione né la minima traccia di enfasi. Non c’è Phil Spector in cabina di regia. Ci sono invece la voce più flebile, le luci più fioche e le trame musicali più tenui che si possano immaginare. Laddove Lennon grida, Stevens sussurra, con una chitarra o una tastiera, senza batteria, completamente disadorno.
Contrariamente alla consolidata abitudine a fare tutto da sé, Stevens chiede aiuto in fase di produzione a Thomas Bartlett, convinto forse di non poter essere sufficientemente lucido per affrontare canzoni che sono parte della sua carne. Stavolta non c’è bisogno del talento e del gusto per gli arrangiamenti più volte dimostrati da Stevens, per “Carrie & Lowell” serve più che altro creare una distanza tra la materia pulsante e la materia cantabile e su quella distanza, con grande rispetto e profonda empatia, Bartlett lavora dando forma compiuta a un inconscio in ebollizione.
“Carrie & Lowell” è un disco di puro songwriting, una raccolta di canzoni scarne, nude, di pagine intime che spesso rendono l’esperienza dell’ascolto morbosa e imbarazzante. Sembra un disco nato per essere un affare privato che per errore viene reso pubblico. Non si limita a essere personale, ma è intriso della vita dell’autore fino a mostrarne gli aspetti più segreti, nauseanti e indicibili. Stevens fa la cosa più semplice e allo stesso tempo più difficile che un songwriter possa fare: accompagnandosi con la chitarra canta con un filo di voce, che a volte diventa un falsetto, melodie dolcissime e lenitive, senza orpelli, tentando di definire il vuoto, e definendolo comprenderlo, e comprendendolo elaborarlo. I suoi tentativi sono destinati a fallire. Per sua stessa ammissione Stevens scrive queste canzoni per superare il lutto, ma le canzoni gli restituiscono poco in termini di conforto. Da songwriter abituato ad avere un rapporto di reciprocità con la propria arte, a dare e ricevere in egual misura, stavolta si deve scontrare con l’impossibilità di trovare un senso al dolore. «Scrivere e registrare il disco non è stato il sollievo che mi aspettavo», dice.
C’è già molto nel primo brano, Death With Dignity, in cui l’artista inizia ad aprire cassetti di ricordi e visioni, non senza remore e incertezze. I versi con cui partono il brano e l’intero disco esprimono fin troppo chiaramente lo smarrimento di fronte al buio. L’artista non sa da dove iniziare.
Spirit of my silence, I can hear you
But I’m afraid to be near you
And I don’t know where to begin
And I don’t know where to begin
(Death With Dignity)
Non c’è ermetismo, così come non c’è nessun altro tipo di filtro. Le parole di Stevens sono quanto di più inequivocabile si possa trovare in una canzone intimista. Il mettersi a nudo in musica conosce con “Carrie & Lowell” un punto di non ritorno.
I forgive you mother, I can hear you
And I long to be near you
(Death With Dignity)
Musicalmente Death With Dignity è il perfetto lasciapassare per il resto della scaletta. Si tratta di un brano dalle tonalità dimesse, suonato in acustico con una strumentazione ridotta all’osso, senza sezione ritmica, senza diavolerie elettroniche: è la cifra estetica dell’album nella sua interezza.
Stevens non indugia nelle proprie miserie personali e non affronta il suo viaggio nel dolore in modo narrativo. I testi creano una sorta di sogno dentro il quale è presente sicuramente una figura materna ma compaiono anche riferimenti mitologici, elementi di trascendenza e libere associazioni di idee.
Should Have Known Better tiene insieme il tentativo di mettersi in discussione («avrei potuto scrivere una lettera» ma «non mi fido mai dei miei sentimenti»), tristi ricordi d’infanzia («quando avevo tre anni, forse quattro, lei ci abbandonò in quel negozio di video») e inaspettate immagini di gioia («mio fratello ha avuto una figlia / la bellezza che lei porta / illuminazione»).
I should have known better
Nothing can be changed
The past is still the past
The bridge to nowhere
I should have wrote a letter
Explaining what I feel, that empty feeling
(Should Have Known Better)
Non presenta una narrazione lineare nemmeno Eugene, che pure, prendendo il titolo dal posto in cui Carrie e Lowell vivevano, potrebbe illudere di essere un resoconto dettagliato del dolore e invece regala la sensazione di ritrovarsi dentro la testa di Stevens, dove si affollano ricordi indistinti («la luce proveniva dall’albero di limoni»), episodi buffi («l’uomo che mi ha insegnato a nuotare non riusciva a pronunciare il mio nome»), la disperazione di un bambino («volevo solo starti vicino») e i postumi della morte («adesso sono ubriaco e spaventato e spero che il mondo sparisca»). Sembra quasi che l’autore abbia trascritto un monologo emerso sulla chaise longue dello psicoanalista per cantarlo poi con una semplice melodia di sottofondo.
Fourth Of July è la sola traccia a presentare una struttura ordinata, costruita come un dialogo tra la madre sul letto di morte e il figlio arrivato a porgerle l’estremo saluto. Il figlio piange e la madre gli chiede il perché delle lacrime, i due si scambiano nomignoli affettuosi e quando il figlio appare disorientato la madre lo invita a guardare un’ultima volta la luna insieme a lei. La voce sembra sul punto di evaporare ma con uno sforzo eroico conduce verso un’apoteosi sentimentale sempre più rarefatta. Fourth Of July è il momento in cui Stevens si lascia andare a una scrittura narrativa talmente regolare che mi sorprenderei se scoprissi che il dialogo sia realmente avvenuto: il figlio è costretto a inventare il dialogo che avrebbe voluto con la madre almeno in punto di morte e questo venire a patti con l’ennesima estrema mancanza è il suo modo di accettare che i cicli che si aprono nel corso delle nostre vite debbano a un certo punto necessariamente chiudersi.
Da cristiano, Stevens si rivolge alla fede: John My Beloved è il pezzo più spirituale dell’album, pieno di riferimenti mistici, in particolare all’evangelista Giovanni. Su un tappeto di pulsazioni folktroniche si susseguono domande su temi quali pace, riconciliazione, desiderio e preghiere che sembrano recitate un attimo prima di esalare l’ultimo respiro: «Gesù, ho bisogno di te, stammi vicino, vieni a proteggermi». Alla fine del brano c’è effettivamente un sospiro che il cantante lascia intatto, forse a simboleggiare un momento di liberazione. In un album duro come la vita, però, il lieto fine non è previsto. Il conforto che la fede offre in John My Beloved sembra venir meno nei due brani che arrivano subito dopo, il folk essenziale che fotografa i comportamenti autodistruttivi del figlio addolorato, No Shade In The Shadow Of The Cross, e il gospel al ralenti che chiude il disco, Blue Bucket Of Gold, con quell’invocazione, «Dio, toccami con un fulmine», che si offre a più di un’interpretazione biblica. A chiudere il disco è in realtà l’outro strumentale di quest’ultimo brano, un’evanescenza di droni che apre a una dimensione ultraterrena. Un simile outro è in coda ad altri quattro brani di “Carrie & Lowell”, diventando quasi un elemento distintivo del disco, un ricorso a sfumature ambient per offuscare i fantasmi e anestetizzare il dolore, un ricongiungimento tra il regno dei vivi e quello dei morti.
Prima di “Carrie & Lowell” Sufjan Stevens è stato (anche) altro. L’artista megalomane che annunciava l’intenzione di dedicare un album a ciascuno dei cinquanta stati americani, tranne poi fermarsi dopo i primi due, “Michigan” (2003) e “Illinois” (2005), un orchestratore sapiente e fantasioso, lo sperimentatore di “The Age Of Adz” (2010), un modello di etica, di indipendenza e anche di costume. Ma alla luce di “Carrie & Lowell” tutto ciò che è avvenuto prima può essere letto retrospettivamente come una lunga e affascinante preparazione per realizzare questo immenso lavoro di sintesi. Stevens ha sedimentato tutte le proprie esperienze artistiche, le ha combinate con il romanzo della sua famiglia, sgrassato le ridondanze, abbassato le luci della stanza e sublimato il suo fragilissimo canto mescolando il tono fiabesco con l’estatico e lo spirituale. “Carrie & Lowell” è il mirabile risultato del suo sforzo umano e creativo, uno dei punti più alti del cantautorato di ogni tempo, riconosciuto come tale in diretta, nel momento stesso in cui ha preso a girare nelle case di tutti noi.
Pierluigi Lucadei, marchigiano, è nato a San Benedetto del Tronto nel 1976. Giornalista, critico musicale e scrittore, collabora con «Il Mucchio Selvaggio», ilmascalzone.it e «Rivista Undici». Suoi racconti sono apparsi sulle riviste «Cadillac» e «Achab». Ha pubblicato «Ascolti d’autore» (Galaad, 2014) e «Letture d’autore» (Galaad, 2016).