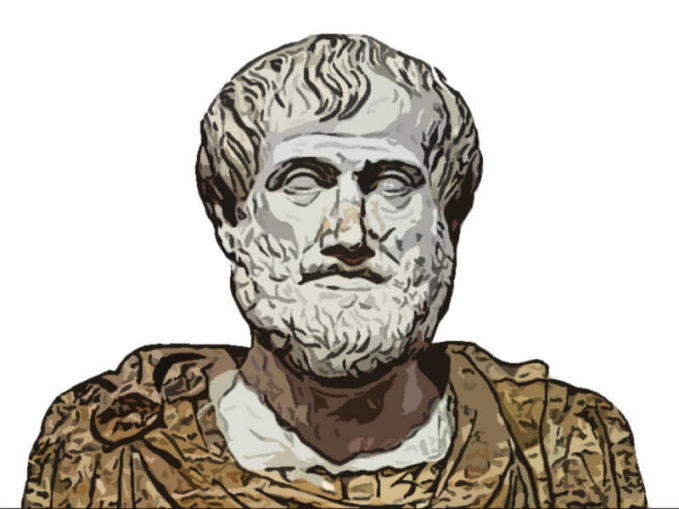
Questo pezzo è uscito su Robinson, l’inserto culturale di Repubblica, che ringraziamo.
ATENE. Basta uscire di poche decine di metri dal traffico di Vassilissis Sofias, alle pendici del Licabetto, su una bella strada chiamata Rigillis. Oltre il cancello aperto da soli due anni, l’improvvisa quiete, fra odori di timo e rosmarino, introduce a una dimensione senza tempo.
Passeggiare è la parola d’ordine. Peripatein dicevano gli antichi. E fu qui, nel 335 a.C. che Aristotele cominciò a spingere i suoi studenti a rendere quel gesto uno stato d’animo capace di diventare simbolo. Cosa accadeva passeggiando attorno al ginnasio di Apollo Licio potremmo dirlo in una parola.
Nella grande scuola che Aristotele qui fondò, chiamata Liceo da Apollo e soprannominata Peripato per via delle lezioni itineranti, fu istituzionalizzato per la prima volta un sistema di studi capace di esaltare ciò che segna la storia del pensiero europeo: il senso critico.
Qualsiasi università, qualsiasi centro di studi organizzati non può che rendere omaggio al filosofo nato 2400 anni fa che in questi luoghi, tornato in città dopo un’assenza durata dodici anni, mise in piedi il primo moderno centro di ricerca a cui la nostra storia si sarebbe ispirata. Innanzitutto una enorme biblioteca pubblica (fatto unico), zeppa degli scritti dei Presocratici e di Platone, di poeti e tragediografi, di testi di medicina, storia, politica, scienze biologiche e fisiche.
Aule dove sedere a leggere, discutere e utilizzare materiali didattici come tavole anatomiche, modelli astronomici, carte geografiche e stellari. Portici e altre aule dove tenere le lezioni che Aristotele e i suoi collaboratori impartirono ispirandosi al principio della competenza e dello specialismo. Tra di essi, Teofrasto, filosofo esperto di botanica; Aristosseno di Taranto, specializzato in musica; Dicearco di Messene, politologo; Clearco di Soli, studioso di anatomia; Eudemo di Rodi, matematico. Studenti scelti per corsi di ogni genere in cui logica, etica e metafisica, non erano considerate superiori a zoologia e anatomofisiologia comparata.
Fra i resti scavati nel 1996 e aperti al pubblico solo due anni fa, si passeggia oggi allontanandosi dalla frenesia del traffico. Studenti dei dintorni appaiono con i libri sotto al braccio provenienti dalla città universitaria che oggi è dislocata qualche chilometro più a sud, sul viale intitolato a Olof Palme, dopo essere risorta sulle ceneri della dominazione ottomana in un bel palazzo sotto all’Acropoli (Tholou 5) eppoi nel celebre edificio neoclassico opera dei fratelli Hansen sul viale Eleftherios Venizelos.
Ma è qui che bisogna tornare oggi. Aristotele vi passò insegnando i tredici anni conclusivi della sua vita di studioso convinto che “il sapiente è in grado di condurre ricerche anche da solo (…) ma lo farà meglio assieme ai suoi collaboratori”. È qui, nel centro dell’Atene dei caffè dove ancora si mette in discussione ogni certezza, che ritroviamo i luoghi in cui venne istituzionalizzato il principio socratico della critica. Mai prendere per buone le verità rivelate, mai inchinarsi ai detti dei luoghi comuni, mai aggiogarsi alle certezze dei padri. Sempre chiedere perché? che cos’è? in che senso? Sempre indagare e discutere. Sempre tenersi pronti a rimettere in discussione le verità a cui siamo giunti per quanto faticosamente.
Forse è per questo che i resti del Liceo di Aristotele, racchiusi fra il Museo Bizantino e il Conservatorio, saranno a partire dall’8 aprile spazio privilegiato per le installazioni della più grande esposizione di Arte Contemporanea d’Europa. Per la prima volta in sessant’anni dOCUMENTA esce dai confini di Kassel e arriva qui, nella patria della democrazia, a interrogarsi sui confini dell’Europa che si sta formando. Motto della mostra: LEARNING FROM ATHENS.
Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha pubblicato con Ponte alle Grazie i romanzi Sono comuni le cose degli amici (2009, finalista al Premio Strega), Il toro non sbaglia mai (2011), È giusto obbedire alla notte (2017, finalista al Premio Strega), e il saggio narrativo L’abisso di Eros (2018). Con Einaudi ha pubblicato traduzione e commento del Simposio di Platone (2009) e i saggi narrativi Le lacrime degli eroi (2013), Achille e Odisseo (2020), Il grido di Pan (2023). Per HarperCollins sono usciti il romanzo Sono difficili le cose belle (2022) e il saggio narrativo Sognava i leoni. L’eroismo fragile di Ernest Hemingway (2024). I suoi racconti sono apparsi in riviste, antologie e ebook (come Mai, Ponte alle Grazie 2014), mentre i reportage di viaggio e le cronache letterarie escono su La Stampa e L’Espresso. Cura un sito di cultura taurina: www.uominietori.it







1 commento