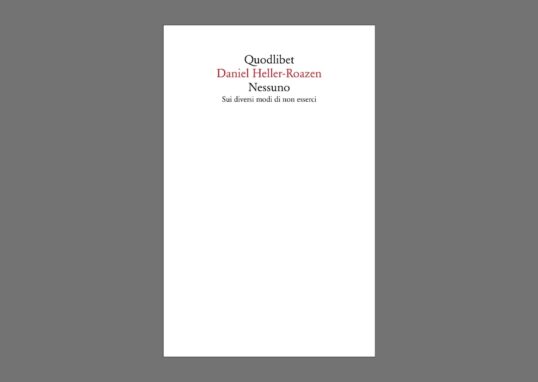testo e foto di Leonardo Merlini
Quante volte mi sono fermato a pensare a Mark Fisher e alla sua poetica dell’hauntologia e dei futuri perduti, alla sua analisi così radicale del realismo capitalista, ossia l’impossibilità anche intellettuale di pensare alternative al sistema economico che governa il mondo e le nostre vite oggi, attraverso il soffocamento della tecnologia e la pervasività della finanza globale. Quante volte mi sono detto che, complice il suicidio di Fisher nel 2017, questo è uno dei grandi incontri mancati della mia vicenda di cronista del contemporaneo. Lui e David Foster Wallace su tutti. Entrambi diventati, per dirla proprio con Fisher, spettri della mia vita.
Poi un giorno mi ritrovo alla Biennale Musica – che ho deciso di seguire perché dedicata quest’anno alla musica elettronica, forse un terreno più vicino, ho provato a convincermi, alla mia sensibilità critica – e in una mattina dopo la pioggia, nella biblioteca del Padiglione Centrale ai Giardini, a un tavolo trovo seduti Simon Reynolds, McKenzie Wark, Steve Goodman, in arte Kode9, insomma chi ha lavorato con Fisher e ne porta avanti lo spirito oltre che la lezione. Accanto a loro Valerio Mattioli, che ha tradotto Realismo capitalista per Nero, l’editore che organizza l’evento veneziano, e ha scritto della rivoluzione della musica elettronica e creata dai computer in un libro – Ex machina – che ho amato moltissimo, anche al di là della mia comprensione dei motivi di questo amore.
Sono colpi di fortuna, mi dico, e penso che sia un po’ come guardare una fotografia della mitica Cybernetic Culture Research Unit (CCRU) dell’Università di Warwick, uno dei primi ambienti culturali in cui a metà Anni Novanta si è cominciato a riflettere sulla nostra contemporaneità con una cambio di prospettiva, che adesso appare illuminante per molti versi. Una fotografia scattata oggi, ma che racconta di un passato che deve ancora succedere. Insomma, a suo modo è la mia hanutologia perfetta. Che prende una forma ancora più chiara quando, qualche ora dopo con le luci della sera già scese sull’Arsenale e tracce di fango chiaro sulle scarpe, incontro Kode9 prima della sua performance in Biennale con Loraine James e parliamo di cosa resta della cultura rave, di filosofia, di possibilità viste oggi, alla luce, per citare un suo stesso lavoro, delle memorie del futuro.
“La cultura rave sta invecchiando, ha già 40 anni, forse di più – mi dice – ed è cambiata molto. Oggi è diventata molto più una forma di spettacolo rispetto a com’era. E ha perso ciò che la distingueva dalla cultura pop mainstream. Però ha ancora la caratteristica di riunire persone che vengono da contesti diversi, con interessi diversi e diverse ideologie: li trasporta all’interno di un collettivo dove le loro convinzioni o preferenze sono irrilevanti. E questa è una cosa che può essere sia negativa sia positiva, ma quello che conta è il fatto che offre un contesto nel quale le persone possono collaborare tra loro comportandosi esattamente all’opposto rispetto a quello modalità molto individualista che il capitalismo tende a generale”.
L’artista scozzese tocca un punto che per me è fondamentale, quello dello stare dentro il sistema e da lì, non altrove, esercitare la propria libertà di critica, dare forma a qualcosa, che sia arte, cultura, musica, scrittura, ma anche semplicemente scelte quotidiane individuali, che vadano in direzione diversa, che aprano, per quanto piccoli o poco rilevanti, possano essere, degli spazi di differenza. Mi viene da pensare a una sorta di rivoluzione silenziosa per molti aspetti legata a doppio filo con il capitalismo, capace, comunque, di mettere in discussione l’intero sistema, seppur probabilmente senza riuscire a scardinarne i principi base del suo “realismo”. Ma questo pensiero alimenta la conversazione e fa in modo, me sembra, di renderla “reale”.
“Le società – prosegue Kode9 – oggi stanno diventando sempre più polarizzate e tutto ciò che genera collettività, vera collettività, nei nostri giorni è qualcosa di piuttosto raro. Quindi questa è forse una lezione che possiamo apprendere dalla cultura rave: essere parte di qualcosa che ci stacca per un secondo dai nostri schermi, che ci allontana dal comportamento consumistico. Lo so, l’industria dei club è parte del sistema capitalismo come qualsiasi altra cosa, ma in questi momenti provvisori, quando si sperimenta una autonomia, per quanto temporanea, continuo a pensare che si aprano dei portali o delle finestre su una società leggermente migliore, dove la priorità è pensarsi come gruppo invece che come esseri singoli e individualisti. Quando le situazioni si fanno molto polarizzate le persone tendono spesso a ritirarsi nei propri gruppi, nella propria identità. Ma quello che la cultura rave offre è un modo per unire le persone incrociando le identità e offre uno spazio condiviso per persone con un background comune, ma anche una possibilità di avere fiducia in coloro che vengono da situazioni diverse. Io credo che questo, nei nostri giorni, sia un aspetto piuttosto prezioso”.
Come preziosa è la variazione di prospettiva che si innesca quando si provano a mischiare le varie suggestioni culturali, le diverse anime, da quelle più razionali a quelle più selvagge, che sono comunque alla base dello “spirito del capitalismo”, le cui energie hanno indiscutibilmente una forza sovversiva, che però il mainstream socio-economico-politico ha nascosto o, meglio, orientato anche in modo violento alla costituzione e alla difesa di un ordine globale. Mi vengono in mente le riflessioni di un altro filosofo radicale come Paul B. Preciado, i suoi tentativi di scardinare il Sistema, il modo in cui con il suo stesso corpo si è fermato – come in quella celebre immagine di piazza Tienanmen nel 1989 – davanti al carro armato della Storia Inevitabile e Unica. Che, per quanto le cose accadano solo una volta e solo in un modo, a posteriori, a priori (grazie Kant, sei ancora qui) non è inevitabile che sia così, non è già scritto, oppure a volte si può provare addirittura a riscriverlo. Non so se questa frase ha senso, ma so che è una frase che ha a che fare con tutto il pensiero di Mark Fisher, con tutto il discorso, nel senso più largo del termine, che i suoi scritti hanno fatto, a me in prima persona come lettore.
Ma sto scappando via, qui, almeno in superficie, stiamo solo parlando di musica, di relazione con la tecnologia, di modi nei quali si può stare e al tempo stesso non stare dentro quello stesso Sistema. Provando, nonostante tutte le riflessioni sulla sua scomparsa, a immaginare un futuro, tra l’elettronica e la nostra vita.
“La musica elettronica – dice ancora Steve Goodman – sta, per definizione, in un terreno culturale che è strettamente legato alla tecnologia, in particolare per apprendere, per non essere sulla difensiva, per collaborare con le nuove tecnologie ed essere capaci di adattarsi al modo in cui esse possono arricchire il nostro ambito culturale. Molte persone hanno una certa paranoia riguardo l’intelligenza artificiale: io credo che ci siano delle cose interessanti nella AI. Gli artisti più significativi oggi stanno imparando a migliorare il proprio lavoro collaborando con le macchine, senza cadere nella logica amico/nemico. Certo, molte persone vedono nell’intelligenza artificiale una minaccia, qualcosa che potrebbe prendere il loro posto sulla scena cultura. Lo capisco, ma continuo a credere che sia paranoico e limitante il non voler trarre vantaggio dalle opportunità artistiche che le nuove tecnologie ci offrono, specialmente quando si tratta di usare la tecnologia in modi diversi da quelli per i quali è stata pensata. In altre parole io credo che si debba capitalizzare gli errori che ci sono nelle tecnologie o le conseguenze non volute del loro utilizzo”.
Ecco, questa sembra essere esattamente una di quelle “fratture” del realismo capitalista che Fisher andava a cercare, e in quello spazio si inserisce anche la, per così dire, postura filosofica della ricerca musicale di Kode9, a cui la Biennale Musica di Lucia Ronchetti ha voluto offrire un palcoscenico istituzionale, sul quale però agire in radicale libertà (e ancora una volta si torna alla dinamica sistema-antisistema, che l’onestà intellettuale ci dice essere inestricabile e, in fondo, inevitabile, almeno fuori dal campo delle ideologie, che è quello in cui cerco sempre di stare). “Per me come musicista – conclude Goodman – essere alla Biennale è qualcosa di fuori contesto rispetto alle situazioni nelle quali di solito mi esibisco. Sono molto felice di vedere un’istituzione come questa che si apre a qualcuno che produce non solo musica dance, ma una musica strana come la mia, lontana dal mainstream della dance. Sono sempre interessato a sfidare le gerarchie che dividono la cultura alta e quella bassa, quindi poter portare la mia musica in un contesto come la Biennale mi fa sperare che queste gerarchie siano fluide e magari più flessibili di come possono talvolta apparire”.
L’intervista è finita, nei cortili dell’Arsenale si è fatto ancora più buio ed è quasi ora che i musicisti vadano in scena. Il futuro, di cui ho già scritto, deve ancora succedere, tutto è ancora possibile. Tutto può essere fluido, diverso. Magari potrebbe essere addirittura “alternativo”, nel senso più letterale e vero della parola. Questo pensiero, alla fine, rasserena.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente