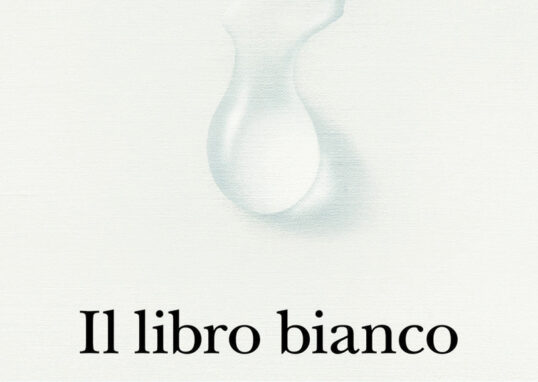“Non c’era un dentro e un fuori. C’erano le parole e c’era il mio corpo, vedevo attraverso la mia stessa pelle. Riversai le mie viscere nella scrittura. Finché diventò un libro. Finché la mia stessa pelle cantò urlando”.
Con La cronologia dell’acqua (trad. Alessandra Castellazzi, nottetempo) Lidia Yuknavitch compone un memoir dalle radici aeree, ancorato al reale nel narrare il dolore come la cosa più importante “capitata sulla pelle fin dall’infanzia” e con una cifra visionaria nel descrivere la condizione agognata del non sentire.
L’opera si apre con i tentativi di elaborare il lutto per sua figlia nata morta, evento descritto nel dramma del parto, nella percezione di lambire la follia e isolarsi dal resto per alimentare la tragedia. I rituali ripetuti all’infinito, come deporre in fila sul tappeto blu scuro i vestitini da neonata o comporre file di sassi, sono esercizi di attesa, monito di un’assenza che annulla il confine tra incubo e veglia.
In cinque atti – Trattenere il respiro, Nel blu, Il bagnato, Resurrezioni, L’altra faccia dell’annegare – l’architettura dell’opera si fonda su ripetizioni e sospensioni. Un elogio del frammento come unica misura possibile per attestare quel che resta di una disgregazione e basarsi su quello scarto non più scomponibile per indagare l’ineluttabilità della perdita.
Tutto ciò che ero, era il mio corpo. Sanguinante, sanguinante.
Il tratteggio lirico di una desolazione privata avanza per contaminazioni, tradisce l’impossibilità di un reale abbandono nell’illusione, si rinnova nella spirale di morte e rinascita su cui si regge l’opera.
Yuknavitch sembra fare propria la versione di Anne Carson a proposito della natura liquida del linguaggio: si sofferma sull’inafferrabilità dell’acqua per compiere un parallelo linguistico e esplorare l’inganno del noto. Si muove tra i reperti di un’infanzia violenta e traumatica per calarsi tra i grovigli di un’esistenza dolente, libera, per lungo tempo subacquea, nell’acqua come nei sogni. Il viaggio onirico è il tempo vuoto dove replicare l’addio.
Ogni tappa è marcata dall’esperienza dell’acqua: la crescita come atleta e i trofei vinti a sette anni, l’agonismo, la piscina come luogo di vergogna, i fallimenti, la doccia speciale dopo il parto, l’immagine del proprio corpo in acque profonde, “senza peso, senza aria. Vuoto senza figlia”.
Il nuoto è vissuto come un mezzo per uscire dalla realtà e annullare il tempo, come sublimazione, come spazio di libertà originata dall’imposizione paterna, come strumento per misurare i propri limiti.
L’odio è il mezzo per rivendicare la propria presenza nel mondo, per attestare la rabbia verso un padre che abusa delle sue figlie e gode del controllo sulla vita altrui, e per riconoscersi nel risentimento verso una madre perennemente altrove, incapace di vedere quel che accade, che puzza di vodka e profumo del giorno prima. Un rancore destinato a durare per tutta la vita e a invadere ogni situazione tragica e paradossale che marca gli esercizi di salvezza accolti sulla pagina. Il male represso esplode in un corpo che invoca altre forme di violenza fisica, la perdita di coscienza, la dipendenza da alcol e droga – “Trenta secondi per passare dall’essere al nulla”– per distruggere la figura paterna, annullare ogni sensazione, ambire alla morte.
Tra andirivieni temporali, fratture, stacchi poetici che illuminano il dramma, l’autrice traccia un’esistenza segnata dai continui esperimenti di reazione alla perdita come la partenza per Lubbokk a diciott’anni per provare un sottile benessere nelle tragedie e nelle storie dell’orrore “intrise di sangue e immoralità” in cui si trova immersa e provare a dimenticare i fallimenti sportivi e famigliari nel far parte dei tossici zombie, con la costante percezione che nulla possa resuscitare l’uomo dentro l’uomo.
Ricordo distintamente di aver pensato: cosa mi resta da perdere? Attraversare la barriera sangue-cervello. Attraversare la barriera mente-corpo. La barriera realtà-sogno. Tutta quell’euforia riempiva il vuoto dentro di me. Nessun dolore. Nessun pensiero. Solo immagini da inseguire.
Il quadro di una tetra educazione sentimentale con l’ombra degli “impostori edipici” segna i primi esperimenti di vita matrimoniale di Lidia nella percezione di far parte di un dramma di Beckett: impronta ogni relazione sulla base della necessità di ripercorrere fisicamente le esperienze all’origine di una deviazione attraverso un “dolore purificante come l’acqua”.
Lo smarrimento, l’estraneità, l’abbandono nell’altro riecheggiano in una narrazione che si nutre di caos per ispezionare la natura del linguaggio e del desiderio. Quello che era nato come un racconto e che grazie alle critiche di Chang-Rae Lee sarebbe diventato un memoir rifugge l’esibizione di un’afflizione, diventa lo spazio per accogliere l’irrequietezza tra percorsi liberi.
La scrittura, lei è il mio fuoco. Le storie nascono dal luogo dove in me sono avvenute la vita e la morte. Mi porta con sé e sarà la mia morte.
Yuknavitch parte dal dato reale per raffinarlo nel delirio, invocare una rottura e accordarsi così al passo di Georges Bataille; di Kathy Acker, “la donna che aveva fatto irruzione nella cultura e nel genere, nella prigione del linguaggio, facendola esplodere dall’interno”; di William Burroughs; di Susan Sontag nell’analizzare le trasformazioni di tono del linguaggio e nell’ispezionare la malattia come lato notturno della vita, “una cittadinanza più gravosa”; di Marguerite Duras, Gertrude Stein e Emily Dickinson, per la scrittura “in grado di spalancare le acque” per persone come lei.
Yuknavitch osserva l’evoluzione di un dolore inestinguibile, rintraccia nella vulnerabilità di un corpo che può generare la vita e la morte un nuovo senso da dare alla distruzione, per tracciare annegamenti e emersioni e interrogarsi sul significato della nascita, sulle possibilità celate nella perdita, sul modo di lasciare una vita per entrare in una nuova.
Che benedizione, ciò che nasce nella solitudine.
Ogni esperienza è vissuta come qualcosa di eccezionale che diventa ordinario, in una personale idea di normalità che concepisce nell’estremismo una forma d’arte. La prosa condensa le visioni assegnando a esse una valenza eterna. L’apparente casualità con cui si affacciano sulla pagina episodi dell’infanzia permette all’autrice di riesumare traumi e riscriverli, come lo schianto con la bicicletta Schwinn rosa fiammante a dieci anni costato la rottura dell’imene, la gita a Mount Rainier con il pretesto di prendere un albero e la devastazione nel volto della sorella dodicenne costretta ad appartarsi nella neve col padre, i giorni di delirio con la mononucleosi e le attenzioni morbose subite, la fiaschetta condivisa con Ken Kesey e la sintonia di corpi rotti che condividono la morte dei figli. Volti e persone che generano a loro volta frammenti caotici di altre storie.
La tensione alla morte è resa per immagini che si dilatano nel tempo in una costante ambivalenza che travalica il racconto di una formazione individuale e dell’elaborazione di un lutto che contamina ogni cosa: si lega a un’idea di rinascita e condiziona ogni relazione, il senso del vivere, il senso dell’amore come “morte viva”.
Ignoravo ancora che il desiderio di morire può essere un canto di sangue che scorre nel corpo.
Sogno e ricordo si mescolano e generano sulla pagina due poli sensibili: la ricerca del desiderio che nell’infanzia e nell’adolescenza trova nel paradiso dello spogliatoio la sola risposta all’annientamento – “un orgasmo di rabbia”–, e l’incredulità nella scoperta di sentimenti nuovi, vicini alla gioia e all’euforia del sentirsi vivi – “Dunque è questa la vita” –, nella rivelazione di una maternità legata al perdono come figlia.
Yuknavitch compie un’indagine sull’identità mossa dalla personale eredità della violenza che trova nella dimensione fisica la traduzione di una rabbia radicata. L’identificazione di parti di sé nell’accademica conosciuta al Dipartimento di Inglese, nella prostituta tossica abbordata di fronte a casa, nel barbone osservato mentre dorme sereno accanto ai suoi escrementi, rivela una concezione del corpo come “metafora carnale dell’esperienza umana”.
Ancora non sapevo che il desiderio va e viene ovunque voglia. Ancora non sapevo che la sessualità è un continente. Ancora non sapevo quante volte può nascere una persona.
L’esplorazione dell’erotismo custodisce una condanna e una necessità di espiazione nell’invocazione di una crudeltà attraverso cui affermare un desiderio inquieto, caotico.
Quello che volevo veramente era farmi spingere sull’orlo dell’io, qualunque esso fosse. Al limite della morte. Forse non letteralmente.
Con La cronologia dell’acqua Lidia Yuknavitch consegna il racconto dolente e luminoso di una fine che si confonde con l’inizio. Una storia di sopravvivenza e di rinascita, di scoperta di sé, di autodistruzione, di necessità di violenza e dolore come forme estreme di voluttà, di ricerca di un abbandono totale per riaccordarsi alla propria innocenza come matrice originaria ignota: il manifesto dell’ambiguità nell’approdo al riscatto estremo da ogni vincolo.
“Non è facile abbandonare un io per accoglierne un altro. La libertà lascia cicatrici. Forse può uccidere. Almeno uno dei nostri io. Ma va bene. Ce ne sono altri. Quante volte moriamo? Le parole, come i sé, valgono la pena”.
Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine letterario The FLR -The Florentine Literary Review.