
(la fotografia è dell’autore)
Per tre anni, nel secolo scorso, ho insegnato alla University of Wisconsin in Madison, una piccola grande città tra due laghi a circa due ore di macchina da Chicago e da Oak Park, dove andavo spesso a trascorrere il weekend. In quel periodo rilessi in inglese i libri di Hemingway che più avevo amato da ragazzo, quelli pubblicati in vita, e I racconti di Nick Adams, pubblicati postumi da Philip Young. Avversati dalla correttezza vigente, li leggevo con circospezione, ma senza sensi di colpa, divorando anche una parte degli studi critici e biografici disponibili nella biblioteca del campus, compresi i libri dei famigliari. Tra questi, il più importante e ricco d’informazioni era quello della sorella maggiore, la più brava a scuola e scrittrice ella stessa. Ma per la sincerità e l’amore con cui era scritto, il più bello mi sembrò quello di un’altra sorella, la meno brava a scuola, l’adolescente ribelle che voleva portare i capelli corti, l’unica ad essere rimasta sempre legata ai luoghi dell’infanzia e della giovinezza.
Era nata a Oak Park nel 1904, quarta dei sei figli di Grace e Clarence Hemingway, dopo Mercelline, Ernest e Ursula, prima di Carol e Leicester. Il suo nome di battesimo era Madelaine, ma molto presto, in famiglia, cominciarono a chiamarla Sunny, per il perenne sorriso radioso che ricordava quello del viso di un bimbo sulla scatola del Sunny Boy Breakfast Cereal. Mentre Sunny divenne il suo primo nome anche per amici e conoscenti, al fratello maggiore, soltanto a lui, piacque sempre chiamarla Nunbones, che non significa niente, ma che per lei era importante, come tutto ciò che lui diceva, pensava, faceva.
Uno dei primi racconti di Hemingway, incluso nella raccolta In Our Time, e uno dei primi ad essere tradotto in italiano, è Soldier’s Home, o Il ritorno del soldato Krebs. Tema del racconto è il disagio esistenziale del reduce. È un racconto che influenzò alcuni importanti scrittori del secondo Novecento italiano, uno di essi da me molto amato. Ma non voglio parlare di questo, del disagio del reduce o della Paga del sabato. Voglio parlare della relazione speciale che, nel racconto, Harold Krebs ha con la sorellina Helen, la sorella preferita, la sola persona in famiglia che lo capisce e ammira incondizionatamente.
Per lei il colmo della gioia sarebbe che lui andasse a vederla giocare a baseball, perché si rendesse conto, e ne fosse orgoglioso, di come, anche nello sport, lei aveva messo a frutto i suoi insegnamenti; per lui andare a vederla giocare nel cortile della scuola è l’unica cosa che lo fa sentir bene: su questa improvvisa nota di speranza si chiude il racconto. Se Harold Kreb, al pari di Nick Adams, è un alter ego dello scrittore, Helen è l’alter ego di Sunny. E anche Littless, l’amata sorellina che accompagna Nick nella fuga a tratti surreale descritta in The last good country (L’ultimo paesaggio vero), frammento di romanzo incluso nelle Nick Adams Stories, è un alter ego di Sunny: la leale compagna d’avventure delle estati trascorse nel cottage di famiglia sul Walloon Lake, l’assidua corrispondente della maturità, il più sicuro collegamento nel non facile rapporto tra lo scrittore affermato e i famigliari.
Avevo già visto da fuori (non visitato perché in quel tempo era ancora una residenza privata) la casa natale al numero 339 di North Oak Park Avenue, oggi, dopo essere stata comprata dalla Ernest Hemingway Foundation di Oak Park, riportata alle sembianze originali e adibita a museo. E avevo visto la casa dove la famiglia si spostò nel 1906, al numero 600 di North Kenilworth Avenue: una grande prairie-style house ispirata allo stile di Frank Lloyd Wright, che a Oak Park abitava e aveva il suo studio, più adatta a crescere spiriti liberi della casa vittoriana fatta costruire dal padre di Grace un quarto di secolo prima. In questa casa Ernest abitò fino ai suoi vent’anni, e non vi tornò più dopo il suicidio del padre avvenuto nel 1928. Entrambe le case si trovano a pochi isolati dalla Oak Park and River Forest High School, anch’essa una meta delle mie passeggiate per il bel villaggio alberato di origini ottocentesche, oggi un elegante quartiere della periferia di Chicago.
Nel suo libro My Brother, Ernest Hemingway, Leicester descrive Oak Park come “il posto dove finiscono i saloon e cominciano le chiese”, una definizione che ancora oggi rende abbastanza bene l’idea del luogo. Lì Ernest era cresciuto ricevendo un’educazione religiosa, e lì scrisse i suoi primi racconti, probabilmente anche Soldier’s home. Ma la religione che lo educò come scrittore era quella abbracciata nei boschi del Nord Michigan, là dove Nick si sentiva “come ci si sente in chiesa” (The last good country): la religione della natura. Era perciò in quei boschi, se ancora esistevano, che volevo camminare prima di lasciare Madison. All’inizio dell’estate del 1990 formulai il mio piano: utilizzando come guida il libro di Sunny e i racconti di suo fratello, avrei esplorato il territorio in cui agisce Nick Adams, e avrei cercato di vedere Windemere, il cottage fatto costruire da Clarence e Grace nel 1899; avrei nuotato nel Walloon Lake, passeggiato per le vie di Petoskey, osservato il tramonto su Little Traverse Bay, dormito con Carmen a Boyne City e fatto colazione a Horton Bay.
Avevo saputo da un collega d’inglese che, da quando era rimasta vedova per la seconda volta, Sunny viveva per la maggior parte dell’anno nel vecchio cottage di famiglia sul lago vicino a Petoskey, ma che era praticamente impossibile avvicinarla. Il suo nome non era sull’elenco telefonico, e il figlio Ernest Mainland, residente a Petoskey, si occupava di proteggere la sua privacy. Lei stessa, del resto, nelle ultime pagine del libro spiegava come fosse rimasta delusa dai molti curiosi a cui aveva aperto la porta del cottage, di come molti di essi avevano poi rivenduto alla stampa informazioni riservate, quasi sempre travisandole o falsificandole. In un caso, un visitatore aveva addirittura registrato di nascosto la sua voce per poi utilizzarla nel corso di una trasmissione radiofonica. Io non ero un giornalista.
Anche se ogni tanto riuscivo a piazzare un articolo su qualche giornale o rivista (articoli che in quel tempo venivano pagati), ero a tutti gli effetti un insegnante d’italiano. Il mio interesse era strettamente privato e personale, non avevo alcuna intenzione di riciclare le informazioni eventualmente raccolte. Se fossi riuscito a parlare con Sunny le avrei detto che ero mosso soltanto da affetto, anzi, da un senso di reciprocità affettiva. Lei, che aveva battuto a macchina il manoscritto di Addio alle armi, il romanzo ‘italiano’ di Ernest, avrebbe certamente capito.
Il territorio dello Stato del Michigan è composto da due penisole: una a sud attaccata all’Indiana e all’Ohio, la parte più popolata, urbanizzata e industrializzata; l’altra a nord attaccata al Wisconsin, la parte rurale, con una popolazione in costante declino da oltre un secolo, in seguito alla crisi e quindi la fine dell’industria mineraria, ma un paradiso per amanti della vita all’aria aperta e per pescatori di trota: ricca di foreste, di piccoli laghi e di fiumi, tra questi il Two Hearted River, il fiume dai due cuori, così chiamato dagli indiani Ojibway per i due rami con cui il fiume nasce prima di riunirsi in un unico corso e sfociare nel Lago Superiore; “grande” non tanto per le sue dimensioni quanto per ciò che rappresenta per Nick. Un lungo ponte sullo stretto di Mackinac, che divide il Lago Huron dal Lago Michigan, collega le due parti.
Poiché all’inizio di agosto ci trovavamo a Eau Claire, nel nord del Wisconsin, dove Carmen avrebbe insegnato in autunno, decidemmo di entrare nel Michigan da Nord, di esplorare le parti più interessanti dell’Upper Peninsula, per poi passare attraverso il Mackinac Bridge alla Lower Peninsula, fermarci qualche giorno a Petoskey con la speranza di riuscire a vedere il cottage sul Walloon Lake, e quindi scendere a Chicago per tornare in Wisconsin, compiendo così il giro completo del Lago Michigan. Eau Claire è il paesino del Midwest da cui proviene la giovane protagonista del racconto Bernice Bobs Her Hair (Berenice si taglia i capelli), il mio preferito di Scott Fitzgerald, e questa coincidenza, per quanto illogicamente, mi sembrava un segnale di buon auspicio per il successo del viaggio.
Partimmo come mi piaceva fare, senza prenotazioni e con un itinerario da decidere giorno per giorno. Viaggiando verso est sulla U.S. Route 8, che ci avrebbe dovuto portare dritto nel Michigan, vidi sulla carta che poco più a nord, alla frontiera tra i due stati, si trovava in riva a un piccolo lago l’altrettanto piccola città di Florence, e decisi di puntare su quella. Scoprimmo più tardi che il paesino si chiamava così non perché fosse stato fondato da emigrati fiorentini o comunque in omaggio alla mia città, ma in onore di Florence Hulst, moglie dell’ingegnere Nelson Hulst, che alla fine dell’Ottocento aveva aperto una miniera di ferro lì vicino, su terreni appartenuti alla tribù degli indiani Menominee.
Di tutto ciò non rimaneva niente, e la popolazione, ora dedita all’industria casearia, era per lo più di origine nordeuropea, come la ragazza del motel in cui dormimmo, e la cameriera del bar affollato di soli uomini che parlavano animatamente di football e di caccia, tutti in jeans e camicia di flanella, in cui cenammo. Rimpiansi di non aver puntato sulla città portuale di Escanaba, come aveva suggerito di fare Carmen, e promisi a me stesso di non cedere più a tali sirene, di rimanere concentrato sul tema.
A Escanaba ci andammo la mattina dopo, ma non ci fermammo, tanto ero ansioso di raggiungere Seney, il centro della penisola e il punto di partenza del cammino di Nick. L’incendio che aveva distrutto i suoi tredici saloon, e forse l’hotel Mansion House, compianti all’inizio del racconto e in una poesia (Along with youth), era stato il colpo di grazia per l’antica capitale dell’industria del legname, la quale, visibilmente, non si era più ripresa. Ma resisteva il nome sulla targa dell’Ufficio Postale, e questo mi bastava. Da lì mi precipitai alla fermata della ferrovia, ora riservata al solo traffico di merci, e al ponte sul Fiume Fox. Osservai a lungo l’acqua chiara e marrone, resa tale dai ciottoli ferrosi del basso fondale, ma non riuscii a vedere una singola trota, neppure nelle zone più in ombra. Forse era ancora troppo presto, pensai, o forse le trote si erano fatte scaltre, avevano imparato a leggere e a scrivere, come diceva un mio amico pescatore, e diffidavano dei turisti.
Da Seney Nick cammina per un numero imprecisato di ore verso nord lungo una strada in salita, presumibilmente per raggiungere il Two Hearted River, anche se il fratello Leicester, citando una lettera di Ernest al padre, diceva che il fiume descritto nel racconto era in realtà il Fox. E lo stesso affermava il Baker nel cruciale capitolo 2 dell’aureo volume che avevo portato con me, insieme ai racconti e al libro di Sunny. Una larga strada carrabile che correva verso nord tra boschi di abeti e di betulle c’era ancora e portava a Grand Marais, sul Lago Superiore, dove contavamo di passare la notte. Il giorno seguente saremmo entrati nel vicino Pictured Rocks National Lakeshore, che si estende a ovest fino a Munising, il più grande parco del Nord Michigan, famoso per le sue dune di sabbia, con sentieri favolosi in cui volevo camminare almeno un po’. Sulla destra della strada, prima di arrivare a Grand Marais, scorre verso est, nella contea di Luce, il Two Hearted River. Studiando la carta calcolai che il ramo sud del Two Hearted River, il più vicino venendo da Seney, doveva distare almeno 40 chilometri: una distanza troppo lunga per essere coperta in un giorno scarso di cammino, con la tenda, l’attrezzatura per la pesca, e uno zaino pesantissimo, pieno di cibo in scatola, come quello che porta Nick. Inoltre, il tratto di fiume accanto al quale Nick monta la tenda si trova sulla sinistra della strada, cioè nella direzione opposta al Two Hearted. Ma anche il Fox River, che attraversa Seney e scorre da nord-ovest verso sud, sembrava un modello improbabile per il fiume in cui pesca Nick. Con questo dubbio metodico ci avviammo in auto verso nord.
Il sole era già alto e la temperatura ideale, come sarebbe rimasta per tutto il tempo del nostro soggiorno nel Nord Michigan. Dopo pochi chilometri, in corrispondenza di un ponte, lessi su un cartello di legno al lato della strada: EAST BRANCH FOX RIVER. Fermai bruscamente la macchina. Anche il Fox River, dunque, come il Two Hearted River, nasceva in due corsi separati! E quello che Nick raggiunge al termine del suo cammino doveva essere proprio il ramo orientale del Fox. Entrambi i rami scorrono verso sud, confluendo dopo Seney nel Manistique River per sfociare nel Lago Michigan, mentre il Two Hearted scorre dallo spartiacque verso nord-est per sfociare nel Lago Superiore. Tutto chiaro! Il nome del fiume non viene mai fatto nel racconto anche per questo motivo. Ma per titolo Ernest scelse quello del fiume più a nord, che è molto più bello e poetico: Il grande fiume dai due cuori.
Lasciata la macchina nelle vicinanze del ponte, ci inoltrammo a piedi nel bosco seguendo il più possibile il corso del fiume. Carmen era perplessa e diceva di voler tornare indietro, ma io insistetti e poco dopo, nelle vicinanze di un piccolo colle, ci apparve sulla sinistra un bel prato, e ai margini del prato scorreva lento il fiume. Un signore anziano, immobile e concentrato, pescava a mosca da sopra la riva. Anche a lui non doveva piacere pescare in compagnia. Quando ci sentì arrivare si voltò facendoci cenno di fare silenzio, come se fossimo entrati in una chiesa. “Rispetto, please!” sembrava dicesse. Rispetto per lui, per il pesce, e per il rito che si stava svolgendo. Io caddi disteso di spalle sul prato, sforzandomi di soffocare grida di gioia. Settant’anni dopo, almeno in quel piccolo angolo di Michigan, tutto era rimasto uguale.
Something Special in Grand Marais
BUFFET ON SUN PORCH OVERLOOKING THE BAY
3 Miles From National Rec. Area – ½ Mile From Lake Superior Beach
La pubblicità su un semplice foglietto disegnato a mano in un cafè di Grand Marais ci portò al glorioso Lakeview Inn Bed & Breakfast gestito dai serafici Bill e Bev Madore. Non dimenticherò mai l’amabilità con cui quei benemeriti signori appena conosciuti ci accolsero nella loro casa adibita a bed & breakfast, e la brezza dal lago che alle 8 di mattina raggiungeva la loggia, quando fu pervasa dal profumo dei muffin ai mirtilli sfornati e serviti dalla signora Beverly insieme al caffè bollente nella caraffa. Perfino la vista delle Grand Sable Dunes, la notte successiva al Rainbow Lodge di Two Heart, e la discesa del fiume in canoa, passano in secondo piano rispetto a quell’alta esperienza sensoriale. Il quinto giorno traversammo il Mackinac Bridge per entrare nella Lower Peninsula diretti a Petoskey.
***
We have lived in Petoskey, Michigan, it is true, and naturally many of the characters are drawn from life as we lived it then (Noi abbiamo vissuto a Petoskey, Michigan, è vero, e naturalmente molti dei personaggi sono tratti dalla nostra vita di allora): così scrive Hemingway in una delle buffe note d’autore che accompagnano il romanzetto parodistico The Torrents of Spring ambientato nella cittadina del Nord Michigan, libro con il quale recise il cordone ombelicale che lo legava alla precedente generazione di scrittori americani, oltre che all’editore Boni & Liveright. A Petoskey, nell’inverno tra il 1919 e il 1920, Ernest visse i mesi in cui scrivere divenne per lui una scelta di vita. Metabolizzata l’esperienza di amore e guerra, rinacque lì come scrittore. E il luogo della sua seconda nascita, come quello della prima, ha un indirizzo preciso: il numero 602 di State Street. Da quell’indirizzo, perciò, cominciammo la visita di Petoskey. Conservo una foto di Carmen accanto al proprietario della casa che fu di Eva e Hazel Potter: un affabile signore sessantenne dal fisico hemingwayano, di cui ho perso il nome, a conoscenza dello scrittore che per breve tempo lo aveva preceduto come inquilino, anche se non particolarmente interessato ai suoi libri, sorpreso e onorato che lui e la sua tipica “gable frame house” fossero oggetto del nostro interesse. Era solo in casa quando suonammo il campanello, e scattai io la foto assicurandomi di inquadrare l’intero edificio: lui e Carmen posano in piedi sugli scalini della veranda d’ingresso, la larga finestra sopra di loro è quella della stanza dove il giovane Ernest abitò in compagnia di una portatile Corona 3, la sua prima macchina da scrivere, a cui avrebbe dedicato la prima delle poesie incluse nel suo primo libro, Three Stories & Ten Poems, pubblicato in Francia tre anni più tardi.
Conservo anche una cartina della città di Petoskey, che trovai nella locale biblioteca pubblica inaugurata nel 1908 e rimasta nello stesso edificio neoclassico di East Mitchell Street, a due isolati dalla casa della signora Potter. Nella biblioteca di Petoskey Ernest tenne una conferenza sulla sua esperienza di guerra in Italia, e in quell’occasione conobbe la persona che gli avrebbe facilitato il trasferimento a Toronto, dove avrebbe ripreso il lavoro di giornalista interrotto con la partenza per l’Italia due anni prima. Non solo, la vasta collezione di classici e di letteratura contemporanea della biblioteca offrì al giovane Hemingway, nei giorni trascorsi a Petoskey, una valida alternativa al college a cui si era iscritta la maggior parte dei suoi compagni di classe di Oak Park. “Del resto, the true university of our days is a collection of books aveva detto Carlyle” (Thomas Carlyle, in una conferenza tenuta a Londra nel 1840, intitolata The Hero as a Man of Letters): questa frase l’ha scritta l’autore della Paga del sabato, già ricordato all’inizio, e stavolta non si tratta di una divagazione, perché la storia è la stessa. Sul retro della cartina di Petoskey ci sono, scritte a mano, le indicazioni per raggiungere il cottage degli Hemingway, così come le dettò Sunny a Carmen, al telefono, il giorno che ci ricevette.
Oggi Windemere è un punto di riferimento storico su Google Maps: da Petoskey, se siete in macchina, il navigatore vi ci porta in dieci minuti. In quel tempo era più complicato. Quando, nel 1968, il cottage dove Ernest aveva trascorso tutte le estati dal 1900 al 1920 (eccetto quella del 1918) venne dichiarato “National Historic Landmark”, Sunny accettò la targa di bronzo a condizione che non venisse esposta fuori dalla sua proprietà, e che il cottage non fosse aperto al pubblico. Un Hemingway Memorial Marker venne collocato nel vicino villaggio di Walloon Lake, ma identificare il cottage tra centinaia di altri sorti nel corso del secolo rimase difficile. Sapevo che si trovava sulla costa settentrionale del lago, più precisamente sul promontorio centrale, tra Indian Garden Point e Tamarack Lane, e considerando la distanza dalla punta est, potevo escludere tutti quelli che insistevano su Indian Garden Drive. Rimanevano quelli su Lake Grove Drive, ma anch’essi non erano pochi. Oltretutto, essendo una zona rurale, sulla strada si trovano soltanto le iconiche cassette postali con la bandierina che si alza e si abbassa per segnalare la presenza di posta, mentre il campanello si trova accanto alla porta d’ingresso, all’interno del driveway privato.
Anche potendo riconoscere il cottage, non sarebbe stato consigliabile entrare nella proprietà privata e suonare il campanello, così come avevamo fatto in città, a Petoskey. L’unico modo di poter sperare di essere ricevuti da Sunny era quello di telefonare prima, spiegandole chi eravamo. Percorremmo in macchina Lake Grove Drive nelle due direzioni. Io ero alla guida, e tornando verso il centro del promontorio per la carreggiata dalla parte del lago, Carmen notò una grande M su una cassetta postale. “Emme come Miller!” esclamai. Miller era il middle name di Ernest e il cognome del secondo marito di Sunny. Dalla strada vedemmo che il profilo del cottage era compatibile con quello delle vecchie foto in bianco e nero incluse nel libro di Sunny. Prendemmo nota del numero civico e tornammo a Petoskey in preda all’eccitazione. Trovata una cabina dotata di elenchi telefonici, sfogliammo febbrilmente il prezioso volume: c’erano tre Miller a Petoskey, e il secondo, John Ernest Miller, aveva due numeri telefonici e due indirizzi, uno dei quali era Lake Grove Drive. Il numero civico corrispondeva a quello sulla cassetta con la lettera M. Composi il numero e, pensando che se avesse risposto Sunny una voce femminile le avrebbe ispirato maggiore fiducia, passai la cornetta a Carmen. Alla risposta, Carmen si presentò e chiese di poter parlare con la signora Hemingway Miller. “Are you?” esclamò subito dopo. Sentii che era fatta! Nel suo inglese forbito, Carmen le parlò di me, della mia passione, e del mio desiderio. Sunny la interruppe per chiedere se eravamo giornalisti, e Carmen la rassicurò ripetendo che eravamo insegnanti, io d’italiano e lei di spagnolo. Era quasi mezzogiorno. Senza fare altre domande la sorella di Ernest disse che potevamo andare da lei alle tre del pomeriggio. Volle darci le indicazioni stradali, anche se non ne avevamo bisogno, e chiarì le regole: che non voleva essere fotografata, che non avremmo potuto fotografare gli interni del cottage, né portare con noi quaderni per scrivere o registratori.
Alle tre precise entrammo nel driveway di Windemere. Lasciai in macchina lo zainetto con dentro anche il libro di Sunny, dato che, essendo di proprietà della biblioteca, non avrei potuto chiederle di firmarlo, e portai con me soltanto la piccola macchina fotografica per fotografare gli esterni. Il cottage, una semplice costruzione a un solo piano con il tetto spiovente, era in basso rispetto alla strada, immerso negli alberi che coprivano la vista del lago. Lei aspettava dietro l’antiporta trasparente, e quando ci vide uscì fermandosi ai piedi della scaletta. Era alta, ferma, bella, e io sentii come un vuoto riconoscendo sul suo largo viso l’espressione insieme fiera e dolce degli Hemingway. Non c’erano altre persone in casa, non c’erano case vicine, e a ottantacinque anni aveva accettato di ricevere due sconosciuti nel cottage fatto costruire dai suoi genitori, che Grace aveva lasciato a Ernest, e Ernest a lei. Era sola e non aveva paura. “Fraid of nothing” era il motto delle loro scorribande estive per i campi e sul lago, tre quarti di secolo prima. Suo padre aveva preceduto tutti. Dopo Ernest, anche la sorella Ursula e il fratello Leicester se n’erano andati alla stessa maniera; sua madre era morta nel 1951, e il suo secondo marito nel 1972; Marcelline era morta di malattia nel 1963, mentre Carol, la sorella più piccola, viveva da molti anni in Massachussetts avendo tagliato i ponti con la famiglia. Il cottage era la cosa più preziosa che aveva, dopo suo figlio Ernest Hemingway Mainland e suo nipote John Kenneth Mainland, e lì aveva scelto di vivere la maggior parte dell’anno, immersa nei ricordi. Il suo libro, pubblicato nel 1975, si conclude con queste parole: “Sono passati sessant’anni da quei giorni, ma a volte mi appaiono così vividi e luminosi come il foliage dall’altra parte del lago in una splendida giornata d’autunno”.
Entrambi la ringraziammo di aver accettato di riceverci. Lei annuì stringendo la mano a Carmen, e prima di porgerla a me, mi osservò senza sorridere. “Are you a journalist?” domandò di nuovo. Doveva aver sviluppato una vera e propria intolleranza verso la categoria. Ripetei quanto le aveva detto Carmen al telefono, e lei domandò come mai un insegnante d’italiano s’interessasse così tanto a suo fratello. La risposta era facile: perché Ernest era anche italiano. Finalmente accennò un sorriso, mi strinse la mano, e ci condusse all’interno del cottage.
***
Entrando mi colpì il contrasto tra il bianco delle pareti esterne e il marrone dell’interno, un non-colore che sembrava assorbire tutta la luce proveniente dalle larghe finestre sul lago. Eppure l’ambiente era caldo e accogliente, e lo spazio più grande di quanto si potesse immaginare da fuori. La grande sala centrale con il camino di mattoni, la sala da pranzo e la cucina sulla destra, due camere sulla sinistra formavano il nucleo originale del cottage; altre camere e una dépendance erano state aggiunte nel corso degli anni. La prima cosa che notai fu un trofeo di caccia, poi il ritratto di Ernest dipinto da Grace, le foto dei genitori, altri quadri e uno scaffale di vecchi libri, mobili e oggetti d’epoca usati come soprammobili: quasi un secolo di storia. Guardandomi intorno incantato il mio sguardo si posò su una foto in bianco e nero poggiata sopra un piccolo piano. Era il ritratto di un uomo dal sorriso gioviale, tra i quaranta e i cinquant’anni, che somigliava a Ernest ma che non era Ernest. Impulsivamente domandai se quell’uomo fosse Leicester, e subito me ne pentii, pensando di essere stato indelicato. Ma Sunny, che fino a quel momento non aveva tradito alcuna emozione, scoppiò in una risata lasciandomi basito. Il fatto è che, involontariamente, avevo pronunciato il nome alla tedesca: Làisester. Ancora ridendo, lei spiegò che così lo chiamavano per scherzo loro, Ernest e le sorelle, ma che il nome del suo secondo fratello si pronunciava Lèster, pensava lo sapessi, confidenzialmente abbreviato in Les. Quel piccolo avvenimento ebbe comunque l’effetto di rompere il ghiaccio, e la conversazione cominciò a fluire con brio toccando i più svariati argomenti.
Vedendo che osservavo un quadro con il ritratto di uomo in abiti settecenteschi, in una posa che ricordava quella del Goethe nella campagna romana, lei ci disse chi rappresentava, e aggiunse che era vestito come un “Liberaci”, enfatizzando il nome con simulata albagia. “Come chi?” domandai, perché ancora non avevo sentito parlare di Valentino Liberace, il musicista e showman italo-americano nato in Wisconsin e morto tre anni prima, molto popolare in America negli anni Cinquanta e Sessanta, noto per gli stravaganti costumi che indossava durante i suoi spettacoli e per l’altrettanto stravagante personalità. A Sunny sembrò incredibile che non lo conoscessi, dato che era “italiano”. Disse che il successo l’aveva rovinato, ma che da giovane era stato un pianista geniale. Sapevo che lei aveva suonato l’arpa nella Memphis Symphony Orchestra, e le chiesi se suonasse anche il piano. Disse che l’aveva studiato da giovane, che aveva avuto un bravo maestro… e mentre parlava con lo sguardo nel vuoto percepii cuoricini volteggiare nell’aria.
Quando mi chiese di quale parte d’Italia fossi, dopo averle risposto, le chiesi a mia volta se possedeva ancora gli orecchini d’argento comprati sul Ponte Vecchio, che Ernest le portò al ritorno dal suo primo viaggio in Italia. Si era dimenticata di averlo scritto nel libro e rimase sorpresa. Poi disse che, sì, certamente li aveva ancora, e che anche lei era stata a Firenze, in occasione del suo memorabile viaggio in Europa nel 1929; che aveva visto il Ponte Vecchio, naturalmente, ma che le risultava difficile organizzare i ricordi: a volte le veniva in mente una certa chiesa o una certa piazza, senza ricordare in quale città l’avesse vista. Dissi che era normale, e che quello era il problema dei “Cook’s Tour”: che si vedono troppe cose in troppo poco tempo. Lo dissi perché nel capitolo dedicato al suo viaggio in Europa, Sunny aveva ricordato quando, in procinto di partire da Parigi per il suo “Cook’s Tour” attraverso la Francia, l’Italia e la Svizzera, in compagnia di un’amica di Oak Park, Ernest raccomandò loro di non mettersi nei guai in Italia, dato che a lui era proibito di entrarvi “per via di qualcosa che aveva scritto su Mussolini”. E questo nonostante la buona reputazione di cui aveva goduto in Italia subito dopo la guerra, per essere stato il primo americano ferito sul fronte del Piave, “decorato con la medaglia d’argento al valor militare e perfino nominato cugino onorario del re Alfonso” (sic). Con delicatezza le dissi che in quel passaggio del libro aveva confuso il re di Spagna Alfonso XIII con il re d’Italia Vittorio Emanuele III, e che mi permettevo di farglielo notare soltanto perché, nel caso avesse fatto una nuova edizione, avrebbe potuto correggere il nome. Lei mi osservò in silenzio, poi guardò Carmen e le chiese come facesse a sopportarmi. La trovai una battuta squisitamente hemingwayana, e mi piacque molto. Restammo da lei fino a quasi le cinque, parlando cose che ’l tacere è bello / sì com’era ’l parlar colà dov’era.
Mi sarebbe piaciuto molto tuffarmi nel lago dal piccolo imbarcadero sul retro della casa, dove in passato i ragazzi ormeggiavano le loro canoe, ma non era evidentemente possibile. Per fortuna, non lontano dal cottage, c’era un piccolo parco pubblico con una scala di legno che scendeva al lago: lì potei fare il bagno, nuotare nel Walloon Lake come avevo desiderato, mentre Carmen preferì aspettarmi seduta sulla riva sabbiosa. Quella sera dormimmo al Dilworth Hotel di Boyne City, e la mattina dopo andammo per colazione a Horton Bay, sul Lago Charlevoix.
La stradina che dal General Store di Horton Bay scende al molo – “the sandy road” dei racconti – era asfaltata, ma era possibile vedere la sabbia ai lati della carreggiata. In fondo alla strada c’era la piccola spiaggia e un imbarcadero fatto con pali e tavole di legno, e nella baia c’erano barche a vela e motoscafi ormeggiati, ma ancora nessuno che faceva il bagno. Le avevo parlato del mio desiderio di visitare Horton Bay e di nuotare fino alla punta dell’insenatura, ma non le avevo detto quando saremmo andati. Mentre scendevamo a piedi verso la spiaggia ci passò accanto una macchina scura con al volante una donna dai capelli bianchi e ondulati tagliati corti. La macchina si fermò alla fine della strada, la donna scese e si mise a osservare la baia, la spiaggia, il cielo. Sembrava voler controllare che tutto fosse a posto. Ci avvicinammo, ma per non spaventarla aspettammo che fosse lei a voltarsi. Quando fece per risalire in macchina ci vide, sorrise, disse “Guarda chi c’è!”, e ci chiese com’era andata a Boyne City. Le dicemmo che il signore del Dilworth era stato molto gentile e ci aveva dato una suite al prezzo di una camera normale. Lei sorrise con soddisfazione. Aggiunsi che, avendo saputo della nostra visita nel pomeriggio, ci aveva detto che eravamo stati molto fortunati perché da anni lei non ammetteva sconosciuti nel cottage.
“Sì, è vero, siete stati fortunati” confermò Sunny.
“Ci ha resi felici!” esclamò Carmen.
Lei le sorrise. “Forse lo eravate già” disse, e si voltò a osservare di nuovo la baia, la spiaggia, il cielo. Mi domandai che cosa stesse pensando: se come tutto fosse cambiato o se come tutto fosse rimasto com’era.
“Siamo stati al General Store” dissi. “E abbiamo visto la casa degli Smith, e la terrazza dove a volte andavate a ballare la sera.”
Lei lasciò cadere le braccia esclamando: “Oh mio Dio! Ho scritto anche questo nel libro?”
“No, l’ha scritto suo fratello, in un racconto in cui parla di un gruppo di ragazzi che fanno il bagno lì, intorno al molo. Tutto sembra essere rimasto com’era, a parte l’asfalto sulla strada.”
“Quale racconto?”
“Uno di quelli di Nick Adams.”
“Ernie non l’avrebbe pubblicato, era una cosa che aveva scritto per sé.”
Sunny Guardò distrattamente la sua macchina.
“Però è bello e importante.”
Lei scosse la testa. “Non avrebbero dovuto pubblicarlo. Anche quest’ultimo libro…” fece un’espressione come se avesse l’amaro in bocca, e di nuovo guardò la macchina.
“Signora, se deve andare…”
“Sì, devo fare una commissione a Petoskey. E voi dovete andare a fare il bagno prima che arrivi altra gente. Questa è l’ora migliore.”
“Signora, è stato un grandissimo piacere, e le auguriamo ogni bene!”
Carmen le prese la mano e la tenne fra le sue con delicatezza. Poi anch’io le strinsi la mano.
“Abbiate cura di voi stessi” disse.
“Anche lei, signora, abbia cura di sé e del cottage. È un posto veramente speciale!”
Sunny salì in macchina, ma prima che chiudesse la porta la richiamai.
“Signora! In quel racconto Nick viene chiamato Wemedge. Significa qualcosa?”
“Niente” rispose lei. “Non significa niente. È solo poesia.”
“Come Nunbones?”
“Esattamente.”
Chiuse la porta, fece una rapida manovra, e partì.
“Che donna stupenda!” esclamai.
“Incredibile come guida bene a quell’età!”
“Ha fatto molta pratica. Pensa che una volta, nel millenovecento ventotto…”
“Aspetta un momento!” m’interruppe Carmen. Salutò una coppia di ragazzi che stavano scendendo verso la spiaggia in shorts e infradito, e porgendo la macchina fotografica chiese loro se potevano farci una foto. È una delle mie preferite tra quelle che ho di noi due.
***
Sunny morì a Petoskey quattro anni e cinque mesi dopo il nostro incontro. Lessi per caso la notizia sul New York Times. E siccome il breve necrologio non indicava la causa, mi piacque pensare che fosse morta nel sonno, dopo aver visto un’ultima volta il tramonto su Little Traverse Bay. Per sua volontà non ci furono né camera mortuaria né cerimonie, soltanto l’annuncio che donazioni in sua memoria potevano essere fatte alla Walloon Lake Association.
Per rispetto del desiderio di Sunny, in tutti questi anni non ho parlato del nostro incontro se non con amici aficionados di sicura fede. Tantomeno ne ho scritto. Nel 1999, in occasione del centenario della nascita di Hemingway, anche i media italiani, naturalmente, ricordarono l’evento. Le testate che potevano permetterselo inviarono giornalisti, scrittori, fotografi, cameramen nei luoghi hemingwayani più ovvi: Key West, Cuba, Oak Park… a nessuno, che io sappia, venne in mente di andare su nel Michigan. E a me non passò per la mente di scrivere qualcosa da proporre a un giornale. Però la sera del 21 luglio – in quel tempo vivevamo in Connecticut – cercai nei miei file i ricordi del viaggio in Nord Michigan, e trovai la cartina di Petoskey con i nostri appunti scritti sul retro. Presi il telefono e composi il numero di Windemere. Mi rispose la voce di un uomo: era Ernest Mainland. Gli dissi del mio incontro con sua mamma, nove anni prima, e di come io e mia moglie avevamo apprezzato la sua gentilezza. Lui disse che aveva il vago ricordo di un italiano che si era presentato lì con sua moglie, perché un giorno sua mamma gli disse qualcosa del genere: “Immagini? In Italia sanno degli orecchini d’argento che mi portò Ernie da Firenze, e io non ricordo dove cavolo li ho messi!”. Era molto cordiale, per niente infastidito dalla chiamata di uno sconosciuto. Gli chiesi com’era andato il centenario lì sul lago, e lui disse che era stata una giornata da dimenticare. Aveva accettato di fare una sorta di open house, e per tutto il giorno c’era stata una lunga coda di visitatori davanti al cottage: c’erano quelli che volevano sapere se la casa aveva un bagno quando venne costruita, e se c’erano ancora le tende degli indiani là dietro, e dove tenevano gli animali, e dove arrostivano il maiale, e quello che voleva vedere la macchina da scrivere, e quello che aveva chiesto dove s’era sparato suo zio… un incubo! Ma ora la porta era chiusa – concluse – e così sarebbe rimasta per i prossimi cento anni. Dopo tutto, anche lui era un Hemingway.
Rimane da spiegare perché abbia deciso di scrivere ora su quell’incontro.
Nel marzo di quest’anno sono stato invitato a parlare del mio rapporto con l’autore della Paga del sabato a Bassano del Grappa. Già il luogo era tutto un programma. A Bassano, nel parco della Villa di Ca’ Erizzo, erano dislocate nel 1918 le ambulanze della Croce Rossa Americana, e in una parte di quel complesso Quattrocentesco ha sede oggi il Museo Hemingway e della Grande Guerra. Ci ero già stato una volta, per un motivo simile, invitato dalla sua bella Biblioteca Civica, e in una splendida mattina autunnale avevo passeggiato sul Lungobrenta Ernest Hemingway con in mano Addio alle armi: “Nel letto del fiume ciottoli e ghiaia erano asciutti e bianchi nel sole e l’acqua correva limpida e azzurra nei canali…”. Questa volta, insieme a me, c’erano anche Margherita Fenoglio e due bravi scrittori italiani, uno dei quali aficionado di rango. Non solo aficionado, anche acuto esegeta. Appena un mese dopo, infatti, è uscito un suo ottimo libro su Ernest, proprio un bel libro, in cui dice cose giuste con un metodo nuovo: prende Il vecchio e il mare, eletto a summa poetica di una peculiare arte narrativa, e alla luce di questa summa ripercorre la biografia letteraria di Ernest. Il libro – Sognava i leoni. L’eroismo fragile di Ernest Hemingway – separa il grano dal loglio, trascende la correttezza e la cronaca spicciola per valorizzare l’essenza dell’opera, il senso ultimo, in un modo che risulta illuminante. Mi ha fatto pensare e ripensare, capire e nuovamente apprezzare. E come ultimo effetto, mi ha fatto venir voglia di rileggere il libro di Sunny.
Consultando un catalogo online ho visto che era stato ristampato nel 1999, in occasione del centenario. Ma io volevo rileggere la stessa edizione che avevo letto nel 1990, e oggi, per fortuna, è più facile trovare un libro fuori commercio di quanto non lo fosse in quel tempo. Sul sito di un rivenditore americano ho trovato una copia della prima edizione in vendita a 6 dollari, più otto di spedizione. Doveva arrivare in due o tre settimane, invece è arrivata in pochi giorni, come se il libro stesse solo aspettando di essere ordinato da me. L’ho aperto con grande emozione, e sulla prima pagina bianca, in bella calligrafia di penna stilografica, c’era scritto: Best wishes from “Sunny”, Madelaine Hemingway Miller.
Luca Bufano
Bagno a Ripoli, 12 dicembre 2024




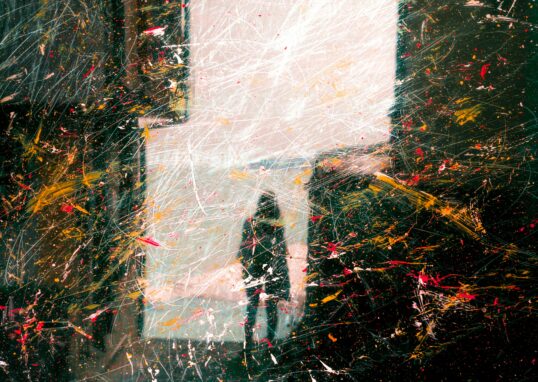


Luca, ho letto l’articolo. Ho 70 anni, raramente ho sentito il medesimo entusiasmo nel leggere un testo. Perfetto in ogni sillaba. GRAZIE. Grazie per averlo condiviso. La Vita è anche questo. Grazie ancora. E davvero, Buona Vita.
Sergio
Era tanto tempo che non leggevo un articolo così interessante e capace di trascinarmi via con sé. Che cos’ha Nick Adams che ci ha fatto innamorare in questo modo? Dopo i racconti dì Hemingway non ho più potuto smettere di cercare la sua America nei libri. Grazie.
Buonasera,
è uno degli articoli più belli su Hemingway pubblicato in Italia negli ultimi anni. Su Hemingway ci sarà ancora tanto da scrivere e scoprire. Ha avuto una vita non comune e continuerà ancora a sorprenderci. Grazie.
Grazie a voi per i commenti. Ma chiamiamolo pure racconto, anche se non-fiction
Un bellissimo racconto, con molto di Hemingway, della sua America, e di storie che si incrociano spinte dalla passione e dal fato