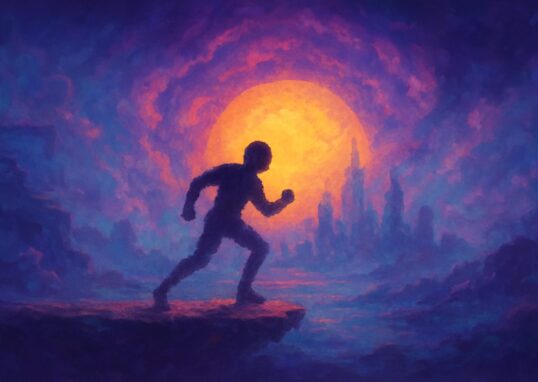La recente decisione di Twitter di sospendere e poi chiudere definitivamente l’account di Donald Trump, accusandolo di aver ripetutamente incitato alla disobbedienza e alla violenza, infrangendo le regole di quel socialnetwork, ha reso ancora più attuale il tema dei pericoli che la democrazia corre quando affida il dibattito pubblico a piattaforme commerciali, interessate principalmente ad accrescere, con ogni mezzo e in modo spregiudicato, i loro bacini di utenza e di conseguenza i loro profitti.
Facebook, di proprietà di Mark Zuckerberg, come le sue costole Instagram e WhatsApp, è il social preferito da 152 dei 167 Paesi dove è diffuso, praticamente sul 90% del territorio del pianeta, e si avvicina ai tre miliardi di utenti mensili. Mettendo a punto delle app “light”, che possono essere scaricate in Paesi come quelli africani, dove la connessione non è ottimale, Facebook ha ripreso il predominio sui concorrenti, rimanendo la più influente tra tutte le forme di comunicazione rapida cui Internet ci ha ormai abituati. La sua forza è essere anglofono, anche se l’illusione dell’Internet “del globo”, la visione salvifica degli esordi, della democrazia e della libertà di espressione che parlano una sola lingua, si è scontrata presto con le necessità commerciali dei social che – si tende a dimenticarlo – sono “imprese”, che vendono prodotti che noi consumiamo, non differentemente dalla Coca Cola e dalla Nike, per fare un esempio di merci globalizzate subito comprensibile, anche se i social sembrano apparentemente non vendere niente, ma solo concedere una libertà d’espressione democratica mai vista prima: poiché nei mercati si fanno affari migliori usando la lingua del posto, ecco comparire WeChat in Cina e Odnoklassniki e VK (Vkontakte) in Russia, mentre il cinese Tik Tok aspira all’egemonia mondiale, insidiando pericolosamente quella zuckerberghiana.
Sul “dogma”, sempre più indebolito, secondo cui Internet e i socialnetwork rappresenterebbero il simbolo della libertà d’espressione, interviene ora, per discuterne, David Kaye, docente di Diritto Pubblico Internazionale alla University of California e consulente delle Nazioni Unite, che gli hanno commissionato una importante ricerca sul diritto di parola e sulla protezione della libertà di opinione. Nel 2019 ha pubblicato Speech Police: The Global Struggle To Govern The Internet, tradotto in italiano da Francesco Graziosi con il titolo Libertà vigilata: la lotta per il controllo di Internet (Treccani, 2021). L’interesse di questo libro sta principalmente nel fatto che è scritto da un giurista e le pezze d’appoggio alle sue argomentazioni sono spesso citazioni da “udienze” tenutesi alla Commissione giudiziaria della Camera o del Senato degli Stati Uniti, quando a più riprese si è discusso sui social media e sul diritto individuale di esprimersi, su chi decide o dovrebbe decidere cosa si può vedere e cosa invece deve essere nascosto.
Ma, come dice Enrico Pedemonte nella prefazione: “Il libro di Kaye non risolve questi dilemmi. Ma fa le domande giuste”. Che, in estrema sintesi, sono queste: “Chi vigila su quanto viene detto in rete? Chi garantisce la tutela dei diritti individuali su Internet? Chi stabilisce le regole che governano l’espressione delle opinioni in rete? Chi si occupa di farle rispettare? Chi fa da giudice nelle controversie sulla loro applicazione? Le aziende? I governi dei singoli stati? La Commissione Europea? Una combinazione di questi?” (pag. 30). Domande cruciali che l’autore si pone, oggi che i social network sono diventati spazi aperti per il dibattito pubblico e privato, dove “si propaga l’odio tramite l’amplificazione artificiosa…pervasi dall’incitamento alla violenza e alla discriminazione…ottimi e redditizi strumenti per la disinformazione, l’interferenza elettorale e la propaganda”. Kaye supporta questi interrogativi condividendo i risultati di indagini che ha condotto in Myanmar, in Siria, in Pakistan, India, Ghana, Kenya, Malesia, Singapore: “paesi piccoli, senza il potere di mercato dei nordamericani o degli europei” e tuttavia cartina di tornasole per ciò che avviene negli Stati Uniti e in Europa su cui l’autore si dilunga perché soprattutto la Commissione Europea pare interessata a una regolamentazione, avendo chiesto a più riprese norme severe che garantissero a tutti i Paesi europei il rispetto delle regole, mentre negli Usa il dibattito sembra volgersi verso la salvaguardia dei diritti umani, della privacy, della libertà di espressione.
Facebook, Twitter, YouTube si difendono sostenendo che hanno regole, politiche, standard, linee guida, tecnologie e procedure che si sforzano di applicare in maniera neutrale, nel tentare di moderare la mole evidentemente enorme dei contenuti pubblicati ogni giorno sulle loro piattaforme globali. Le regole di Twitter, per esempio, che sono state al centro del dibattito per aver oscurato Trump, mirano a censurare i comportamenti negativi, non “un’ideologia o un sistema di valori in particolare”. Ma, sia in Europa che in America, le corporations proprietarie delle piattaforme social sono tutelate dalle direttive sul commercio elettronico (poiché sono, appunto, entità commerciali, né politiche né governative, sono esentate da responsabilità istituzionali e hanno, in poche parole, “la libertà di creare le proprie regole sui contenuti”, quindi: “libertà nell’adozione degli standard, nel decidere cosa è appropriato, nel regolamentare i propri spazi in maniera autonoma”). Più libertà di espressione fa bene agli affari: si potrebbe sintetizzare così l’incentivo imprenditoriale alla base dei codici etici di Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube.
Una maggiore partecipazione moltiplica i dati sugli utenti raccolti dalle piattaforme e ne aumenta il valore per gli inserzionisti pubblicitari. Infatti è ormai noto che, se possiamo usufruire gratuitamente degli spazi per esprimerci che i social ci concedono, è perché le merci di scambio siamo noi, che ci vendiamo più o meno consapevolmente alle corporations, cui consegniamo informazioni preziose sui nostri stili di vita, consumi, gusti, perfino emozioni.
Gli incidenti di percorso che disturbano questo sistema commerciale perfetto si chiamano “fake news”, “odio”, “violazione della privacy”. Come dice Mercy Mutemi, legale della Bloggers Association of Kenya di Nairobi, citata dall’autore: “Le fake news? Chiamiamole bugie”. La costituzione kenyota non tutela la propaganda a favore della guerra, né l’incitamento all’odio o alla violenza. “Ma le bugie sono una forma di espressione e la libertà d’espressione è protetta dalla legge… e comprende anche la libertà di dire bugie”.
Germania, Francia, Spagna compaiono nel libro di David Kaye per due modelli che i governi di questi Paesi hanno adottato per vigilare sui contenuti di stampo terroristico e sull’odio veicolato tramite i socialnetwork. Il primo comporta operazioni di polizia delle IRU (Internet Referral Units, Unità addette alle segnalazioni su Internet) mentre il secondo riguarda “ammonimenti “in stile Macron. Nel settembre 2017, durante la sua prima visita all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Presidente francese affermò: “C’è chi combatte per i nostri valori, la libertà e la sicurezza dei nostri concittadini e chi decide di fare il gioco dei terroristi. Scegliete voi da che parte stare”. Il tono chiaro e ultimativo con cui Macron si rivolse ai leader della Silicon Valley in ascolto, avrebbe dovuto quanto meno impensierirli. Invece il dibattito sulle conseguenze di questo vuoto di potere, dopo quattro anni da questa ramanzina, sembra appena iniziato, sollecitato anche da questo interessante libro di Kaye.
L’odio, le fake news, il proselitismo terrorista, la propaganda continuano a sfruttare i socialnetwork perché, in fondo, i governi di tutti i Paesi, Stati Uniti in testa, si sono dimostrati riluttanti a specificare su cosa si dovrebbe intervenire per porre un argine al degrado, al di là delle buone intenzioni, in verità rivendicate da tutti. “Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e altri hanno adottato leggi penali che proibiscono l’incoraggiamento, l’esaltazione o l’apologia del terrorismo, tutte cose che ai sensi della legge sui diritti umani ricadono a malapena sotto l’autorità dei governi. Questi non possono ordinare la rimozione di contenuti problematici senza una base giuridica statale, perciò chiedono alle corporations di farlo al loro posto” (pag. 105).
Le corporations proprietarie dei social media, secondo i funzionari al servizio di Angela Merkel, non potevano rappresentare spazi in cui “violare impunemente le leggi dello Stato più di quanto si facesse quotidianamente nelle birrerie” pag. 90, (assunto velato di sarcasmo, che però spiega bene la supponenza con cui ancora si guarda ai social, considerati spesso alla stregua di “discorsi da bar” cui dare relativa importanza).
Forse sta proprio in questa ambiguità il nocciolo della questione: i social media sono controllati da un pugno di imprese private che mirano principalmente ad accrescere il loro valore azionario. Come può un’azienda commerciale essere investita, o addirittura auto investirsi di un’autorità morale? Le regole che dovrebbero governare la libertà d’espressione nello spazio pubblico dovrebbero essere stabilite dai governi, su sollecitazione delle comunità politiche che eleggono i loro rappresentanti. Invece vengono demandate a compagnie private, sottratte al controllo e alle responsabilità democratiche, cui si chiede di fungere da governanti e giudici che abbiano a cuore l’interesse pubblico, allorché sono interessati invece ai loro esclusivi profitti. E intanto, mentre si perpetua questo clima di abusi, influenzati da algoritmi sconosciuti e gestiti dalle piattaforme nella totale impunità, noi utenti continuiamo a giocare, a mettere i nostri cuoricini sotto ai post, nell’illusione incosciente che l’interazione a cui Facebook, Instagram e Twitter ci chiamano quotidianamente abbia a che fare con ciò che ci piace e ciò che non ci piace, invece che con questioni leggermente più complesse, come il controllo sempre più invasivo delle nostre vite per esempio.
Il libro di David Kaye pone l’interrogativo più inquietante, dopo aver configurato una società in cui l’eccesso di libertà porrà il problema paradossale di difenderla: che cosa sia la libertà, e come sarà il futuro delle democrazie evolute, se i governi non porranno un freno allo strapotere delle corporations.
(Foto)
Paolo Landi si occupa professionalmente di comunicazione e ha scritto alcuni libri sull’educazione dei minori all’uso consapevole dei media. Recentemente ha pubblicato “Instagram al tramonto” (La Nave di Teseo)