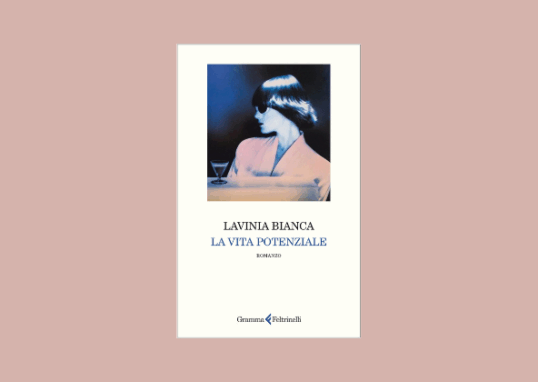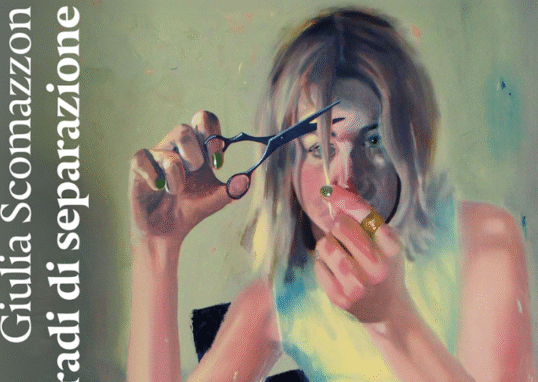Foto di Jason Schjerven su Unsplash
“Senza l’intensità del significante, senza il peso del corpo, non avrebbe mai trattenuto la profondità del significato”: tra la dimensione corporale dell’esistenza e il peso specifico del gesto, parola o movimento che sia, si gioca da sempre l’equilibrio instabile, turbato e conturbante dell’essere umano. Così, suggerisce Matteo Bianchi nell’ultima sua fatica letteraria, L’altro imperatore (Edizioni L’Obliquo, 2024): una plaquette di minimali prose poetiche in dialogo con le fotografie di Andrea Lunghi, dedicate a un Napoleone che con la sua storia emotiva, oltre che fattuale, attraversa le ere e giunge a noi, celandosi inaspettatamente nella vecchiaia immalinconita di un padre che vorrebbe ancora “guerreggiare contro il mondo”.
L’esilio dell’imperatore nell’Isola d’Elba (ed è proprio ad ElbaBook, manifestazione giunta alla sua decima edizione, che il libro sarà lanciato), i suoi sonni inquieti nei dieci mesi di segregazione isolana e l’umanissima consapevolezza di tutte le rinunce compiute, compresa la più costosa e cioè quella amorosa, rappresentano il correlativo oggettivo accorato, compostamente straziante ma non passatista dello straniamento che invade l’animo dell’uomo, da solo con le sue fragilità e la sua follia. Un viaggio etico attraverso una stanza. D’altronde, Pasternak ha scritto che “non si può attraversare la strada/senza calpestare l’universo”.
E se il paesaggio, di prosa in prosa, si trasforma fino a cambiare geografie e tempi storici, il modo migliore per rappresentare queste spaventose transizioni – psicologiche più che reali – sono proprio le impercettibili differenze presenti nella progressione degli scatti che ritraggono il giaciglio elbano di Napoleone lungo l’arco di quell’unica notte trascorsa nell’eremo di Santa Caterina d’Alessandria. Non c’è ombra d’uomo in quello scenario asfittico se non nell’indizio della posizione delle lenzuola che sembra seguire la febbre del silenzio, della solitudine, di quello stesso rabbioso e insieme tenero delirio dell’uomo anziano a cui è dedicato l’ultimo testo.
Freud ha detto che “dal poeta emerge il pensatore”, e infatti Bianchi, attraverso una prosa che non lesina l’eleganza appresa dalle sue molte letture di poesia lirica senza disperdere quell’atteggiamento colloquiale e asciutto, sobrio, che appartiene al romanzo contemporaneo più efficace, imbastisce un discorso poetico intelligente oltre che empatico, trasversale ad epoche diverse e perfino astorico, pur cimentandosi in alcuni dettagli precisi che ineriscono a fatti di comune memoria.
Un messaggio libertario che unisce eroismo e alienazione: “Ma il Prometeo della Rivoluzione, colui che aveva rubato il lume all’Ancien Régime per liberare i suoi fratelli, non avrebbe mai accettato di essere subordinato alla visione dell’ennesima corona. Sarebbe stata ancora la sua guerra, con le sue mani e nel suo stesso nome”.
Ed è sempre alle mani, “non metaforiche ma reali”, che Paolo Fabrizio Iacuzzi (presente, quest’anno, anche lui ad ElbaBook) dedica simbolicamente l’antologia dei sette vincitori del Premio Ceppo Biennale Racconto 2024: Nelle sue mani – le sette opere di Misericordia corporale (Interno Libri Edizioni).
Il corpo, in tutta la sua fulgida operosità, è centrale nelle brevi prose di questi autori. Un corpo in movimento, perfino quando è di marmo e non umano come quello magicamente animato dei due leoni dell’ingresso della Favorita, nel singolare contesto panormita di Giovanna Di Marco, in cui la realtà è la grottesca pantomima dell’assurdo. Un corpo affatto identitario, eppure pieno di bisogni incontrollati, di debolezze, di condizionamenti opportunistici (e di sperequazioni sociali e di genere) che svela l’aspetto più bieco, o colpevolmente inautentico, dei migliori sentimenti, o degli intenti apparentemente più nobili, come suggerisce Nadia Terranova. Un corpo che necessita di coprire la propria nudità poiché l’uomo, diventando eretto e civilizzandosi, ha iniziato anche a provare vergogna per l’esposizione dei propri genitali, come spiega Alessio Mosca. Un corpo singolo martoriato nell’intera umanità malata, in cui “ogni cosa eternamente cade”, come afferma Rilke riportato nel drammatico racconto di Mircea Cărtărescu che si conclude, però, con una speranza collettiva.
Un corpo che pretende sepoltura, perché “seppellire è humare, da humus, ed è in questo preciso momento che nasce l’humanitas”, come chiosa Michele Mari. Un corpo che ha terrore della segregazione, eppure non rinuncia all’obiezione di coscienza per la quale viene condannato, andando in contrasto con la legge come l’Antigone, e come lascia intendere, nel suo racconto, Ezio Sinigaglia. Corpi che affondano nel buio, stretti gli uni agli altri, come nelle Sette Opere di Misericordia del Caravaggio di cui, una in particolare, “Dare da bere agli assetati”, riporta Giulia Oglialoro a compiere una riflessione sulla scrittura come “forma di carità per noi stessi e per gli altri”, acqua nel deserto della banalità in cui può sprofondare il linguaggio.
Il corpo è al centro non solo della meccanica dei movimenti ma anche della concretezza dei sentimenti dell’io psicologico e mitologematico. Un io di carne, antropocentrico, che continua ad apparire predominante e dominante nella letteratura e nella realtà, al di là degli espedienti formali, talvolta drammaticamente (o ironicamente) travolto dal suo stesso cannibalismo. Non a caso, per Feuerbach, “l’uomo è ciò che mangia”.
Gisella Blanco vive a Roma. Collabora con Il Foglio. Scrive per la rivista Leggere Tutti cartacea e on line, per Atelier Poesia cartaceo e on line, per Liguria Day, per Poesia di Luigia Sorrentino, per Smerilliana. Ha seguito la comunicazione della Fiera del Libro di Iglesias, del Premio Nazionale Elio Pagliarani, Elba Book e del TeverEstate per il Cibaldone Culture Festival. È giurata nel Premio Internazionale Città di Sassari per la sezione Poesia.