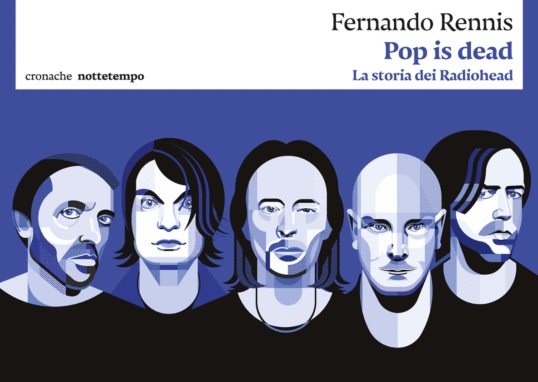di Rosario Sparti
Dove eravamo rimasti? Nel 2019 l’onda di Parasite aveva travolto la Croisette per poi dirigersi verso Hollywood. Intanto un’altra onda proveniente dall’Oriente iniziava a travolgere tutto il mondo costringendo il Festival di Cannes, per la prima volta dopo le manifestazioni studentesche del 1968, a fermarsi.
Nonostante tutta la sua sfrontata pervicacia Thierry Frémaux, delegato generale del festival, si vedeva nei fatti costretto ad alzare bandiera bianca e rimandare tutto a tempi migliori, pur senza privarsi del piacere di apporre il marchio di Cannes su tutti i film da lui selezionati per l’edizione del 2020.
Un anno dopo sembra che nel frattempo non sia successo nulla. Certo, in sala si indossano le mascherine, chi entra nel Palais deve avere il Green Pass o sottoporsi alla prova della sputacchiera ogni 48 ore, ma a differenza di Venezia qui non sembra esserci nessuna volontà di procedere cauti, cercando di rischiare il meno possibile. Frémaux sa che deve mostrare i muscoli, ancora più di prima: Cannes deve diventare il simbolo della ripartenza nel segno della continuità.
E in verità, fin dal primo istante, la 74° edizione del Festival di Cannes ha esibito senza ritegno il suo desiderio di ricordare a tutti cosa è stato e cosa può ancora essere il Festival di Cannes. Quindi celebrità sul tappeto rosso, sale senza distanziamento di posti, calendario intasato di proiezioni, film che spuntano come funghi fino all’ultimo istante, ma soprattutto il sogno di tornare a dettare i tempi della cinefilia internazionale esibendo la sua potenza di fuoco.
Peccato che i film presenti in Concorso, pur con qualche eccezione, siano per la maggior parte l’espressione dignitosa di una medietà artistica poca funzionale a slanci retorici e prosopopea mediatica, scarsamente utili a sorreggere la grandeur transalpina. Servirebbe almeno un titolo forte per attirare l’attenzione, in grado di suscitare reazioni contrastanti e aprire magari un dibattito critico che stenta a prendere corpo, denunciando peraltro una stanchezza del giornalismo cinematografico che sembra anch’esso essere uscito stremato dalla pandemia. Resta la sensazione, infatti, che gli stessi giornalisti si siano resi conto e stancati di certe formule sempre uguali a sé stesse, buone forse per i social, ma che oggi si rivelano in tutta la loro vacua natura di aria fritta venduta con arte.
A movimentare la situazione allora ci pensa proprio il presidente della giuria, Spike Lee, pronto a fare la cosa giusta un attimo prima della fine: innanzitutto con la sua scenetta in stile Oscar che lo vede svelare in apertura della cerimonia di premiazione il vincitore della Palma d’Oro, tra incomprensioni linguistiche e un disorientamento figlio di una partecipazione sin troppo attiva a un festival che l’ha scelto come simbolo, e poi con l’annuncio del Palmarès decretato dalla giuria che ha guidato con percepibili turbolenze.
A vincere il premio più ambito è Titane della regista francese Julia Ducournau, seconda donna nella storia del festival a vincere la Palma d’Oro. Con una giuria composta in buona parte da donne e da francesi, sarebbe fin troppo facile pensare che si tratti di una scelta obbligata, figlia da un lato del dazio da pagare al paese ospitante e dall’altro segno politico dei tempi che viviamo. Invece si tratta di una valutazione senz’altro politica, però di ben altro segno: la testimonianza di voler portare al gradino più alto un cinema altro, apparentato con il genere, privo di mezze misure e spesso relegato al ruolo di “invitato bizzarro” che partecipa a un festival.
Una decisione destinata inevitabilmente a far discutere, che nessuno inizialmente si sarebbe aspettato e che per capacità di sorprendere – tra età della regista e sfrontatezza del film – ricorda soltanto la premiazione di quel Sesso, bugie e videotape che lanciò la carriera di Steven Soderbergh. Non è di certo la prima Palma d’Oro della categoria “film che non so se raccomanderei a mia madre”, ma pellicole come Cuore Selvaggio, Pulp Fiction o The Square – per restare a lungometraggi fuori dai canoni di tempi più o meno recenti – erano comunque l’espressione di registi che avevano già conquistato una buona o persino ottima notorietà internazionale.
Dopo l’esordio con il cruento Raw – Una cruda verità, Ducournau prosegue sulla sua strada e realizza un nuovo film inscrivibile nella categoria del body horror sui generis, vicino a certe suggestioni cinematografiche debitrici del cinema di Cronenberg e Tsukamoto: la storia di una bambina vittima di un incidente automobilistico che riesce a sopravvivere grazie a una placca di titanio impiantata nel cranio e che crescendo instaura relazioni passionali con le autovetture.
Fin da queste poche righe, ma basti guardare il trailer, risulta chiaro come la regista insegua la combinazione di elementi che ha reso di culto molte pellicole controverse del passato: quel mix di turbamento e fascino, provocazione e disinteresse per il buon gusto, tipico di certo cinema instabile, esplosivo, diseguale nella riuscita e generoso negli shock che risponde apparentemente alla sola logica di fregarsene di tutto e tutti.
Ma se Titane è fin troppo consapevole e desideroso di essere inscritto in questa categoria, quanto ci sia di furbo o di genuinamente destabilizzante nella sua natura, che ruolo possa assumere nell’ambito di un cinema festivaliero sclerotizzato è tutta inaspettata materia di discussione gentilmente offerta da un regista, che tra uscite sui giornali e grinta battagliera non si è mai troppo interessato alle sfumature tra love and hate, impegnato con questo verdetto forse persino a scuotere se stesso e cercare di ricordarsi dei giorni elettrizzanti di Lola Darling.
Attraversando la cerimonia con l’imbarazzo dipinto sul volto per la gaffe, Spike Lee dunque ha finito per scrivere, involontariamente o meno, un finale facinoroso e imprevedibile che probabilmente è ciò che serviva al Festival di Cannes per poter sopravvivere dopo il trauma subito, proprio come la protagonista di Titane.
Tuttavia, accanto alla speciale piastra di titanio che quest’anno ha dato una speranza di nuova vita al festival, come sempre c’è l’oro che ha consentito a Cannes di brillare per svariati decenni: una lista dei vincitori che mette assieme il talento visivo di Leos Carax, premio alla regia per il suo cupo e affascinante Annette, e l’abilità di scrittura di Ryûsuke Hamaguchi, miglior sceneggiatura con Drive My Car, le capacità di attori giovani come lo statunitense Caleb Landry Jones e la rivelazione Renate Reinsve (attrice norvegese cuore pulsante di The Worst Person in the World), senza dimenticare l’overdose di premi ex aequo che ha posto vecchie conoscenze quali Asghar Farhadi e Apichatpong Weerasethakul accanto ai nomi di Nadav Lapid e Juho Kuosmanen.
Senza entrare nel merito dei giudizi sui film e sulle decisioni della giuria, compito sempre ozioso e fin troppo parziale a causa della limitata permanenza di chi scrive sulla Croisette, ci piace pensare che tutta la retorica della ripartenza, nonostante i mesi trascorsi durante il lockdown a consumare film sui nostri divani come comfort food, sia stata bruciata dalla criticabile impertinenza dimostrata da Frémaux e la giuria del 74esimo Festival di Cannes.
Nel segno di un cinema sporco e che osa senza paura di scadere nel ridicolo, smanioso di essere visto in sala a rischio di contagio, talvolta sterilmente provocatorio ma sempre appassionato nel raccontare per immagini, che divide e fa chiacchierare inutilmente come normalità comanda. E in questo viaggio che speriamo continui a far innamorare gli spettatori, esattamente come i protagonisti del road movie malinconico e sognante Compartment No. 6, forse il momento che durante la cerimonia di chiusura ha più di ogni altro ricordato di cosa è fatto il cinema è stato rappresentato dalla consegna della Palma d’Onore a Marco Bellocchio dalle mani di Paolo Sorrentino: un anziano signore dallo spirito di un ragazzino e un uomo maturo nato vecchio che parlano del fare cinema come momento di guerra con se stessi e atto di coraggio. Tutto ciò che serve per fare vero cinema, quello di cui abbiamo ancora bisogno.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente