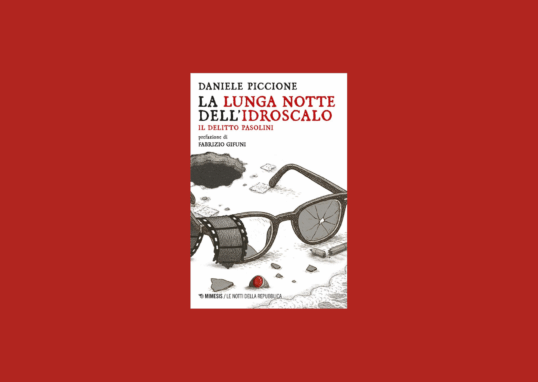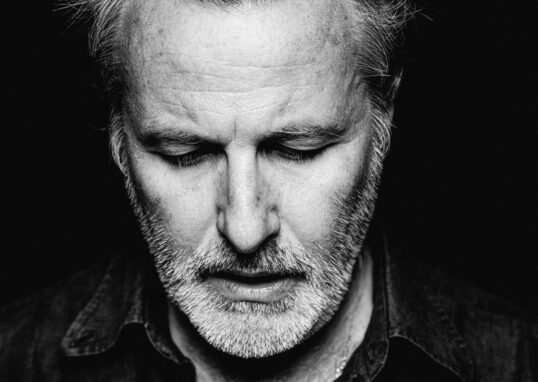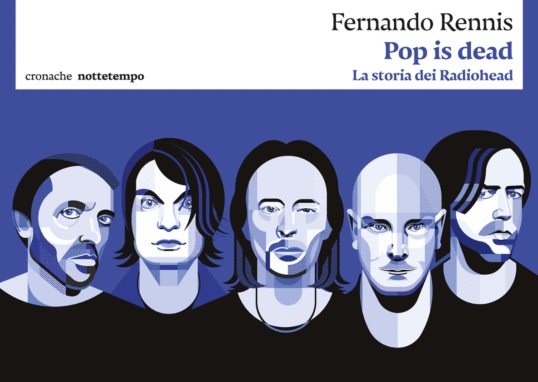“Sono una cecchina, una trapezista che esegue i suoi salti senza una rete sotto”, si descrive così durante un’intervista apparsa su Público Cristina Peri Rossi. Autrice di una quarantina di opere, ritenuta una delle voci maggiormente rilevanti della letteratura ispanica contemporanea, tradotta in oltre quindici lingue, divenne nota anche come traduttrice di Clarice Lispector e Monique Wittig. È anche grazie alla sua attività di traduttrice che rivela l’attenzione estrema riservata alla parola, resa attraverso un’inesausta ricerca linguistica che produce una voce letteraria irriverente inconfondibile.
Scelse di non fare mai parte di collettivi e conventicole, per esporsi sempre in prima persona in favore delle cause civili che a ottantatré anni continua a portare avanti anzitutto in poesia. L’intransigenza, la coerenza interiore, la volontà di non piegarsi a dinamiche editoriali o di altro genere, le costarono rifiuti e problemi, a partire dall’estromissione dall’ambiente intellettuale dell’Uruguay e la censura delle sue opere durante la dittatura militare, costringendola all’esilio in Spagna nel 1972, evento che rappresenta la dorsale della sua intera produzione poetica e in prosa.
Perseguitata anche dalla dittatura di Franco, per un periodo dovette trasferirsi a Parigi. In quell’occasione strinse un’amicizia fondamentale nel suo percorso, con Julio Cortázar, narrata successivamente nel libro Julio Cortázar y Cris (di quella complessa e intensa relazione permangono anche alcuni dei versi di Cortázar raccolti in Salvo il crepuscolo (trad. Marco Cassini, Sur).
Peri Rossi tornò in Spagna nel 1974 per stabilirvisi definitivamente. L’esordio era avvenuto un decennio prima, con il libro di racconti Viviendo, ma la vera celebrazione arrivò quasi sessant’anni dopo, quando nel 2021 ottenne il Premio Cervantes, il riconoscimento più prestigioso assegnato alla letteratura in lingua spagnola. Muovendosi tra generi diversi, dal giornalismo (scrisse per El País, La Vanguardia, El Mundo, tra gli altri) alla saggistica alla narrativa alla poesia, Peri Rossi continuò ad affrontare generi diversi con una prospettiva audace, definita anzitutto attraverso alcuni grandi ambiti di indagine: il significato dell’esilio, la labilità delle relazioni, il peso dei traumi, il rapporto con la memoria, l’identità sessuale. La matrice politica che permea la sua idea di letteratura risiede anzitutto nella lotta contro le dittature, nella causa transfemminista, nel pacifismo.
L’Italia ha riservato negli anni scarsa attenzione a Cristina Peri Rossi, fatta eccezione per l’uscita nel 1983 della raccolta di racconti Il museo degli sforzi inutili, ripubblicato oggi da Sur con traduzione di Vittoria Spada, e dell’ormai introvabile Le difficoltà dell’amore (La tartaruga), un’espressione caleidoscopica della complessità delle relazioni sentimentali. Pur avendo sondato generi e forme narrative diverse, Cristina Peri Rossi rinnovò costantemente una predilezione per la forma breve nel misurare le insidie del vivere.
Nei racconti pubblicati negli anni, sin dalle opere giovanili apparse sul finire degli anni Sessanta, sono riconoscibili alcuni aspetti che caratterizzeranno anche la produzione successiva, in particolare in merito allo studio del corpo, al rapporto con il desiderio, al significato dell’erotismo, alla crisi della società, all’alienazione generata dalla distanza interiore vissuta a seguito di traumi perenni, al modello tragico del mito, alla dimensione dell’infanzia, alla tensione alla decadenza, alla necessità di attingere a un peculiare immaginario fantastico per sondare gli inganni dei ricordi e gli enigmi del noto.
Ritrovare oggi in libreria i racconti di Cristina Peri Rossi permette di riconoscere la valenza civile di un’idea di letteratura retta su continue alterazioni del reale, su aperture fantastiche, su scorci teneri e crudeli, per scorgere la direzione dell’umanità, la solitudine dell’individuo. Il museo degli sforzi inutili studia il significato della distanza attraverso un gioco al contrasto tra continue trasfigurazioni della realtà per enfatizzarne gli esiti.
Sfilano sulla pagina anziane che scappano di casa sapendo che nessuno andrà a cercarle; archiviste di un museo che cataloga per anno le assurde imprese fallimentari degli esseri umani; adolescenti che eleggono un trespolo come eremo permanente; psicanalisti che si sfogano con le pazienti per analizzare la rabbia per il tradimento coniugale mentre la realtà, come un liquido, fuoriesce dal bicchiere; bagnanti immaginarie; stranieri costretti a maneggiare il loro vuoto; viaggiatori mai riusciti a partire riuniti in congresso all’aeroporto di Toronto; amanti delusi che vanno al banco dei pegni a comprare una fetta di tempo da mettere sopra le ferite per farle rimarginare.
In bilico tra farsa e tragedia, le sue storie definiscono un dialogo con l’assenza, narrano la perdita, annunciano l’istante che anticipa una disfatta ineludibile, intravedono la necessità salvifica di aggrapparsi al desiderio per rintracciare un senso al vivere: studiano la violenza, le nevrosi, il dolore, anche attraverso un’ironia dissacrante che si posa lieve su un quotidiano spesso surreale e all’apparenza imperturbabile.
Una temporanea esitazione sulle scale di una metropolitana può generare conseguenze inattese, come narra ne La crepa, dove un uomo arriva a dubitare della sua stessa esistenza a partire da un gesto mancato, un passo sospeso, un piede indeciso che non solo ha generato tra la folla dietro di lui rovinose cadute, piccoli furti, tentati stupri, perdite di parrucchini e dentiere e scambi di borsette, ma ha instillato un dubbio atroce. Dopo l’arresto per aver turbato l’ordine pubblico, durante l’interrogatorio una crepa sul muro attira l’attenzione del protagonista e lo induce a sostenere che in assenza di continuità non esiste altra realtà all’infuori del momento: “Il preciso momento in cui non aveva saputo se saliva o se scendeva e non gli era quindi stato possibile appoggiare il piede”.
Le variazioni allucinate generate da tale osservazione cadenzano interrogativi sulla nozione del tempo in relazione alla difficoltà a comprendere la realtà, rivelano le falle della memoria, una memoria inservibile, che “naviga, fa acqua”, intrappolata nel sotterraneo. La metafora della navigazione rappresenta una grande costante ritrovata anche nella produzione poetica, scelta per raffigurare l’assenza di riferimenti e il disorientamento esistenziale.
L’opera ispeziona la solitudine, gli esiti delle dipendenze emotive, con un continuo cambio di registro che attraverso l’ironia, il dramma, il ricorso al grottesco, evidenzia la miseria della natura umana. L’isolamento e l’incapacità di trovare nuove ragioni per vivere sublimati nell’ossessione per un acquario dominano L’effetto della luce sui pesci, che narra l’alienazione e il distacco dalla società civile, l’annebbiamento generato da un assillo che invade ogni spazio e tramuta drasticamente l’ordinario.
Ogni racconto è generato da una condizione di quiete apparente, di stanca quotidianità, che apre a stravolgimenti improvvisi e trova spazio nella dimensione onirica, abitata nel racconto Il senso del dovere, che solleva interrogativi sulla necessità di assoluzione personale di fronte al riconoscimento della propria inettitudine e del mancato impegno politico e sociale.
Studia il clima del sogno, la sua superficie desertica, le sue presenze indefinite e senza volto nel racconto La città, per soppesare gli aneliti sopiti, il ricatto del passato, l’intercambiabilità di simboli vacui.
Lo spazio del sogno è lo scenario d’elezione anche del racconto La pecora ribelle, dove un insonne tenta di addormentarsi seguendo il classico rituale della conta delle pecore. A stravolgere ben presto tale imperturbabilità notturna è il rifiuto espresso dal primo capo di bestiame del gregge immaginario. A nulla valgono i tentativi di convincere la pecora a saltare, nemmeno un bastone brandito per spronarla. L’uomo si chiede se lo steccato sia un limite e se il diniego delle sue pecore significhi non riuscire a essere padrone del suo gregge. Finisce per costringerle con la forza, e poco alla volta prende forma uno scenario orripilante, una questione di sopravvivenza tra l’uomo e l’animale, culminata nel gesto estremo che porta un’improvvisa pace interiore. Prova un desiderio violento e voluttuoso nell’affondare con le mani macchiate di sangue nella tiepida carne bianchiccia della bestia: “Quasi incollato alle viscere spappolate della pecora, ancora calde, stavo per addormentarmi come un bimbo ingenuo che non ha ancora saltato lo steccato bianco”.
Lo studio della violenza e delle tensioni agli antipodi che dominano la natura umana risuona in molti dei racconti della raccolta, nel ricorso al fantastico, al surreale, all’assurdo, per esasperare le conseguenze di assilli concreti. Lo studio del corpo, l’idea di cura, la necessità di supplire private mancanze sublimandole in ruoli, prendono forma anche attraverso tali espedienti, come accade nel racconto Parlare al muro, dove un uomo trova per strada una porta incosciente e priva di forze, descritta al pari di una donna in fin di vita dopo aver subito innumerevoli supplizi e crudeltà, che assiste amorevolmente e a cui parla per raccontarle la propria vita.
Il ricorso al fantastico caratterizza anche altri racconti dal tono ironico, come Punto fermo, per studiare la crisi delle relazioni sentimentali, l’euforia iniziale nel ricevere in regalo un segno di interpunzione in un elegante astuccio d’argento, a cui seguiranno la delusione, il tedio, i conflitti per futili ragioni, il rancore ostinato, inevitabilmente legati alla perdita del dono, che sancisce l’afflizione e annulla ogni proposito di ripresa.
Tutta la nostra precedente felicità è scomparsa, e sarebbe inutile pensare che possa tornare. Ma nemmeno riusciamo a separarci. Questo punto fuggitivo ci lega, ci annoda, ci riempie di rancore e disgusto, va divorando uno a uno i giorni passati, che furono così belli.
Il comico e il grottesco caratterizzano anche le pagine che esprimono l’impegno antimilitarista che da sempre caratterizza l’azione di Peri Rossi in testi che indagano la perdita, il rapporto con la morte, l’elaborazione del lutto in condizioni beffarde.
Il racconto Bandiere narra la cerimonia reiterata in ogni casa che prevede la ricezione di una bandiera in regalo per ogni uomo morto, condita da convenevoli e slogan patriottici spesi da ufficiali sul coraggio, l’onore, il servigio reso al paese, seguiti da un minuto di silenzio e dalla consegna del dono di cui sovente non si sa che farne, dove metterla, se appenderla, usarla come lenzuolo o come tovaglia, sopra la toletta. Quella bandiera simboleggia una malcelata derisione della perdita e innesca distorti meccanismi di appartenenza e sottili ricatti morali. La sua produzione arriva persino a generare un indotto, nel portare molte donne disoccupate a dedicarsi al confezionamento dei drappi. “Così la popolazione del paese è divisa in due grandi categorie: le persone dedite a confezionare bandiere e quelle destinate a riceverle”.
La lingua nelle opere di Cristina Peri Rossi perlustra gli spazi liminali, cela una malia che a tratti assume toni tetri, capace di posarsi lieve sui drammi e di concepire nuove frontiere dell’irrealtà, a partire dalla consapevolezza che “non esiste sintassi innocente”, come accade nel racconto Le strade della lingua, incentrato sulla particolarità di un rafforzativo che diventa il pretesto per analizzare il rapporto con lo spazio che si apre e gli abissi verso cui ci si può dirigere attraverso un’espressione esasperata.
Camminavo. Mi sentivo bene con il linguaggio. Camminavo; andavo e venivo senza una meta per i viali che si accendevano lentamente e, anche se andando si arriva sempre da qualche parte, sapevo che il mio andare portava solo all’interno delle parole, che è il luogo in cui mi sento al sicuro.
È lo scandaglio di quella dimensione estranea al noto a produrre uno stravolgimento e uno smarrimento che lambiscono una forma di virtualità necessaria a sollevare nuove domande sul nostro tempo, e a rendere profondamente attuali le istanze sollevate Cristina Peri Rossi.
Il ricorso a immagini mentali come elementi catalizzatori della scrittura, l’esplorazione del concetto di patria attraverso cui attestare fratture sociali, censure e distanze, l’analisi del significato interiore e condiviso dell’esilio, gli interrogativi sull’identità, le risorse del fantastico, il passo costantemente teso alla vertigine che rivendica una natura sospesa, portano a concepire l’intera produzione letteraria di Cristina Peri Rossi come un furente manifesto di libertà, e rendono la sua voce quella di una visionaria del futuro, per mutuare le parole di Novalis, capace di dare forma nei racconti a rappresentazioni al contempo profetiche e necessarie.
Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine letterario The FLR -The Florentine Literary Review.