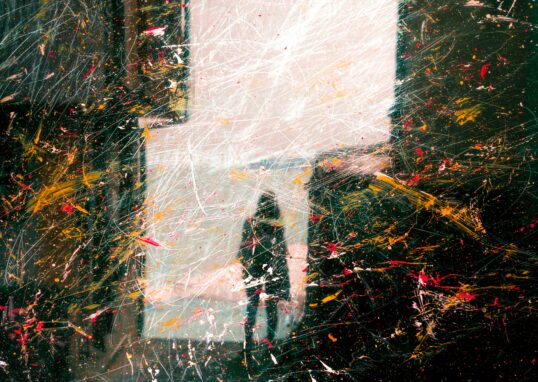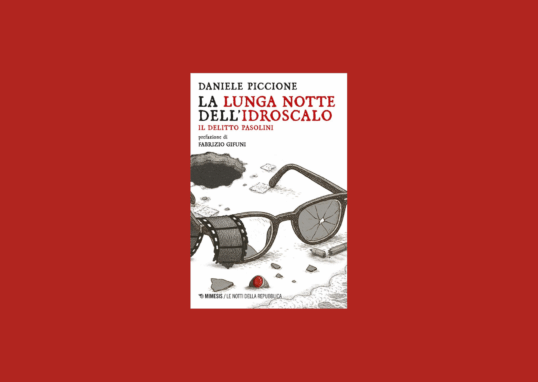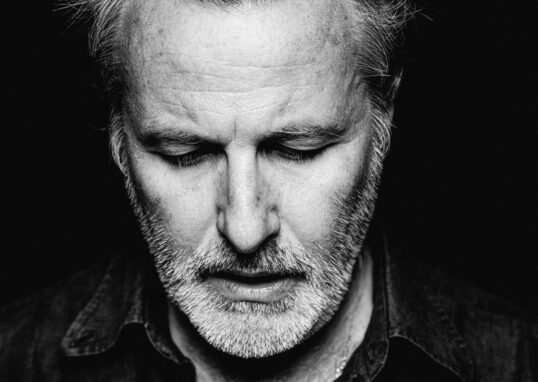Nell’agosto del 1914, il giovane Adolf Hitler si offre volontario per combattere nell’esercito bavarese, scrivendo una lettera al re Ludovico III di Baviera. La sua richiesta viene accettata immediatamente, e il giovane Adi – come viene affettuosamente ribattezzato dai suoi commilitoni per il suo aspetto minuto – viene inviato a combattere nella celebre battaglia di Ypres, in Belgio, nella quale nel giro di venti giorni morirono circa quarantamila soldati.
Nel pomeriggio del 22 aprile 1915 i soldati francesi videro una gigantesca nuvola verdastra che si avvicinava a loro lentamente, uccidendo tutto ciò che incontrava durante il suo passaggio: piante, animali, uccelli, uomini, insetti. Era una nuvola di gas cloro, un preparato predisposto dal chimico ebreo Fritz Haber, che aveva un potenziale micidiale, e che avrebbe segnato una svolta nelle tecniche di combattimento durante il Primo Conflitto Mondiale.
Siamo nel primo capitolo del libro Quando abbiamo smesso di capire il mondo, di Benjamín Labatut (Adelphi, 2021, trad. it. di Lisa Topi), intitolato «Blu di Prussia»: un libro singolare, costruito in maniera concentrica dal suo autore. Il libro riporta un quantitativo impressionante di fatti che ritornano gli uni sugli altri, ma non per fare chiarezza: al contrario, per dimostrare l’impossibilità di farla.
Si tratta, per ammissione dello stesso autore, di «un’opera di finzione basata su fatti reali», anche se le idee scientifiche che vi sono raccontate sono riportate in maniera pressoché fedele.
Il primo capitolo racconta la storia della creazione di un colore sintetico, appunto il blu di Prussia, inventato per errore all’inizio del XVIII secolo da un fabbricante di pigmenti svizzero di nome Johann Jacob Diesbach. Diesbach cercava in realtà di ottenere il carminio, ovvero un colore rosso ricavato dalla cocciniglia, ma insieme al suo assistente Johann Konrad Dippel (personaggio singolare,al quale si ispirò Mary Shelley per scrivere il suo romanzo Frankenstein) realizzarono un colore blu che rimpiazzò in pittura quello che si era usato fino a quel momento, il blu oltremare.
Labatut racconta questo aneddoto non tanto per le sue implicazioni artistiche (il nuovo colore fu impiegato per la prima volta nella Sepoltura di Cristo dell’olandese Pieter van der Werff per dipingere il velo della Madonna), ma per rendere conto di tutt’altro: l’invenzione del cianuro. In tutto il libro vengono raccontati decine di aneddoti interessantissimi, che sono in realtà il presupposto per parlare di qualcos’altro, e per dimostrare come molto spesso il progresso segua direzioni sghembe, che possono portare molto lontano dal punto di partenza o dall’obiettivo prefissato.
Nel 1782 il chimico Carl Wilhelm Scheele mescolò il blu di Prussia contenuto in un recipiente utilizzando un cucchiaio sul quale erano rimasti dei rimasugli di acido fosforico, e creò in tal modo il veleno più importante dell’epoca moderna, ribattezzandolo «acido prussico». Si tratta della componente basilare del cianuro, ovvero la sostanza utilizzata nei campi di sterminio tedeschi per uccidere gli ebrei, e poi dai nazisti per suicidarsi quando tra l’aprile e il maggio del 1945 le forze sovietiche stavano per entrare a Berlino e rovesciare il Terzo Reich.
Sono fatti come questo quelli che interessano Labatut; queste apparenti contraddizioni che testimoniano l’impossibilità di comprendere le cose in maniera univoca, e suggeriscono un universo complesso, del quale è arduo decifrare le leggi.
Come lo strano caso di Fritz Haber, il chimico che aveva messo a punto il veleno usato proprio nella battaglia di Ypres. Dopo l’armistizio, Haber fu dichiarato criminale di guerra e fuggì in Svizzera. Lì apprese la notizia della vittoria del premio Nobel per una scoperta compiuta molti anni prima. Nel 1907, Haber aveva trovato il modo di estrarre l’azoto direttamente dall’aria, risolvendo in maniera brillante il problema della concimazione delle piante, che a causa della carenza di fertilizzanti al principio del XX secolo rischiava di causare una grave carestia in tutto il mondo. In questo modo consentì alla popolazione terrestre di passare in meno di un secolo da 1,6 a 7 miliardi persone. In realtà con questa scoperta lo scienziato stava tentando di fornire alla Germania l’occorrente per la fabbricazione di esplosivi e polvere da sparo, ma questo conta poco.
Questo capitolo iniziale del libro sul blu di Prussia può apparire marginale rispetto agli argomenti di cui si tratta nel resto dell’opera, ma ha lo scopo di predisporci a un modo di pensare diverso, che sarà necessario per capire quello che verrà dopo.
Nei capitoli successivi si parla di alcuni degli scienziati più geniali degli ultimi due secoli, le cui scoperte misero in luce degli aspetti talmente sconvolgenti della matematica e della fisica che i rispettivi autori abbandonarono le loro carriere scientifiche e si ritirarono a una vita isolata e asociale, per proteggere l’umanità dalle conclusioni angoscianti delle loro ricerche.
Va detto che, per leggere il libro, non è rilevante che il lettore abbia una conoscenza scientifica approfondita di ciò di cui si parla. Anche chi, come me, ne sa poco di matematica e fisica può seguire facilmente ciò che si racconta. Basta avere un’idea generale dei concetti basilari di cui si sta discorrendo. Del resto, Labatut non fornisce troppe spiegazioni che aiutino il lettore ad approfondire la conoscenza degli argomenti trattati. Più che i concetti, gli interessano le conseguenze; più che le teorie, lo affascinano le ripercussioni sul modo di pensare; più delle conoscenze scientifiche, lo appassionano le discussioni che le hanno determinate.
Il cuore del libro è costituito dal quarto capitolo, il più lungo, quello che dà il titolo all’opera, «Quando abbiamo smesso di capire il mondo». In questo capitolo si raccontano le battaglie combattute nei primi decenni del secolo scorso per dare una sistemazione teorica al mondo subatomico con la cosiddetta meccanica quantistica.
Dopo che, per vari secoli, la fisica classica aveva elaborato delle solide teorie sul mondo macroscopico, su ciò che può essere visto e analizzato con strumenti anche particolarmente sofisticati, e vi aveva costruito sopra teorie complesse come quella della relatività, si poneva il problema di comprendere in cosa consistesse esattamente il mondo subatomico, che non può essere analizzato con la medesima facilità.
Furono presentate diverse teorie. Da un lato abbiamo Erwin Schrödinger, un fisico austriaco che mise a punto un’equazione bellissima e ancora valida sulla fisica quantistica e che gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1933. Secondo il racconto di Labatut, Schrödinger sviluppò l’equazione in una sorta di trance mistica, uscito dalla quale non riuscì più a ricordare i presupposti che lo avevano portato a formulare tale equazione. Schrödinger, che rielaborò le teorie del principe francese Louis-Victor Pierre Raymond, settimo duca di Broglie, sostenne che le entità del mondo subatomico fossero sia onde sia particelle, applicando concetti ben noti alla fisica classica.
Contro questa teoria combatté con veemenza Werner Karl Heisenberg, il quale asseriva che bisognasse «non solo calcolare, ma pensare in maniera quantistica», ovvero immaginare un mondo che non offriva nessuna certezza ma soltanto probabilità. Heisenberg, la cui teoria prese significativamente il nome di «principio di indeterminazione» non credeva nell’idea che il nucleo di un atomo potesse essere considerato alla stregua di una stella e gli elettroni come pianeti che le girano intorno. Nel mondo subatomico, la realtà non esiste al di fuori dell’atto dell’osservazione. «Un elettrone non si trova in nessun luogo fisso finché non lo si misura: appare soltanto in quell’istante». Un elettrone non si trova in un unico luogo e non ha una sola velocità. Heisenberg «aveva scoperto che alcune proprietà di un oggetto quantistico – come la posizione e la quantità di moto – erano accoppiate e obbedivano a una stranissima relazione. Quanto più precisa era l’identità di una di esse, tanto più incerta era l’altra». Tentando infatti di osservare la posizione dell’elettrone se ne alterava la quantità di moto e viceversa. Il mondo quantistico era un mondo dominato esclusivamente dalla probabilità.
Era, a tutti gli effetti, la fine del determinismo. Anche perché Heisenberg affermava che quei principi potevano applicarsi tanto al mondo subatomico quanto a quello macroscopico, con la differenza che gli effetti di tale teoria erano impercettibili per un corpo di dimensioni elevate, mentre erano enormi per una particella piccolissima.
Einstein non riusciva ad accettare questa interpretazione, perché riteneva che la fisica dovesse parlare in modo oggettivo, di cause ed effetti, non solo di probabilità. Ma dopo aver tentato senza successo di sollevare obiezioni alla teoria quantistica formulata da Heisenberg, espresse il suo dissenso pronunciando una frase che sarebbe diventata famosa nella storia della fisica: «Dio non gioca a dadi con l’universo!».
È un mondo che non siamo più in grado di capire. Facciamo ipotesi, ci basiamo su di esse e formuliamo teorie. A volte queste teorie funzionano, e sulla base di esse mettiamo a punto dispositivi che fino a un secolo fa sarebbero stati ritenuti miracolosi. «Quand’è che abbiamo smesso di capire il mondo?», si chiede Labatut. Probabilmente non è possibile stabilire un momento esatto in cui abbiamo cessato di credere a quello che vedevamo. Chi avrebbe mai pensato che a partire da un colore, il blu di Prussia, si potesse predisporre un veleno micidiale come il cianuro? Chi poteva ipotizzare che nel 1945 quella stessa sostanza, che sotto forma di Zyklon Baveva sterminato milioni di ebrei nelle camere a gas, sarebbe stata ingerita dai gerarchi nazisti per non essere catturati vivi dalle truppe sovietiche alle porte di Berlino? A chi poteva venire in mente che un criminale di guerra come Fritz Haber, dopo aver messo a punto un veleno micidiale che avrebbe falcidiato le truppe nemiche senza pietà, avrebbe vinto il premio Nobel per una delle scoperte più importanti del secolo scorso?
Se la realtà è ciò che noi percepiamo e la verità è ciò che esiste davvero, nella scienza moderna non è sempre facile comprendere se ciò che viene ritenuto vero sia anche reale. È un aspetto che ha ben descritto Michael Berry, professore di fisica presso l’Universitàdi Bristol, in un post apparso lo scorso anno sul blog Physics World, consultabile all’indirizzo https://physicsworld.com/a/true-but-not-real:
Non c’è nessuno specchio d’acqua che riflette la luce su una strada arroventata, nessuna fata morgana che si libra sull’orizzonte polare, nessun vostro sosia nello specchio, nessun omino dentro la vostra TV. Queste interpretazioni sono false, ma le nostre percezioni sono reali.
Mi viene da pensare che con la fisica avviene l’opposto. Confrontiamo le nostre teorie con l’osservazione e gli esperimenti, e se corrispondono (anche se talvolta in modo impreciso), noi dichiariamo legittimamente che le leggi fisiche sono vere. Ma la domanda «È reale?» rimane senza risposta.
Nella fisica classica il divario tra ciò che è vero e ciò che è reale è più ridotto. L’osservazione dei fenomeni è più semplice, e quando una teoria viene ritenuta vera è molto più facile che sia ritenuta reale anche dalla percezione dell’uomo. Nella fisica subatomica, più si scende in profondità e più le teorie sviluppate non corrispondono a fenomeni che possano essere percepiti direttamente dall’esperienza umana, ed è quindi molto più complicato stabilire se siano o meno reali.
Il divario che si è venuto a creare tra ciò che è vero e ciò che è reale è forse il punto a partire dal quale, secondo Labatut, abbiamo progressivamente smesso di capire il mondo.
Nell’epilogo del libro, intitolato «Il giardiniere notturno», ci troviamo in Cile, il paese natale dell’autore, in un villaggio che si popola solamente nei mesi estivi. Nel villaggio ci sono molti giardini, ma le piante stanno tutte morendo, infestate da un parassita invisibile che ne ha intaccato i tronchi e ha tinto di grigio il verde del fogliame. L’atmosfera è notturna, il clima mite, il male che sta divorando l’ambiente circostante sembra come magicamente addormentato. Il narratore, durante una passeggiata di notte insieme al proprio cane, incontra un giardiniere intento nelle sue attività. L’uomo gli spiega che è consigliabile eseguire di notte determinati lavori sulle piante, perché anche le piante dormono, e soffrono meno nel caso in cui si debba spostarle. Dopo aver chiacchierato un po’, l’uomo gli racconta di essere stato per metà della sua vita un matematico brillante, ma che a un certo punto aveva preferito abbandonare tutto e darsi alla botanica.
Il giardiniere sosteneva che «era la matematica – non le bombe atomiche, i computer, la guerra biologica o l’apocalisse climatica – che stava cambiando il nostro mondo, al punto che, nel giro di vent’anni al massimo, non saremmo più stati capaci di capire che cosa significa essere umani». Non solo gli scienziati, ma neanche la gente comune sarà più in grado di capire il mondo.
Fa l’esempio della fisica quantistica: sta alla base di internet e dei telefoni cellulari, eppure nessuno l’ha mai capita fino in fondo. Un complesso di teorie complicatissime che mette a dura prova la comprensione anche nelle intelligenze più luminose, e che fa perdere lentamente il contatto con la realtà, rendendo arduo stabilire se ciò che dalla scienza viene ritenuto vero possa essere considerato anche reale.
A un certo punto il narratore chiede al giardiniere come avrebbe potuto fare per capire quanto rimanesse da vivere al suo albero di limone. Il giardiniere risponde che l’unico modo per saperlo sarebbe stato quello di tagliare il tronco per contarne gli anelli. Ma chi farebbe mai una cosa del genere? Uccidere una pianta per vedere quanto le resti da vivere?
La stessa cosa forse vale per la scienza. Se per comprendere i principi matematici e fisici occorre sezionare la realtà per guardarci dentro, smontarne i meccanismi più minuscoli per decifrarne le regole a costo di infrangerne i congegni più delicati, forse conviene rinunciare e sfruttare le risorse del mondo senza tentare di capirle, per ciò che ci elargiscono naturalmente, senza indagare troppo sulle leggi che le governano. Mantenerle intere e goderne i frutti, gustarne la bellezza, curando, per esempio, le piante con amore, proprio come fa il giardiniere notturno.
O forse, nonostante tutto, è necessario rischiare, senza lasciarsi intimorire dalle difficoltà; indagare nei recessi più insondabili della materia, scalare i vertici più impervi dell’astrazione, osare vedere dentro alle cose, arrampicarsi sulla torre di Babele per conoscere i segreti del cielo, anche a costo di non riuscire più a comunicare, anche a costo di non sapere più nulla, anche a costo di non capire più il mondo.
Luca Alvino è nato nel 1970 a Roma, dove si è laureato in Letteratura Italiana. Nel 2025 ha pubblicato per Il Convivio la raccolta poetica Sono il poeta. Nel 2023 ha tradotto e curato per Interno Poesia un’ampia antologia delle poesie di John Keats, intitolata Mio cuore. Nel 2021 ha pubblicato, ancora per Interno Poesia, la raccolta poetica Cento sonetti indie. Nel 2018 è uscita per Castelvecchi la sua raccolta di saggi Il dettaglio e l’infinito. Roth, Yehoshua e Salter. Nel 1998 ha pubblicato con Bulzoni una monografia sull’Alcyone di Gabriele d’Annunzio, intitolata Il poema della leggerezza.