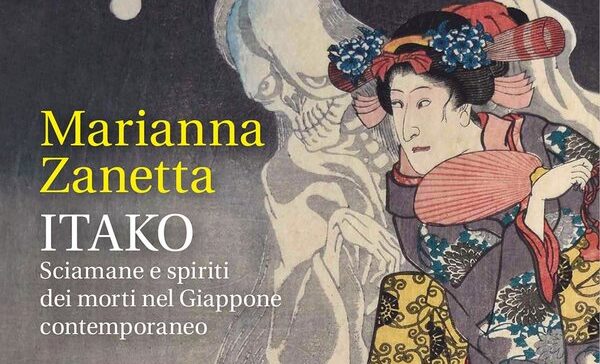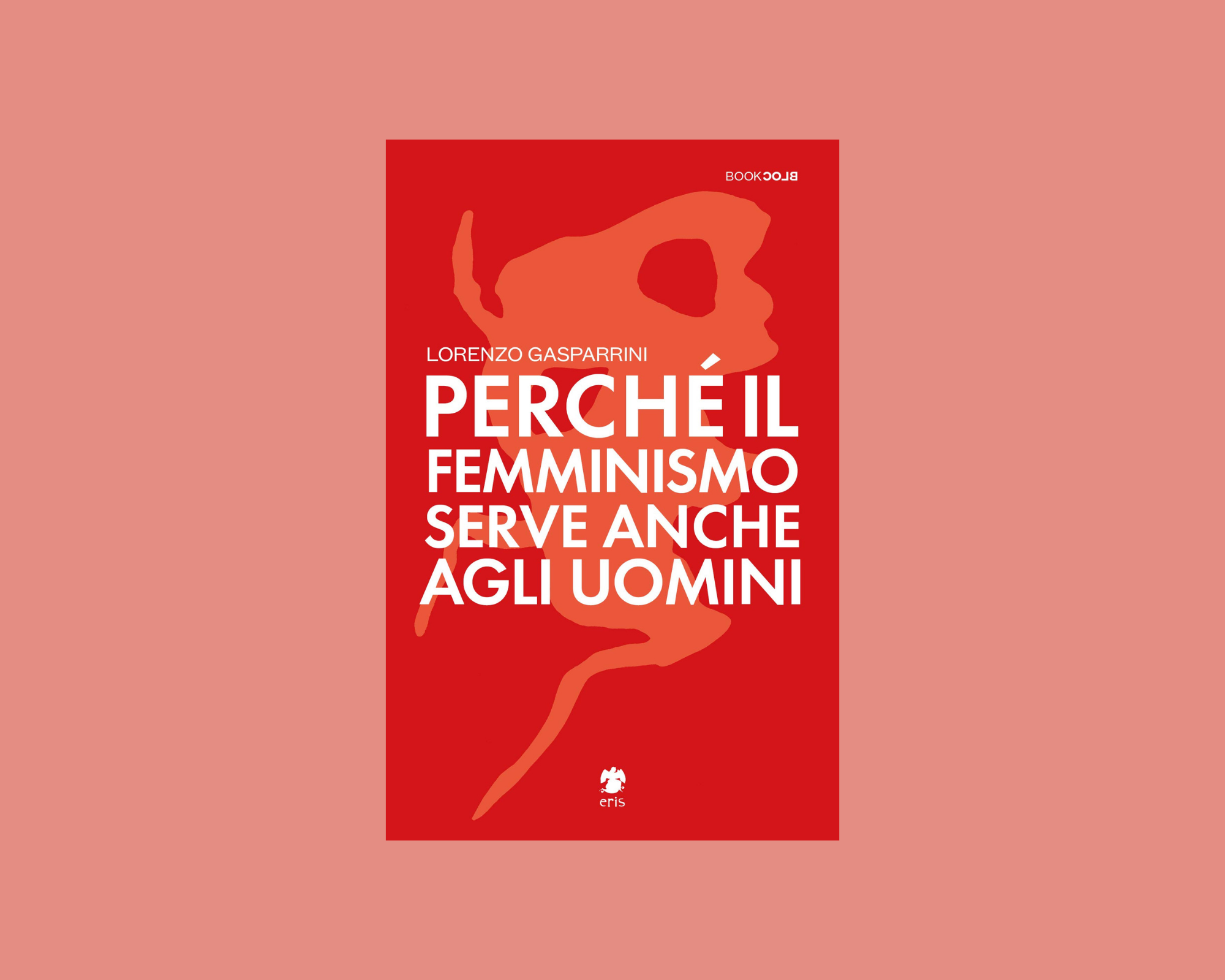Foto di Juanita Swart su Unsplash
Pubblichiamo un pezzo uscito su Specchio, che ringraziamo.
Il bosco avanza, cresce, si avvicina alle città. Animali di cui ci eravamo dimenticati, fuori da rappresentazioni antropomorfe dominate dal marchio Disney, compaiono nelle periferie delle metropoli, vanno a spasso per i vicoli dei paesi, si fanno riprendere e fotografare e qualcuno assegna loro addirittura nomi propri. Mentre ci siamo ormai abituati a notizie apocalittiche circa la distruzione del pianeta per mano dell’uomo, la natura riprende il suo assalto alla civiltà. Una contraddizione quasi paradossale se non fosse che in effetti è del tutto campata in aria. Perché ben altro sta accadendo. Un fenomeno complesso in cui si intrecciano narrazione, immaginario e realtà, che è argomento di studio e dibattito soprattutto per gli antropologi. Tre le questioni fondamentali. Me lo spiega Matteo Meschiari, antropologo e scrittore, professore di Geografia all’Università di Palermo, fra i primi in Italia a parlare di quella nozione ormai quasi abusata: l’Antropocene.
“Da un lato dobbiamo considerare la costruzione di un immaginario che è l’esito della cattiva coscienza della nostra specie rispetto alla crisi ambientale. Ci sentiamo responsabili per quel che sta accadendo e dunque immaginiamo un futuro di rinselvatichimento, come un deus ex machina ecologico. Si tratta di una visione utopica sostenuta da saggisti di provenienza anglosassone come George Monbiot (Selvaggi. Il rewilding della terra, del mare e della vita umana, Piano B). Viene detta “rewilding”. Rispetto alla “wilderness”, concetto dal lungo passato, è proiettata soprattutto nel futuro, anche se le sue radici sono antiche, perché già nel 1973 ne parlava Paul Shepard, di cui è in uscita per Meltemi Teneri carnivori. Cacciatori e selvaggina sacra, il suo capolavoro, un libro che spiega il collasso presente a partire da un passato remoto, quello dell’evoluzione biologica e culturale della nostra specie e quello dell’avvento dell’agricoltura. Dall’altro lato invece c’è chi come Gilles Clément sostiene l’idea del “Terzo Paesaggio”, un concetto formato per analogia con il “Terzo Stato”, per dire che esistono luoghi meno nobili, più umili, ma dai quali possiamo imparare molto. L’architetto di paesaggio dovrebbe infatti progettare contrastando la tradizione in cui l’uomo dà forma al suo giardino, e dovrebbe lasciare che la natura faccia il suo corso. Quello a cui assisteremmo sarebbe dunque la crescita di giardini selvatici. Una nozione che rappresenta bene la natura utopica di queste narrazioni”.
La realtà invece è un’altra. E diversamente da questi indirizzi di studio che hanno grande successo ma peccano di scarsa concretezza, Meschiari se ne occupa da sempre. “Concretamente, noi assistiamo a un fenomeno interessante. Sono tantissime le terre – soprattutto nelle periferie delle città e dei paesi – che gli agricoltori hanno abbandonato, vinti dalla “tecno-agricoltura”. Impossibile farcela, a meno che non si prendano accordi con i vari slow food. Impossibile competere con l’agricoltura di massa. Terre che fino agli anni Sessanta del Novecento erano coltivate, sono state via via abbandonate a se stesse. In trent’anni i campi sono stati ripresi dalla natura, in parte sono diventati boschi. E questo certamente contribuisce a sostenere l’idea che i boschi si stiano avvicinando e siano in costante crescita. Ma non è così”. Meschiari è molto chiaro e conosce benissimo l’obiezione che sorge spontanea: se questi piccoli boschi non rappresentano un cambiamento significativo, tuttavia è reale e anche molto impressionante la vicinanza di animali che una volta erano relegati in una sorta di altrove e sostanzialmente invisibili. Ci eravamo abituati all’idea che il lupo vivesse molto lontano da noi e questa era anche la chiosa a storie per bambini di cui si ripeteva la natura fiabesca, tanto per tranquillizzarli. Adesso questa nuova vicinanza del selvatico ha cambiato radicalmente il nostro modo di vedere le cose.
Meschiari ascolta, però non è così convinto. “Si tratta certo di realtà nel senso che ogni immaginario e ogni narrazione hanno la loro realtà. Peraltro in questo caso indubbiamente è accaduto qualcosa di nuovo. I cinghiali che scorrazzano per le vie di Roma, i lupi nella Pianura Padana, i cervi, i daini, gli orsi. Ma il motivo non sta nella crescita dei boschi e nell’avvicinarsi del selvatico a spese della città. Il vero motivo è sempre la crisi ambientale e il cambiamento climatico, perché l’erosione degli ecosistemi naturali spinge gli animali lontano dalle loro terre, non per riconquista, ma per disperazione. Al tempo stesso però questa presenza animale sposta il confine simbolico del bosco. Con il loro progressivo e incessante avvicinarsi, gli animali si fanno quasi araldi, portatori di selvatichezza e creano in noi l’idea che il bosco si stia spostando oltre i suoi confini reali e sia arrivato a invadere le città. Insomma, il loro spostamento, dovuto a altri fattori, sembra raccontarci lo sconfinamento del loro ecosistema nei nostri confini, i confini dell’umano”.
E dunque ciò che conta è sempre e comunque la crisi ambientale? “Certamente. La realtà è che, nonostante piccole crescite qua e là, i boschi diminuiscono ovunque. E queste di cui parliamo sono solo narrazioni della cattiva coscienza, al meglio favole della buonanotte per impedirci di guardare in faccia una situazione irrecuperabile. Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Non facciamo nulla per cambiare le cose. E intanto le grandi foreste amazzoniche vengono distrutte per sempre. Il bilancio globale ci dice che intere regioni alberate stanno scomparendo in America Latina, soprattutto in Brasile. Figuriamoci quanto conta un boschetto che si è ricreato nella periferia delle nostre città. Però è molto interessante come noi reagiamo. Perché appunto la nostra cattiva coscienza ci spinge a interpretare questi fenomeni così poco significativi per edulcorare il disastro a cui stiamo andando incontro. Lo stesso avviene di frequente con il clima. Sappiamo bene del riscaldamento globale. Ora, il clima impazzito porta spesso a fluttuazioni scomposte che a volte si manifestano in un freddo improvviso e incongruo, come una nevicata primaverile nei paesini delle Madonie. Interpretiamo questo freddo come un fenomeno positivo, che contrasta il riscaldamento globale ma ne è invece la conseguenza diretta”. E lo stesso facciamo con quest’idea del bosco che avanza e degli animali selvaggi che entrano in città? “Certo. È esattamente la stessa cosa. Guardiamo quel piccolo fenomeno per distogliere gli occhi da ambienti che l’uomo ha distrutto definitivamente perché non potranno rigenerarsi. Inutile dire ancora che bisognerebbe lavorare sul clima. È diventata una lamentela che annoia chiunque. Si sa da trent’anni e non si è fatto nulla di concreto. Le emissioni di anidride carbonica continuano a essere troppo alte. La conseguenza è la desertificazione. Ecco cosa cresce davvero. Il deserto”.
Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha pubblicato con Ponte alle Grazie i romanzi Sono comuni le cose degli amici (2009, finalista al Premio Strega), Il toro non sbaglia mai (2011), È giusto obbedire alla notte (2017, finalista al Premio Strega), e il saggio narrativo L’abisso di Eros (2018). Con Einaudi ha pubblicato traduzione e commento del Simposio di Platone (2009) e i saggi narrativi Le lacrime degli eroi (2013), Achille e Odisseo (2020), Il grido di Pan (2023). Per HarperCollins sono usciti il romanzo Sono difficili le cose belle (2022) e il saggio narrativo Sognava i leoni. L’eroismo fragile di Ernest Hemingway (2024). I suoi racconti sono apparsi in riviste, antologie e ebook (come Mai, Ponte alle Grazie 2014), mentre i reportage di viaggio e le cronache letterarie escono su La Stampa e L’Espresso. Cura un sito di cultura taurina: www.uominietori.it