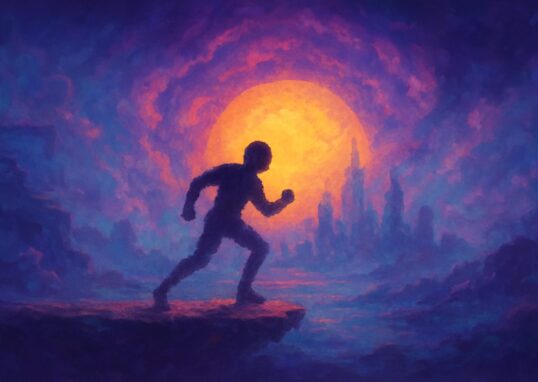di Rosa Maria Di Natale
Le migliori risposte alle domande più difficili spesso arrivano dalla letteratura. Solo che questa si diverte a camuffarle, a confonderle con altre o a diluirle nel tempo.
Qualche volta le risposte della letteratura si moltiplicano tanto quanto le possibili domande.
Cos’è, per esempio, la diversità?
Quando ho iniziato a scrivere il mio romanzo Il silenzio dei giorni (Ianieri edizioni), che ho infine dedicato “Ai diversi di ogni tipo e a ogni tipo di sopravvissuti”, avevo in mente solo alcune fasi della mia storia, liberamente ispirata al cosiddetto “delitto di Giarre” del 1980. Nel fatto di cronaca realmente accaduto, due giovani omosessuali vennero trovati uccisi ai piedi di un albero, ancora abbracciati. A me interessava capire perché avevano pagato un prezzo così alto a causa della loro diversità (erano gli “ziti”, ossia fidanzati innamorati in una provincia sicula di 40 anni fa, chiudete gli occhi e immaginateli), e come si era arrivati sino a quel punto di omofobia e rifiuto.
Mi premeva scrivere una storia completamente inventata, eppure figlia di quella storia vera.
Sono partita da quello che mi pareva più urgente e cioè raccontare una comunità provinciale assolutamente realistica negli anni ‘70 in Sicilia orientale. Il paesino dove tutto avviene l’ho chiamato Giramonte; non esiste, ma è il patchwork fedele della provincia sicula di quegli anni, viva e calda ai piedi del vulcano Etna.
Una volta terminato, il manoscritto ha trascorso molti anni nel cassetto e solo dopo essermene veramente distaccata, ho capito da dove mi sono giunte le risposte che cercavo. E che sono riuscita in qualche modo a fissare nelle mie pagine.
E dunque cos’è la diversità?
È la metamorfosi uomo-donna di Orlando secondo Woolf, o la passione decadente del vecchio von Aschenbach che si tinge i capelli per amore di Tadzio, o è la governante suicida perché si scopre lesbica, nell’omonimo racconto di Brancati?
Oppure è la bruttezza della Bestia di Perrault, o la remissività del disabile Ranocchio in “Rosso Malpelo” di Verga, o magari il sordomutismo “dotato” di Marianna Ucrìa? O forse il vero diverso è il ribelle solitario impiccato in Se questo è un uomo, il deportato che prima di morire grida : “Compagni, Io sono l’ultimo”. E gli altri prigionieri abbassano la testa in silenzio, confermando la loro passiva distanza dal suo eroismo.
Forse la presunta normalità non fa parte delle nostre variegate esistenze e la letteratura ce lo mostra in mille modi.
La complessità che spaventa: omofobia e onore
“Ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico nella sua struttura fisica. È fatto in un modo diverso anche nella sua combinazione spirituale. Quindi tutti gli uomini sono a loro modo anormali – rispondeva amabilmente Ungaretti al Pasolini di Comizi d’amore, salvo poi chiamarlo “pederasta” nel privato epistolare – Tutti gli uomini sono, in un certo senso, in contrasto con la natura”.
Troppo spesso la Storia non guarda benevolmente a questa complessità descritta da Ungaretti; anzi finisce per banalizzarla, perché troppo difficile da gestire.
I diversi sono infatti portatori di cambiamento e questo può diventare un problema. Un po’ come le donne che decidono di contare di più.
Non è un caso che omofobia e sessismo vadano di pari passo. Odiare l’omosessuale che in qualche modo si allontana dai gusti che si pensano appropriati o strettamente appartenenti al proprio genere, è già un atto di sessismo.
Mi viene in mente la famosa ripartizione in cinque tipi degli umani, secondo il mafioso Don Mariano Arena ne Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Don Mariano è il boss locale con una visione ben precisa del mondo suddiviso in uomini, mezz’uomini, ominicchi, i “(con rispetto parlando) pigliainculo” e i quaquaraquà…
Specificando che i pigliainculo “vanno diventando un esercito…”
Don Mariano usa questa classificazione per spiegare al capitano Bellodi il proprio codice d’onore.
Anche l’onore è una delle chiavi che la letteratura ci offre per svelare i legami tutti italiani tra la cosiddetta diversità e la violenza che spesso le si rivolta contro.
Sciascia è piuttosto chiaro.
L’onore sarebbe prerogativa degli “uomini veri” che di certo non sarebbero mai sessualmente passivi. È quello stesso onore, probabilmente tutto italiano, che storicamente portò gli italiani ad abrogare solo nel 1968 il reato d’adulterio e addirittura nel tardo 1981 anche il delitto d’onore.
Ancora una volta la letteratura ci aiuta a dipanare la matassa anticipando la Storia.
L’idea dell’onore che oggi, più che ricordarci l’irreparabile offesa, sembra rimandare alla reputazione sociale e digitale (controlla su Google cosa si dice di te e otterrai il riflesso di ciò che gli altri si aspettano dal tuo io sociale) in Italia ha avuto molto a che vedere con la potenza sessuale.
Pure in quel caso è stata la narrazione a venirci incontro, anche grazie al cinema italiano.
Chi può dimenticare Giovanni Arpino con il suo drammatico Un delitto d’onore e dunque la commedia di Pietro Germi del Divorzio all’italiana?
Quando Mastroianni diede volto e voce al protagonista, ancora una volta siciliano, e cioè il barone Ferdinando Cefalù, riuscì ad imprimere un dirompente effetto tragicomico alla pellicola. Cefalù è annoiato dalla moglie e terribilmente invaghito della cugina ancora adolescente, e con la sua vestaglia elegante e la retina in testa convinse il pubblico di mezzo mondo proprio per questa immagine ridicola e insieme drammatica di un certo Meridione retrogrado e al contempo colmo di bellezza senza tempo.
Ma in quel film c’è anche l’Italia sessista e provinciale vista con gli occhi di Germi dove nella sezione del PCI gli uomini ballano con altri uomini, o dove il finale fa scandalo per via del bikini conturbante della giovanissima Stefania Sandrelli.
Diversità, fascinazione e nuovi percorsi
In “Ciàula scopre la luna” di Pirandello il diverso è invece un misero malato di mente che sgobba nella miniere della Sicilia rurale post unitaria. Eccola la diversità: è l’incapacità di percepire la violenza subita come sopruso, è lo spaesamento di fronte all’ovvio; è l’estasi bambina di Ciàula di fronte alla scoperta della luna.
Ma per piombare con un gran salto sino ai giorni nostri, anche la Lila della tetralogia de L’amica geniale di Elena Ferrante è decisamente una diversa sprezzante delle regole imposte dal patriarcato, manipolatrice ma anche vittima, insofferente della sua Napoli degradata (ancora una volta il nostro Sud letterario) e al contempo sua comprimaria.
Ciàula il siciliano scemo e Lila la napoletana geniale potrebbero essere due facce della stessa medaglia perché entrambi sono testimoni viventi di una realtà ben diversa da quella che si vuole fare credere. Scombinano le carte in tavola. Sono personaggi attraenti.
Ma alla fine, è l’autore che muove i fili dello svelamento. È l’autore che illumina una strada per comprendere cosa sia la diversità e quale possa essere il percorso per apprezzarne le luci e le più profonde fascinazioni.
Di esempi analoghi o migliori di quelli appena citati ce ne sarebbero in gran quantità.
L’altra domanda che mi preme è: che tipo di narrazione ci aspetta oggi rispetto al tema della diversità?
Una possibile chiave potrebbe essere una nuova lettura del reale, o una riscrittura di quanto è già accaduto nella realtà cercando di accendere una luce e trovare spiegazioni, radici, tracce di un passato trascorso, oppure per nulla cancellato.
Raccontare la diversità apre la porta a una miriade di mondi. Alcuni sono stati sotto il nostro naso per secoli e forse non ce ne siamo avveduti abbastanza. Altri dobbiamo ancora scoprirli.
È anche necessario tenere conto dell’ammonimento di Giuseppe Pontiggia in Nati due volte. Il romanzo fa riferimento alla diversità dell’handicap ma la sottolineatura potrebbe valere per ogni tipo di diverso.
“La normalità – sottoposta ad analisi aggressive non meno che la diversità – rivela incrinature, crepe, deficienze, ritardi funzionali, intermittenze, anomalie. Tutto diventa eccezione e il bisogno della norma, allontanato dalla porta, si riaffaccia ancora più temibile alla finestra. Si finisce così per rafforzarlo, come un virus reso invulnerabile dalle cure per sopprimerlo. Non è negando le differenze che lo si combatte, ma modificando l’immagine della norma”.
Per chi scrive, non resta che nutrirsi di belle storie e scegliere tra le centinaia di chiavi disponibili per raccontare la diversità. Personalmente non ho risposte precise e neppure definite, ma se qualcosa sono riuscita a ricavare è merito della letteratura.
E a proposito di chiavi narrative sulla diversità, o sulle differenze, o su provvidi straniamenti, mi scappa un’ultima domanda.
Chi era quello che diceva che “dove c’è bellezza c’è compassione”?
_
Rosa Maria Di Natale è giornalista e scrittrice. Il suo romanzo “Il silenzio dei giorni” (Ianieri edizioni) liberamente ispirato al “delitto di Giarre” del 1980, è uscito nel maggio 2021.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente