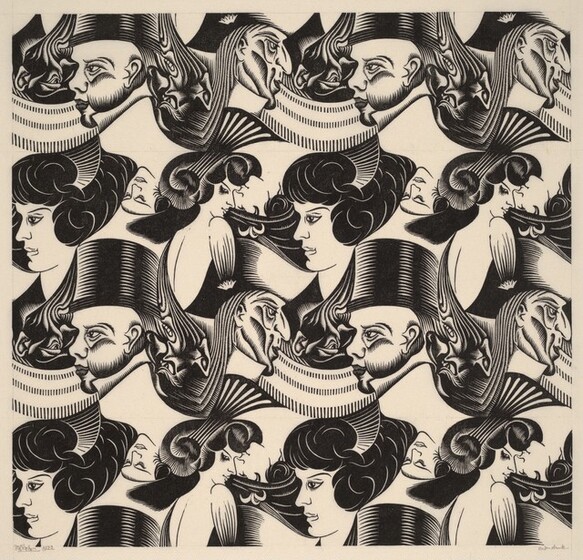
Pubblichiamo, ringraziando la rivista e l’autrice, l’intervista di Giada Ceri a Luigi Lombardi Vallauri uscita sul numero 292 di “Una città”. Si tratta della settimana di una serie di interviste di Giada Ceri a persone variamente impegnate nell’ambito penitenziario.
***
A differenza che nella giustizia retributiva, fondata sul “male contro male”, portatrice di una sua crudeltà consustanziale e dove la vittima non esiste, in quella riparativa la vittima diventa addirittura giudice e può chiedere tutto o anche niente; in un contesto di privazione della libertà del corpo, l’importanza di salvaguardare la libertà intenzionale, la più importante, e di recuperare il desiderio di beni non esclusivi. Conversazione con Luigi Lombardi Vallauri.
Luigi Lombardi Vallauri è stato professore ordinario di Filosofia del diritto presso l’Università di Firenze dal 1970 al 2011. Dal 1976 al 1997 ha insegnato la stessa disciplina all’Università Cattolica di Milano, da cui è stato espulso per eterodossia (provvedimento dichiarato illegittimo nel 2010 dalla Corte europea di Strasburgo). Nel 1979 ha fondato il Gruppo di Meditazione, tuttora attivo, che costituisce la sua seconda famiglia. La prima consta di cinque figli e undici nipoti.
Giada Ceri: La natura afflittiva dell’istituzione penitenziaria si esprime fin dal suo nome. Penitenza, pena, dolore. E noi bravi cittadini che viviamo fuori dal carcere, scrivi nel tuo libro Crudeltà (Doppiavoce, Napoli, 2021), dovremmo provare a immaginare il dentro e a sentirlo sulla nostra pelle. Ti riferisci alla percezione di uno spazio chiuso nel quale l’orizzonte è tagliato, il tempo scorre vuoto, sono assenti non soltanto i progetti per il futuro, ma addirittura il futuro. Del carcere scrivi che è un luogo «considerato la pena meno crudele tra quelle finora escogitate; crudeltà che si aggrava all’estremo nell’ergastolo e in alcune forme repressive assunte – per esempio in base all’articolo 41bis – dal perseguimento della massima sicurezza. È una crudeltà strutturale, struttural-funzionale, una crudeltà delle cose stesse, indipendente da eventuali attitudini o atti di crudeltà soggettiva degli operatori carcerari».
Luigi Lombardi Vallauri: Che il carcere sia crudele è un dato di fatto. Però, al tempo stesso, come ogni cosa, il carcere è sottoposto a quello che io chiamo il principio super-supremo dell’ordinamento giuridico, che risulta dal combinato dell’articolo 3, II comma [«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»], e dell’articolo 9 integrato, quello sulla bellezza del mondo [«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»]. Come norme sul carcere abbiamo il ben noto articolo 27 [«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»], che però sta sotto il principio super-supremo del pieno sviluppo della persona nel contesto della bellezza del mondo: il carcere viene giudicato nella misura in cui promuove il pieno sviluppo della persona e cerca di creare al proprio interno un contesto simile a quello della bellezza del mondo.
GC: Quello di cui parli è un orizzonte molto lontano dalla realtà dei nostri istituti penitenziari. Eppure nella Costituzione italiana la parola carcere non compare mai e non casualmente si parla al plurale di pene, non di pena. Ovvero: esistono altre possibilità, per chi ha commesso un reato, oltre a quella di essere recluso. Mi riferisco alla restorative justice, un’idea di giustizia molto diversa da quella del nostro Paese, che è ancora essenzialmente retributiva.
LLV: Si tratta di sostituire alla triade processo-condanna-prigione la triade mediazione-incontro fra l’autore del reato e la vittima-riparazione. Nella giustizia retributiva il ruolo della vittima è pari a zero: la vittima ha soltanto la “soddisfazione” di sapere che l’altro soffre. Invece, l’incontro occhi negli occhi permette al colpevole di comprendere il male che ha fatto e alla vittima di comprendere le ragioni che lo hanno condotto a farlo. Penso al libro di Elvio Fassone [Fine pena ora, Sellerio, 2015]: il detenuto, omicida che veniva dal Bronx di Catania, e colui che lo aveva condannato all’ergastolo si sono scritti per ventisei anni. Da poco è nata un’associazione di persone che si occupano di uomini maltrattanti che stanno in prigione, il Centro studi trattamento agire violento, di cui recentemente è stata inaugurata la sede a Torino. Esistono anche i problemi degli uomini maltrattanti, non solo quelli delle donne maltrattate.
GC: Questo modo di affrontare la questione dei reati e delle loro conseguenze presuppone che l’attenzione si sposti sulle relazioni che esistono o possono ristabilirsi fra le persone.
LLV: Sì, assolutamente. Mentre la giustizia retributiva è una copia della cosiddetta giustizia divina, in cui c’è solo la commisurazione della gravità del male compiuto al male inflitto dallo Stato al reo, male contro male, del tutto indipendentemente, direi, dalle persone. Come nell’Inferno di Dante. È tutta roba che viene dalla teologia. La giustizia retributiva carceraria, come quella precedente, è diversa dal vecchio guiderdone, il vecchio compiere atti utili alla vittima. Nella giustizia retributiva la vittima non esiste. Nella giustizia riparativa, invece, la vittima diventa un co-giudice, se non addirittura il giudice. Può chiedere cose spropositate, ma anche niente, e forse neppure niente è giusto. Il Libro dell’incontro [di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato, Il Saggiatore, 2015] racconta quello che hanno fatto Claudia Mazzucato e altri per circa dieci anni, con importanti garanzie, con i parenti delle vittime della lotta armata e gli autori dei reati, che si incontravano in Piemonte, in una casa dei gesuiti appartenuta al re di Sardegna. Io sono stato lì una volta. Agnese Moro in cucina lavava i piatti con gli assassini di suo padre… Ci sono state delle scene terribili, occhi negli occhi. Così la prospettiva della giustizia penale cambia completamente.
GC: È una prospettiva, quella di cui parli, che presuppone un livello molto alto, quanto meno di consapevolezza, nelle persone.
LLV: E la loro disponibilità. Con i mafiosi, per esempio, non è possibile. Non si sottopongono a nessun tipo di mediazione.
GC: Con loro allora che cosa si fa?
LLV: Si fa il carcere normale. Comunque la giustizia riparativa sta guadagnando terreno.
GC: Nel frattempo, come si è detto, la nostra giustizia mantiene un impianto essenzialmente retributivo. Di più: dato lo stato di molte delle nostre prigioni, possiamo affermare che la pena carceraria è rimasta una punizione di fatto corporale e non soltanto la sua abolizione, ma anche la sua riduzione a extrema ratio appare molto lontana nella prospettiva attuale della giustizia di questo Paese.
LLV: Se rimane il carcere, la libertà viene ridotta drasticamente. Tutte le libertà vengono ridotte: quella motoria, quella sensitiva, quella intenzionale, come la chiamavano gli scolastici (la fantasia-memoria, cioè la capacità di immaginarsi cose assenti o possibili), e infine la libertà intellettuale, che è trascendentale, perché l’uomo si estende a tutto, è in qualche modo tutte le cose, come diceva Pico della Mirandola e già prima di lui san Tommaso. Detto ciò, visto che il carcere è per definizione riduzione della libertà, si pone il problema di vedere quale libertà può sopravvivere in base ai due principi costituzionali che ho citato. Rimane un po’ di libertà intenzionale, quindi culturale. Mi riferisco a una cultura che può essere attiva – disegno, pittura, teatro… – oppure ricettiva – la lettura, per esempio. Cambia, fra le due, la partecipazione del corpo.
GC: Corpo che in carcere viene ampiamente sacrificato. Non penso solo alle questioni più eclatanti, per esempio gli atti di autolesionismo e i suicidi, ma anche alla salute fisica e psichica, che in carcere si deteriora, o all’amputazione della dimensione sessuale e, più in generale, alla difficoltà, per chi vive in stato di detenzione, di mantenere e coltivare le relazioni personali e familiari… Ma torniamo ai libri.
LLV: Io dei libri faccio insieme un inno e un ridimensionamento. Un libro che ha lo stesso spessore di un mattone contiene un mondo. Ma leggere – come scrivere – nega il corpo, al quale invecchiando sono sempre più sensibile.
GC: Il libro come mondo può almeno in parte compensare l’assenza, in carcere, dell’esperienza del mondo esterno. Tu, che ti definisci un animale dell’aperto per il quale anche la casa e la città sono una prigione, in prigione hai portato la meditazione.
LLV: Sono stato qualche volta in carcere per cercare di insegnare meditazione ai reclusi di una sezione speciale di Sollicciano, cioè a mafiosi. Nel mondo incredibilmente ridotto di cui loro disponevano c’erano comunque qua e là fili d’erba alle finestre. Io dicevo: Se voi toccate questo filo d’erba, toccate il discendente di una linea ininterrotta che risale all’origine dell’universo. Voi toccate tre miliardi di anni di storia generativa ininterrotta. Nella reclusione del carcere irrompevano miliardi di anni, i reclusi toccavano l’origine dell’universo.
GC: E come reagivano?
LLV: Erano disponibili a questa specie di vita contemplativa. Ora, il livello più alto della libertà è quello della libertà intenzionale, non solo sensitiva o immaginativa, ma intellettuale e diciamo pure spirituale. Quindi la cultura crea nell’uomo un ambiente intenzionale che in termini filosofici classici si può dire trascendentale, cioè si estende ad totum ens, a tutto l’essere. Questo ambiente interno, intenzionale, trascendentale è enormemente maggiore dell’ambiente materiale circostante, come dimostra il fatto che molte carceri sono ex conventi (per esempio quello delle Oblate di Firenze), ex monasteri, in cui lo spirituale-culturale era al suo più alto livello. Tutti i grandi ordini contemplativi prima dei mendicanti erano totalmente privati della libertà di movimento. I benedettini facevano voto di stabilità, di non uscire cioè mai nella vita dal monastero. I certosini erano dei reclusi a vita. I Sette Santi di Firenze lasciarono il cosiddetto saeculum e andarono a vivere a Monte Senario ognuno in una grotta piccolissima, molto più piccola di qualunque cella carceraria. L’ambiente spirituale, trascendentale, può essere perfettamente vissuto anche in celle minuscole. E così anche il vuoto appetitivo-affettivo, quello dei sentimenti. Per esempio, il motto latino del beato Alessio Falconieri iscritto nella sua grotta a Monte Senario dice: “Beato Alessio Falconieri, crocifisso al mondo e pasciuto delle delizie celesti, qui a lungo visse nel nascondimento”. In quel tempo c’era anche la ricerca della negazione totale del mondo, come nello yoga di Patanjali la cosiddetta chiusura della porta dei sensi. Tornando al carcere, che riduce tutti i tipi di libertà, facciamo che almeno riduca il meno possibile la libertà intenzionale. I detenuti non sono allenati e non si rendono conto di queste possibilità formidabili della clausura. Però la libertà fisica, motoria, è molto importante per la maggior parte dell’umanità. Imparando a fare yoga anche rimanendo reclusi in una cella di un ex convento potrebbero salvarsi almeno un po’.
GC: In molti discorsi sul carcere si punta l’attenzione su ciò che il carcere può e dovrebbe fare. Mi pare invece che tu, data la realtà delle prigioni che abbiamo in Italia, ti aspetti più dal singolo individuo e dalla sua capacità di non farsi annichilire che non dall’istituzione carceraria.
LLV: Sì. Io auspico che venga sostituita il più possibile la prigione, ma ci troviamo in un sistema di prevalente pena retributiva, e solo agli inizi di una giustizia riparativa.
GC: Il carcere non può cambiare, secondo te?
LLV: Potrebbe cambiare sottoponendo l’articolo 27 della Costituzione alla coppia formata dall’articolo 3, II comma, e dall’articolo 9 integrato. Questa coppia giudica tutto, anche l’uso dell’automobile.
GC: E questo è possibile terrenamente?
LLV: Io coltivo il principio secondo cui l’utopico è la cosa più utile. La storia è una storia di utopie realizzate. Se punti sul vincente, sei tendenzialmente superfluo. Non solo. Il successo non è assolutamente un criterio di valore: il successo è un fatto. Nessuna tradizione spirituale che conosco afferma che si deve giudicare il valore in base al successo. Quindi, anche ammesso che tutto quello che stiamo dicendo sia utopico, lo diciamo lo stesso. Si realizzerà? Non lo so. In genere dico che se sostengo qualcosa questa cosa non si realizzerà, cioè il mondo va nella direzione sbagliata perché non fa quello che dico io… Se vuoi prevedere in quale direzione andrà il mondo, chiedimi dove dovrebbe andare e prevedi il contrario.
GC: Diciamo allora che, se il carcere tende a rimanere quello che è, le persone invece possono cambiare.
LLV: Anche il carcere un po’ cambia, non è più quello delle segrete di un tempo. E il carcere svedese non è quello italiano, che è ancora diverso da quello turco…
GC: Intendo dire che in Italia l’istituzione penitenziaria, fra le varie altre, mi sembra la più recidiva.
LLV: Be’, Gandhi sosteneva che il valore di una nazione si misura dagli ospedali e dalle carceri e riteneva che il carcere (nella sua realizzazione più corretta) non fosse incompatibile con il principio della nonviolenza. Gandhi è stato in carcere anni. Naturalmente, aveva una mentalità monastica… E poi si trattava di carceri inglesi e fuori c’erano formidabili manifestazioni in suo favore.
GC: Mentre oggi per le condizioni di vita nelle prigioni manifestano quasi solo i radicali, e dentro in molti hanno la sensazione di essere dimenticati e rimossi. In generale, il carcere diventa oggetto di attenzione solo quando succede qualcosa di grosso, diciamo così, che è davvero impossibile ignorare. Alessandro Margara lo definì discarica sociale… A questo proposito, sarebbe importante ragionare non soltanto su come si vive in carcere, ma anche sul perché molti ci finiscono.
LLV: Nella mia terminologia i reati nascono dalla prevalenza del desiderio dei beni esclusivi, il cui possesso o godimento esclude quello degli altri: ricchezza di beni materiali, potere, notorietà mediatica (il successo, un tempo). Bisogna riorientare il desiderio fondamentale dell’uomo dai beni esclusivi ai beni non esclusivi, che sono essenzialmente tre: beni del corpo (la piena salute e le abilità, per esempio saper nuotare o saper ballare), della mente (come la cultura, la vita contemplativa, e tutte le virtù) e della relazione umana (tutte le forme positive di amicizia in senso molto lato, che sono addirittura beni inclusivi). I beni esclusivi sono beni che non dicono il valore di una persona: per esempio, la ricchezza e il potere regale possono essere ereditari. Ora, la brama dei beni esclusivi crea uno spazio sociale, che io chiamo incompatibile, nel quale l’espansione di uno riduce quella degli altri. Il conflitto sociale non è congiunturale, ma strutturale, se il desiderio prevalente negli esseri umani è desiderio dei beni esclusivi. Allora è fondamentale, anche per motivi ecologici, il passaggio dal primato del desiderio dei beni esclusivi al primato del desiderio di quelli non esclusivi. C’è una frase latina che lo dice: “L’uomo che gentilmente fa luce all’altro non per questo ci vede meno”. Questa è la chiave del futuro. L’ho detto quarantacinque anni fa, poi il mondo è andato da un’altra parte… Alla radice dell’uscita dalla prigione, e soprattutto della non recidiva, c’è il passaggio dal desiderio dei beni esclusivi, che ha portato in carcere, al desiderio dei beni non esclusivi. È impressionante come il desiderio dei beni esclusivi sia comune agli autori di reato e alle stelle sociali, così come la destra (elitismo dei beni esclusivi) e la sinistra (egualitarismo dei beni esclusivi) vogliono entrambe le cose sbagliate: pensano che la realizzazione dell’uomo stia nella conquista di quei beni. I bambini fanno giochi di supremazia, la storia insegnata a scuola è una storia di supremazie, di più forti che prevalgono sui più deboli, potenzia ancora il desiderio di essere come i vincenti… Questa dimensione, ripeto, non è congiunturale, ma strutturale, investe perfino le religioni: Dio, l’Oltre, che di per sé sarebbero beni non esclusivi, sono stati trasformati in beni esclusivi: la mia religione esclude e deve battere la tua.
GC: Tornando in conclusione ai libri e, in generale, alla cultura come strumento di riabilitazione, sulla questione c’è molta retorica. Leggere fa bene, si ripete, la lettura rende liberi… Eppure, l’esperienza brasiliana del Reembolso através da leitura, in cui la lettura di un libro da parte di detenuti autorizzati dal giudice viene ricompensata con quattro giorni di libertà, non ha fatto proseliti.
LLV: Mi dispiace, ma non rinuncio a sperare. Come ho detto sopra, la lettura in carcere può spalancare libertà. D’altra parte, ci sono state varie critiche ai libri. Milarepa, il nume del Tibet per così dire, non ha mai scritto nulla. I centomila canti di Milarepa non sono mai stati scritti. Un suo allievo voleva andare in India perché in India c’erano i libri, i templi e i maestri. Milarepa gli dice: Come maestro può bastare la mente, se sai atteggiarla; come tempio può bastare il corpo, che, nella giusta posizione, è dimora degli dei; come libro può bastare il mondo. L’allievo però gli risponde: Se non ho un Lama che mi dice che i Lama sono superflui, o un libro che mi dice che i libri sono superflui, come faccio a capirlo? Discutono moltissimo. Milarepa parla della trappola del pensiero discorsivo e della superiorità assoluta dell’intuizione meditativa sulla lettura. Oppure prendiamo Platone. Nella lettera settima dice, più o meno: Ho dovuto scrivere, perché ero il più bravo, però mi rendo conto (pensa a Socrate) che la comunicazione attraverso lo scritto è essenzialmente inferiore a quella del maestro. Perché i tre uomini decisivi – in ordine cronologico Buddha, Socrate, Gesù – non hanno scritto una riga? Non solo non hanno scritto un libro, ma nemmeno una riga. Non sono professori. I professori per definizione scrivono, anzi pubblicano. Poi: i taosti. Chuang Tzu: I libri sono la merda degli antichi. Dove sta scritto? In un libro.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente






