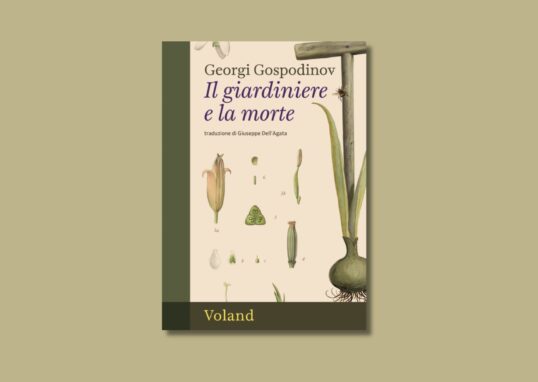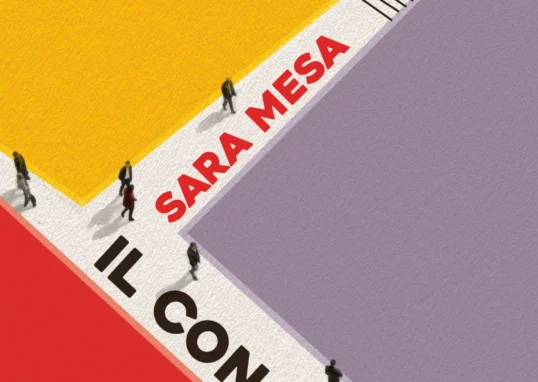di Lavinia Mannelli
“Zoom”.
“Zoot suit”.
“Zulù”.
“And that’s that. I’m finally finished”.
A parlare è Joanna Eberhart (Katharine Ross), la protagonista del film The Stepford Wives. Diretto da Bryan Forbes nel 1975 e noto in Italia col titolo La fabbrica delle mogli, si tratta della prima trasposizione cinematografica del romanzo omonimo di Ira Levin (1972). La trama è semplice: a Stepford, una cittadina sconosciuta del Connecticut, i mariti sono riusciti a trasformare le mogli in perfette compagne di vita, felici e soddisfatte madri di famiglia; solo che l’hanno fatto sostituendole con dei robot.
In questa scena Joanna sta registrando la sua voce mentre legge gli ultimi tre lemmi del dizionario di inglese: è un piacere che le ha chiesto un amico del marito, che si è definito curioso del suo accento.
“Just a lifelong hobby”, le ha detto.
In realtà, Joanna sta inconsapevolmente donando voce, e vita, e un vocabolario moderno, al robot che presto o tardi la sostituirà.
“I aim to feed them all into a computer and program it”, aggiunge sogghignando l’uomo. Anche il marito di Joanna ridacchia, appena imbarazzato.
Perché questo piccolo preambolo? Perché La trama di Elena (Ponte alle Grazie, 2023, pp. 192, 15 euro versione cartacea, 9.99 euro versione ebook) è un romanzo in cui Francesca Sensini registra le parole di Elena di Troia, una donna del cui aspetto si è parlato sempre attraverso il dizionario mitologico forgiato dagli uomini, ma che non ha mai avuto voce propria.
Mi chiamo Elena e sono la regina di Sparta. Avete certamente sentito parlare di me. Sono la donna più bella del mondo. (p. 7)
In questo libro, Elena mostra finalmente il suo vocabolario, la sua epica ingenua e la sua contro-epica provocatoria. Non è semplice rispondere a tutte le voci che girano sul suo conto (“Per alcuni sono la peggiore delle donne, […] altri mi protestano innocente e pura, magnifica preda degli uomini”, p. 8), e quando Elena dice: “Io sono un oggetto” (p. 12), è perché la sua esistenza nei libri che leggiamo, ancora oggi, è un gomitolo di cultura e natura insieme; è diventata quasi una metamorfosi ovidiana.
Presenza che non deve spiegare niente, tendo a irrigidirmi in statua, in idolo, in un oggetto prezioso che si prende, si sposta, si contempla, si ama e detesta, e che non conosce usura.
Certo, la sua bellezza è narrata da Omero, non proprio l’ultimo degli scrittori, ma nelle sue parole Elena, sebbene più libera che in altre, è stata comunque una cosa: bellissima, ma pur sempre cosa. Elena e tutte le ricchezze sono gli oggetti da conquistare per i Greci e, come riporta Sensini nelle Note bibliografiche del libro (p. 171), si tratta di un’espressione che leggiamo in numerosi passi dell’Iliade. Se da una parte sembra che il più famoso degli aedi si sia servito di Elena come di un espediente narrativo per tenere insieme i fatti degli uomini (“Si è nascosto dietro i suoi personaggi, anche dietro di me. Soprattutto dietro di me. Ha fatto di me lo snodo del desiderio di tutti”, p. 12), è proprio a partire dal rapporto con lui, con Omero e, dunque, con la letteratura tutta, che si delinea una sorta di rapporto voyeuristico con la storia scritta dagli uomini:
Non mi ha voluto possedere, a lui basta la sua cetra. Quello che fa, da millenni, è restare a guardare. Mi guarda mentre mi spoglio della veste abituale di cosa bellissima.
“Angelo del focolare, ma di molti focolari” (p. 13), anche Elena, come Joanna, a un certo punto della sua storia millenaria, di vita, mito e riscritture, si siede su un divano di idoli e poesia e registra il suo vocabolario personale, scatenando fantasmi che, prima o poi, la allontaneranno da sé e dagli altri.
Avevo deciso di invecchiare, ero curiosa di vedere l’effetto che faceva. Così, ho evocato il tempo e tutti i secoli della mia esistenza ripetendo a voce alta l’intero indice di un dizionario di mitologia. Allora la casa ha preso a vacillare.
Sono le parole dei miti e degli albori della letteratura occidentale a costituire la trama di questa storia tutta lampi e confessioni, masochismi e vendette, colpe e accuse, in una lingua colta molto viva.
Elena (e così Sensini) è del resto tessitrice di storie (“Poi sono passata alle parole. Sono diventata una tessitrice di trame, una donna aedo. Non volevo subire gli eventi”, p. 11), che la conducono finalmente fuori dall’orizzonte vittimistico e patriarcale che le è sempre stato cucito addosso. Ama le parole e le studia (“crescendo ho preso il gusto delle parole. […] mi sono messa a inseguirle e ho voluto studiarle”, p. 31), cercando con una certa grave autorità, in esse e nella loro etimologia, nel loro senso comune e in quello in disuso, la spiegazione ontologica del suo posto nel mondo. Impariamo molto su di lei dall’origine lessicale di sua madre, Leda, e da quella di molti altri nomi; e in questa ricerca – che è anche genuinamente didattica – si trova senz’altro uno degli aspetti più interessanti del romanzo di Sensini.
Alcune delle pagine più belle del libro sono quelle dedicate al rapporto con la madre e, soprattutto, con la sorella Clitemnestra:
La mia era una freddezza calcolata, una provocazione, pensava. Il suo sogno era riuscire a violare il mio equilibrio, a estrarre da me reazioni scomposte. Solo così mi avrebbe staccata finalmente dal cielo di Zeus. (p. 36)
Memorabili sono anche le pagine sui costumi di Sparta, che vietavano alle donne di rammollirsi nel gineceo (p. 44) e le costringevano ad aspirare agli stessi ideali di vigoria e sacrificio degli uomini: queste riflessioni sono tanto interessanti quanto provocatorie, perché mettono in contraddizione l’educazione di Elena non solo con ciò che accadeva ad Atene, l’eterna avversaria di Sparta, ma anche con quello che avviene ancora oggi, dove solitamente delle eccezioni femminili come Elena si parla storcendo il naso: perché Le Spartane, le Elene, se le cercano (p. 44). Sempre a partire da queste scene che paiono secondarie, ma che in realtà, proprio come nel mito, costituiscono la materia viva, che è digressiva ed ecfrastica, della narrazione (Di lineare, in realtà, non c’è molto: gli eventi si agglutinano e, a un certo punto, si separano partendo in ogni senso, per poi riavvolgersi su sé stessi e riprendere una nuova fase di espansione, dice Elena, qui vero e proprio alter ego di Sensini, a p. 15), non si può non rimanere colpiti in particolare da una scena, che mostra una piccola Elena (ma già matura, imperturbabile), alle prese con le sue bambole.
Leda mi aveva affidato ad Artemide: aveva avvolto, tra le mie fasce di lino, donnine d’avorio, augurandomi di crescere, di diventare come loro. Queste piccole bambole avevano le braccia dritte lungo i fianchi e i capelli acconciati in trecce piatte e spesse, e portavano lunghi pepli. Stavano sull’attenti, pronte a sciogliere gli arti rigidi eseguendo tutti i miei ordini. Così le immaginavo, animate da dentro la loro fissità solo apparente. (p. 43)
Ecco come ci si aspettava che sarebbe dovuta diventare Elena; ecco come si aspettavano che sarebbero dovute diventare milioni di donne che, invece, per volontà degli Dei, di un Dio o del destino, sono diventate eccezioni. Tuttavia Elena non è solo un’eccezione, ma è anche un’eccezione violata, bottino e vittima secolare, luogo comune, insulto, stigma, che adesso vuole parlare. Le pagine in assoluto più intense del romanzo, che motivano la macchina narrativa e ridefiniscono il senso dell’operazione di Sensini, sono quelle che parlano di cosa significava essere donne ieri e oggi; di cosa significhi parlare se la parola ti è sempre stata ricamata addosso. Elena non si accontenta di essere spettatrice: la rabbia – la vista che trema (p. 9) – di essere solo una donna, finanche la più bella e famosa delle donne, è ciò su cui si regge questo romanzo, che ambiguamente non scorda di accennare anche all’odi et amo tra simili che da sempre assedia i simulacri femminili: Ho sempre preferito l’idea che fossero delle donne a uccidermi, dice Elena, specchio delle loro bellezze tanto quanto delle loro frustrazioni, perché potessero così rendersi conto, una volta calmata la loro rabbia, che puntavano l’arma contro sé stesse (p. 150).
Il romanzo di Sensini, del resto, non scorda di rammentare che, per le donne, parlare e guadagnarsi uno spazio nel mondo e, poi, sviluppare un linguaggio e una prassi politica comune presuppongono innanzitutto determinate condizioni materialistiche. Virginia Woolf scriveva Una stanza tutta per sé nel lontano 1929 e poneva la questione ancora attualissima del diritto delle donne a uno spazio culturale (ma si potrebbe chiaramente parlare di un diritto alla voce, alla tessitura di trame, letterarie e non solo). Woolf auspicava e rivendicava la possibilità per le donne di raggiungere un’indipendenza non solo di pensiero, ma anche economica rispetto agli uomini; di ottenere luoghi fisici, oggetti materiali e non solo metaforici, in cui esercitare la parità. Basterebbero cinquecento sterline all’anno, suggeriva alla fine. Così Sensini e la sua Elena recuperano la celebre formula di Woolf (ci sono molti spunti di Sensini accademica, nel libro, ma mescolati piuttosto organicamente alla trama della sua “personaggia”: si veda, per esempio, il capitolo Tutti pazzi per Elena).
Per scrivere storie una donna deve avere denaro e una stanza tutta per sé (p. 13)
Se questo è vero, però, la stanza di Elena appare fin da subito quasi troppo affollata per essere solo sua. Per questo motivo ricorda quella da cui si dipana la trama di un grande romanzo del Novecento italiano: quella stanza ingarbugliata, in penombra, piena di mezze verità e confessioni estorte, che è la camera di Elisa in Menzogna e sortilegio. Come nel romanzo di Sensini, anche lì la scrittura di Elsa Morante si mescola, in un gioco romanzesco, metaletterario, raffinatissimo e ancora oggi paradigmatico della scrittura dell’autrice, all’elaborazione infaticabile del racconto di Elisa: ciò che la protagonista narra (e con cui si difende e si ferisce, a seconda) si rifrange continuamente tra le pagine dei libri amati da Morante, e in questa rifunzionalizzazione cangiante sta, forse, la loro menzogna e il loro eterno sortilegio.
Non è un caso che molti dei passi più belli del libro di Sensini corrispondano ai vari tentativi di Elena di definirsi, di raccontarsi con una stratificazione di verità successive (p. 21), senza dolo (p. 21) o gerarchie – proprio come avviene nel mito: è questo il motivo per cui lei stessa parla del libro come di un romanzo genetico (p. 34).
Invece ero, e sono, a modo mio, inalterabile, come il marmo e il bronzo delle statue antiche che, anche quando hanno perso il loro colore, dilavato ed eroso dalla chimica del tempo, convincono lo spettatore moderno di non essere opache e consunte, bensì purissime, e gli insegnano come la loro corruzione sia candore e suprema saggezza. (p. 38)
Sono variazioni sulla pelle alabastrina di un archetipo, scolpito giorno dopo giorno dalle parole di tutti noi che lo leggiamo e lo rielaboriamo, che riflette all’infinito su sé stesso e su ciò che si è specchiato sulla sua superficie perfetta (altri punti interessanti sono quelli dedicate allo specchio, del resto). Noi crediamo di conoscere Elena, ma con quello che sappiamo di lei abbiamo solo costruito un feticcio.
Feticcio. Questa parola ricorre due volte nel romanzo, e non a caso entrambe le volte (p. 9 e 81) insieme al cavallo di Troia. Elena, la Elena vera o quella soltanto raccontata, è il cavallo di Troia, il dono apparente, o piuttosto l’inganno che il cavallo nasconde, la minaccia dell’assedio? Il romanzo vive di questa contraddizione, la alimenta e la smentisce, proprio come succede in un romanzo di formazione. La sensazione, leggendo il romanzo di Sensini, è che in ogni caso Elena non si potrebbe salvare e, allo stesso tempo, non potrebbe salvare chi ha ferito: in nessun caso, nemmeno annullandosi. La casa che le somiglia è, infatti, una casa dalle mura grezze, spesse, impenetrabili, piena di vecchi oggetti appartenuti ad altri, non so a chi (p. 14); cose perse.
La cosa curiosa è che Elena fugge dalla tragedia (p. 25), che è la voce degli altri che le si sovrappone. Anche noi lettori ci convinciamo di non averne bisogno, a mano a mano che ci immedesimiamo in Elena; e lo facciamo con una forza straordinaria, che ci trasporta da una fase all’altra della sua vita e dello spettro di essa. In realtà, senza un po’ di tragedia, vale a dire di Storia e di rabbia, non saremmo qui a leggere questo bel libro.
Nelle pieghe di questa stessa amarezza si riconoscono i tracciati delle mie carte scoperte, della tela infinita che tesso e che, a differenza di Penelope, non disfo mai. Perché non è una scusa, la mia, non è il sudario destinato a un morente, ma la trama della mia continua resurrezione. (p. 157)
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente