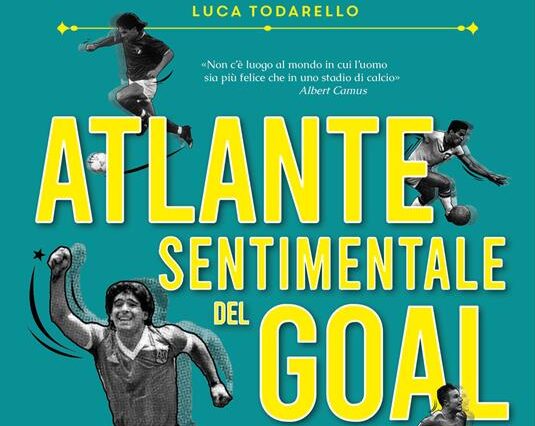
Pubblichiamo parte della prefazione di Atlante sentimentale del goal. Le cinquanta reti che hanno fatto la storia della Coppa del Mondo, a cura di Luca Todarello. La prefazione è di Massimo Raffaeli.
di Massimo Raffaeli
«Pochi momenti come questo belli,
a quanti l’odio consuma e l’amore,
è dato, sotto il cielo, di vedere».
Umberto Saba, Goal
Nell’esperienza di qualunque appassionato di calcio il goal equivale esattamente a quanto, nel suo famoso saggio sulla fotografia, Roland Barthes definisce il punctum e cioè un sinonimo del guardare in macchina ovvero l’azione di chi fissa nello stesso momento in cui viene fissato.
La sequenza pressoché infinita di goal che ogni appassionato serba nella traccia mnestica ha infatti la conformazione di una doppia banda perché da un lato trattiene un insieme (diseguale, ignaro e anzi indenne dalle categorie di spazio e tempo), una somma di frazioni corpuscolari tutte quante trapuntate di ictus, dall’altro le redime al presente nel moto imprevedibile, liberatorio, che gli psicoanalisti chiamano ab-reazione. Lo stesso accade per i rari istanti perfetti e dunque totalmente compiuti della nostra esistenza, quelli che talora sanno scamparla dallo stato di ovvietà e indifferenza.
Il goal è l’acme, l’attimo in cui torna a coagulare quanto un momento prima era ancora disperso e insensato, perciò il goal è un ordine che riscatta l’anonimo, ordinario, disordine della vita quotidiana e ad essa conferisce senso e direzione. Così si potrebbe anche dire che nella partita di calcio, allegoria della nostra vita, il goal attinge l’equilibrio dell’opera d’arte (sia pure, se vogliamo, di un’arte minore) e insieme l’assolutezza della sovranità (e Georges Bataille, al riguardo, ricorreva alla nozione di dépense, puro consumo, spreco senza ritorno) ma la sua risulta una sovranità tanto più ambita quanto più momentanea e sempre a rischio di rimozione e oblìo.
Pertanto il goal, quel goal, ti guarda mentre tu nel ricordo non smetti di guardarlo. Per esempio arbitrario, personalissimo: il primo dei tre goal di Paolo Rossi al Brasile nel vecchio stadio di Sarriá, il 5 luglio del 1982, sublime sberleffo a Golia di un Davide già dato da tutti per spacciato; quello di Luigi Riva alla Germania Est (Napoli, stadio san Paolo, 22 novembre del ’69), con un tuffo rasoterra a mo’ di barracuda, da chi scrive vagheggiato sui banchi della scuola media; la saetta di Johan Cruijff
durante un Ajax-Celtic dei primi anni Settanta, prodigioso prolungamento del ’68 con altri mezzi al vertice di una competizione, la Coppa dei Campioni, che allora come ora somigliava alla ricerca del Santo Graal; il colpo del vecchio sempiterno José Altafini segnato di testa dentro l’acquivento con imperioso stacco durante uno Juventus-Fiorentina alla fine del ’72 e infine il goal, stop/controllo/conclusione (forse era un Lazio-Lanerossi del ’74), a fil di palo e a firma dell’indimenticabile ala destra Renzo Garlaschelli. Ma si tratta, per l’appunto, di immagini sgranate e immerse nel flou della televisione in biancoenero, sono frammenti del tutto privati, reperti accarezzati dal tifoso, collezionista e custode gelosissimo di un repertorio che non smette di accudire e integrare.
Ci è stato spiegato che il collezionista è colui che raccoglie frantumi scampati al diluvio e all’insignificanza proprio perché tenta di dare finalmente un ordine, un senso, a materiali che in sé ne sono privi.
Lo scrigno che Luca Todarello apre ai lettori del suo Atlante sentimentale del goal non serba esclusivamente dei ricordi individuali ma funge da collettore della memoria pubblica e da serbatoio di gesti entrati nel senso comune. Perché, quanto al gioco del calcio, nulla può attingere l’universalità del Mondiale e nulla sa decretare la fama di un calciatore quanto il fatto di averlo giocato o, addirittura, vinto. (Le vistose eccezioni collocate nella appendice dell’Atlante confermano la regola in sé inderogabile pure se si tratti di Valentino Mazzola, l’eponimo del Grande Torino perito a Superga, di Omar Sivori, autentico espada del calcio o anche di Alfredo Di Stéfano, nel suo caso hombre-orquestra e per qualcuno il campione più classico, così come, tutto dire, di Marco Van Basten e Zlatan Ibrahimovic: né ha mai giocato un Mondiale l’asso italiano che le iperboli del tifo battezzarono piede sinistro di Dio, demiurgo della cosiddetta punizione “a foglia morta”, geniale e indolente simbolo dei Sixties e dei nostri anni ribelli).
Todarello ordina secondo cronologia la propria materia a partire dal Mondiale di Montevideo, 1930, che nessuno praticamente vide ma stabilì la immensa fama di un italo-argentino, l’ala sinistra Raimundo Orsi detto Mumo, a tempo perso violinista e abile tanguero, sommo virtuoso del gioco e capace di segnare direttamente da calcio d’angolo con decenni di anticipo sui suoi non molti emuli quali Luciano Chiarugi soprannominato Cavallo Pazzo e i non meno indocili Alvaro Recoba e Ronaldinho.
Limite del repertorio è ovviamente il Mondiale russo del 2018, vinto dalla Francia di Kanté, Pogba e Mbappé e però caratterizzato dalla emergente Croazia di Mario Mandzukic e di uno straordinario Luka Modric. Per parte sua Todarello sceglie dei goal memorabili per tradurli in ritratti emblematici. In poche righe equanimi, egli sintetizza una fisionomia tecnica per vederne in controluce il profilo esistenziale e la postura etica. Il suo modello, archetipico, è l’Eduardo Galeano di El futbol a sol y sombra (del ’95, da noi uscito con il titolo meno caravaggesco e più balzachiano di Splendori e miserie del gioco del calcio) da cui Todarello deduce l’attenzione per i dati del contesto ambientale e del percorso formativo convogliati in uno stile netto, essenziale, che nulla concede al lessico a volte sordido degli addetti ai lavori mentre guadagna in ritmo ed eleganza. Todarello va di volta in volta al punctum restituito dal ricordo liberamente associando assi e comprimari del football, eventi carismatici o del tutto sbiaditi.
Davvero non si finirebbe di citarli: il goal di Nelinho a Dino Zoff (Baires 1978, finale per il terzo posto), un colpo di taglio esterno dal vertice destro dell’area, parabola a rientrare, qualcosa di balisticamente inaudito che tuttavia non mancò di scatenare contro il campione friulano accuse invereconde di cecità e torpore; la crudele quarta marcatura di Carlos Alberto nella finale dell’Azteca (1970) che finì di umiliare l’Italia di Mazzola e Rivera con un tracciante destro di violenza esplosiva dopo un fraseggio prolungato e ipnotico, puro calcio danzato, da parte di Pelé, O Rey, e dei compagni verdeoro; senz’altro il goal di Marco Tardelli alla Germania Ovest nella finale di Madrid ’82 su cui pure tanto si è scritto ora evocando il grido unanime di Ungaretti in trincea ora viceversa l’urlo primordiale del dipinto di Edvard Munch; o finalmente la doppietta con cui il giocatore più grande di sempre, Diego Armando Maradona, seppe liquidare gli inglesi (Messico 1986), prima con il provvido soccorso della Mano de Dios poi con la serpentina a tutto campo citata nei manuali come massima espressione dell’arte calcistica e insieme come gesto di temeraria presunzione da parte di chiunque non incarnasse quella medesima divinità.
L’Atlante trasmette insomma qualcosa che per gli appassionati può divenire volta a volta una reliquia, un bene-rifugio, persino un rito scaramantico o il bene di una eredità. Che cos’è un goal se non il compimento nel magma di azioni fallite? È stato infatti un poeta, Antonio Prete, a definire la passione per il gioco del calcio come la ricerca, non meno necessaria e impellente, di “un’altra armonia”.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente






