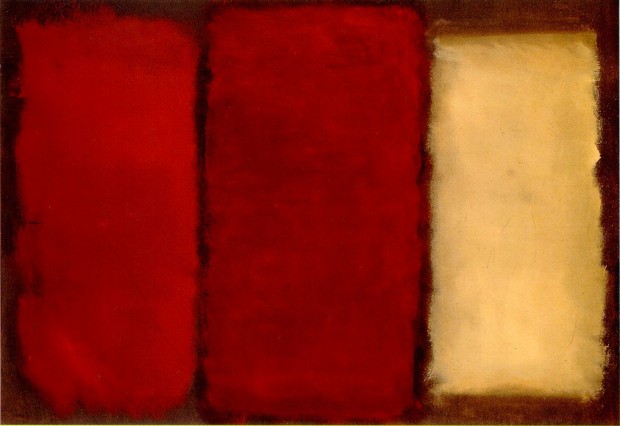
(Immagine: Rothko.)
Sono immerso nel mio ruolo di accompagnatore di Ermanno. Stiamo salendo verso l’appartamento più alto dove sia mai stato in vita mia. Palazzi di diciotto piani, a Serpentara, Roma nord-est. L’ascensore ci risucchia verso l’alto. E ciò di cui sono sicuro è che questa capsula di metallo non si fermerà, adesso prenderà ancora velocità, sfonderà il leggero foglio del tetto coibentato, fluttuerà qualche momento nell’aria, come una palla da flipper tirata con poca potenza, e poi ricrolleremo a terra io e Ermanno: storti, rovesciandoci su noi stessi, abbracciati per farci inutilmente scudo coi corpi contro l’impatto.
Ci apre la madre di questo Stefano, truccata, truccata forse da ieri, il fard e l’ombretto che le si sono seccati su un viso gonfio, diresti insufflato di sonno arretrato. È in tuta e scarpe coi tacchi: stivaletti alti slacciati. Siamo qui perché una settimana fa è stato contattato da questa donna, che di nome fa Raffaella ma si fa chiamare Raffo, al maschile, che cercava qualcuno pronto a aggiustarle in un massimo un mesetto tutte le stanze della casa (che è su un paio di livelli) dotandole di ringhiere e pedane per il figlio. Stiamo parlando del figlio handicappato, handicappato grave, che si è aggravato (da quello che ci ha raccontato in una serie di dettagli che non lesina) negli ultimi tre mesi, e per il quale quindi occorre ripensare ogni volta lo spazio.
Stefano ci viene presentato il giorno che entriamo in casa sua, avvertendoci che oggi è un giorno no. Io mi presento, insicuro, a disagio, e non capisco cosa potrebbe voler dire Giorno Sì, ossia quali delle caratteristiche oggi lampanti non sarebbero normalmente presenti. Non starebbe seduto di traverso su una sedia a rotelle, con le gambe contratte semiripiegate su un lato? Avrebbe lo sguardo animato dagli stimoli esterni invece di guardare fisso in direzione della madre? Emetterebbe dei suoni più comprensibili invece di questi singhiozzi acuti, che la madre non commenta, come se fossero un suo modo pacifico di salutare?
È alto – o meglio – è lungo: disteso in questo modo slogato sulla carrozzina. Completamente glabro; gli sbocciano solo dei miseri ciuffetti di capelli su una testa lucida senza pori che assomigliano a licheni sopra la superficie di una parete di ghiaccio; e ha una pelle talmente chiara che anche questo pallore potrebbe essere il sintomo di un altro handicap – albinismo della cute. Ma la cosa che veramente non si può evitare, in questa casa ingombrata di divani, letti, poggiamani, è guardarlo in faccia, distogliere lo sguardo dal suo non-sguardo. A un primo acchito questo significa essere quasi attratti dalla sua bellezza praticamente olimpica: le sue iridi cerulee e le sue labbra candide. Alle volte se lo si chiama, “Stefano!”, reagisce allo stimolo, allarga gli occhi, emette un sibilo; alle volte sembra narcotizzato.
Appena entra negli appartamenti, Ermanno prende le misure del pavimento e delle pareri. Mentre Raffo ci fa una sintesi della storia clinica del figlio. Utilizza una freddezza che è sintomatica solo di un’abitudine ormai digerita. Una decina d’anni fa a Stefano hanno trovato un tumore al cervello (quant’avrà avuto? neanche vent’anni): un blocco di cellule cattive e floride attaccate ai nervi da cui non si volevano sganciare. L’hanno curato con una chemioterapia eccessiva e mal dosata, che in combutta con il tumore ha causato danni cerebrali tali per cui adesso fa la vita di un bambino di tre anni, forse due, forse uno.
E ora, e qui, Stefano ci guarda o ci ignora, circonfuso dall’attenzione della madre e di una strana, stranissima pseudo-famiglia che Raffo è riuscita a assemblare e che ci ha tenuto a presentarci invitandoci a restare a pranzo, anche se c’eravamo da subito schermati che eravamo solo venuti a fare un sopralluogo: “Lei è Carmen”, piacere, “lei è Sandrina”, piacere, “poi lui è Marcello”, piacere, “e lei è Giada”. Queste Carmen e Sandrina, truccate anche loro molto, vestiti leopardati e ciabatte anche loro, sono colleghe (appena più giovani) di Raffo. Lavorano in un’agenzia di data entry, in particolare si occupano di controllare gli assegni: fanno turni di sei ore, notte e giorno, e – da quello che ho capito – quando tocca a Raffo uno dei due turni di notte, Carmen o Sandrina la sostituiscono dentro casa: mettono a letto, vestono e svestono Stefano, gli preparano la colazione. In contraccambio hanno praticamente la possibilità di vivere qui gratis, si dividono una stanza, stazionano da mane a sera – anche se la ragione che le ha spinte a accamparsi la capirò bene soltanto qualche settimana dopo: invischiate in delle situazioni famigliari talmente sfasciate che un disabile grave con disfunzioni neurologiche che alle volte ti vomita addosso o si strappa il pannolino durante la notte e va cambiato, lui e le lenzuola, non è niente rispetto a quello che le attenderebbe a casa loro.
E Raffo a pranzo, in questa cucina che sa di acido muriatico (perché lei, vedrò anche questo, ha un modo di pulire la casa che è praticamente decontaminare) mi chiede, dopo mesi che nessuno mi butta là questa domanda. “E tu che cosa fai?”.
…mi volto verso i piatti appesi dei ristoranti: accuso un istante di smarrimento, perché di fronte a questa interrogativa aguzza, mi viene da essere altrettanto sincero. E la sincerità, mi chiedo, che cosa mi porterebbe a rispondere? Passo le giornate in uno stato vicino all’allucinatorio? Faccio da amico del cuore a Ermanno?
Lo faccio con una risata imbarazzata, ma le rispondo: “Sto facendo una ricerca sui pesci”, come tenessi con garbo una conversazione da pranzo domenicale: il ragazzino interrogato dalla zia. Perché del resto per fortuna mi rendo conto che persiste, dentro di me, un altro me in sedicesimo che preferirebbe che non passasse il messaggio implicito Scusate sono allo sbando, ma ci terrebbe a fare una figura decente, ci terrebbe, ecco, a ribattere proprio come si fa a una zia… Ho avuto il massimo dei voti per questa ricerca… ih ih… se va in porto come dovrebbe avrà un rilievo internazionale… ih ih… ora mi vedete qui a fare da compare a questo polacco male in arnese… ih ih… ma è come dire, sì, da un certo punto di vista, tutta la cosa si potrebbe interpretare diversamente: io è come se riprendessi con la cinepresa la vita di Ermanno, e insieme registrassi anche la mia, di vita, la vita così come avviene, senza filtri, senza pregiudizi, differenze di classe, di nazionalità… ih ih… anche se io appunto sono bianco, cioè anche Ermanno è bianco, ma io appunto sono italiano, sono un italiano colto, che ha studiato al liceo, che vive… ih ih… questo momento di disagio, che ci sta e non ci sta… che ci sta e non ci sta con la testa anche ih ih… e questa specie di sorriso sfiatato è proprio il segnale di un disagio, di un’asimmetria…
Raffo tanto non si aspettava nessun tipo di risposta. Ha già pronta la sua, di controreplica. Lascia il tempo che il pranzo scivoli verso il caffè, che io sia sazio (pasta al ragù, pollo, mi sono ingozzato anche di pane), per accordarmi un sorriso da vera zia: “Quanto zucchero?” e “Vuoi ancora qualcosa? Altro pane?” e la sua frase innocente: “Sono contenta che ti sia piaciuto tutto. Ma ti andrebbe di venire qualche volta a portare Stefano fuori a fare un giro. Anche questa settimana?”. Mi porge un bicchierino di mirto, pieno all’orlo. “Ti pago, eh, per il disturbo”.
“Il disturbo?”, mastico confuso.
“Ecco, appunto. Non è mica un disturbo. È esperienza. Una bella esperienza”.
E così, per fare esperienza, mi ritrovo a uscire di casa “quando ti pare, quando vuoi, quando hai tempo” alle sei e mezza per preparare la colazione a Stefano, dopo che Sandrina o Marcella l’hanno vestito, mentre la luce ghiaccia che risale dai marciapiedi si appiccica come una brina ai palazzi residenziali di Serpentara e espelle almeno per qualche ora i bambini dal mondo.
Stefano appena mi vede vuole uscire, smania. È fatto in un modo che mi soffermo a osservare. Quando ha un desiderio, il suo corpo si inarca e preme. Se vuole mangiare spalanca la bocca. Quando vuole un abbraccio da Raffo, tende le braccia in avanti come corde del bucato e finisce che si abbraccia da solo. Quando vuole andare in bagno, abbassa la testa. Se vuole andare fuori, si agita sulla carrozzina, tutto proiettato verso la porta.
Non è difficile stargli vicino dopo che uno ha compreso la grammatica basilare di bisogno, gratificazione e controllo. Sbava, lo pulisci. Sta scomodo, lo alzi tenendolo da sotto le ascelle. Deve andare al bagno, gli abbassi la tuta, e gli tieni il pisello giusto per indirizzargli lo schizzo.
Con lui prendo strade in salita e in discesa appena siamo fuori dal portone. Stefano è sepolto da una serie di tute e pile scoordinati e un cappello che gli copre tutta la testa e mezza faccia; i colori sbirulineschi. Lo spingo per le strade in salita e in discesa per riscaldarmi. Mi attacco alla carrozzina come alle maniglie di un tapis-roulant. Quanto ci metto a arrivare dal semaforo a quel bar? Stefano incosciente non si rende conto. Io ho i piedi gelati e devo correre. Però mi sembra, m’immagino, che si diverta a andare fuori di casa, andare veloce, superare le macchine ferme al semaforo. In salita soprattutto, in discesa si attacca alle barre di ferro laterali. Quando andiamo a zig zag ride con questa sua risata ansante, e io lo prendo come un segno di consenso. Faccio il coglione.
Spesso prendo a pranzare da Raffo. Marcello un giorno mi spiega tutta la sua intricata struttura famigliare. Per cui lui forse è il fratellastro di Raffo. Forse,perché il loro padre (con cui lei è cresciuta fino a cinque, sei anni) si è rifatto vivo con la famiglia di Marcello quando lui era un adolescente, spacciandosi per il padre naturale. La madre di Marcello, una sciura del quartiere Trieste prima ha ammesso la cosa, poi quando lui ha cominciato a chiederle dei soldi, ha negato tutto trattandolo come un truffatore. Nel frattempo però era successo che c’era stata una vacanza estiva fatta insieme da questi due tronconi di famiglia, un paio di settimane in una vecchia casa a Fregene, in cui Raffo e Marcello si erano conosciuti, piaciuti anche un po’ e – abbastanza incerti sulla verità del loro presunto padre comune per decidere di farsi una storia – avevano ripiegato su una confidenza a metà tra l’amicizia, la familiarità, la fratellanza, e il fronte comune nell’odio per i loro genitori, naturali o meno. Quando Raffo era stata abbandonata dal marito (sparito circa una settimana dopo che a Stefano era stato diagnosticato il tumore, “il tempo che j’ho preparato un po’ de bucato pulito e de camicie stirate”), Marcello si era preoccupato di sostenerla. L’aveva introdotta a quello che sembra a tutti gli effetti il loro principale interesse condiviso: gli psicofarmaci. In particolare le benziodiazepine. E al primo momento di difficoltà economica si era trasferito a casa sua – una specie di marito, una specie di fratello, una specie di amico, una specie di figlio troppo cresciuto o di padre sostitutivo.
Un’altra mattinata, in cui fuori c’è una pioggia fredda e continua, Marcello ne approfitta e mi spiega anche chi è Carmen. Ci arriva con delle circonvoluzioni di frasi, rispondendo a una domanda su cui aveva glissato qualche settimana prima. Gli avevo chiesto che ci faceva una fede al dito di Stefano. Lui aveva nicchiato, finto di non sentire, e nei giorni successivi la fede non c’era più. Poi una mattina l’anello ha fatto la sua ricomparsa, ogni tanto gliela mettono perché a Stefano fa piacere, una volta al mese, festeggiare l’anniversario.
“L’anniversario di che?”.
“Guarda che è proprio sposato”.
“E co’ chi?”.
“Come co chi? Co’ Carmen”.
Il matrimonio è stato celebrato cinque, sei anni fa da un funzionario comunale compiacente (leggi: pagato). Lei ci ha guadagnato la cittadinanza italiana, la possibilità di non battere in strada (leggi: di battere quando le va) e una specie di alloggio. Lui, una ragazza che lo soddisfa.
“Ossia?”.
“Che lo accarezza. Sai che pure in Svizzera ce stanno queste, e so’ pagate dallo stato”.
“Ci stanno che? Le mogli degli handicappati?”.
“Le accarezzatrici, le chiamano. Appropriato. Le accarezzatrici sociali. Lei: lo accarezza. Lo masturba… Lui sta bene”.
“…”.
“Prima ce la faceva a farsela da solo. Si rigirava tutto. Ci si aggrappava con le dita. Ma mo’ è strano, è come se ci avesse avuto un qualcosa che gli ha fatto saltare il coordinamento dei nervi, o dei muscoli, che ne so… Sta più rintronato…”.
“Lo fa a pagamento tutti i giorni?”.
“Ormai so’ in confidenza. È più una cosa automatica, medica pe’ dì. E ‘o sai, quando gli piglia male a Stefano, non c’è quasi un cazzo da fà pe’ calmallo. Gli prennono sti attacchi ‘pilettici che svaria tutto. E ‘amo trovato pure co’ Carmen sta soluzzione che pe’ daje ‘na calmata. Carmen je fa na sega. E lui si risintonizza”.
“…”.
“È che c’ha tutto collegato. Non se regola, non se po’ regolà”.
I palazzi appiccicati alle strade a destra e sinistra ti fanno ombra d’estate e ti proteggono dal vento d’inverno. Ma appena ti ritrovi in uno slargo semiperiferico niente ti ripara e l’umidità ti si attacca alla gola. Butto addosso a Stefano un altro maglione, e cerco di rinfilargli la canotta dentro i pantaloni, gli stringo la cinghia, per non lasciargli la schiena scoperta. Se si ammala è un macello, si mette a respirare male di notte e gli sale un’insofferenza asmatica che sveglia chiunque.
Mi verrebbe di parlargli dei pesci: Stefano. Mi hanno consigliato di comunicare il più possibile, il che in sostanza vuol dire chiacchierare anche se lui si limita a mugugnare. Comunicare vuol dire accarezzargli la testa, massaggiargli i muscoli del collo che si irrigidiscono per la tensione, “manifestare empatia” (che è un’espressione psicologica che devono aver imparato un po’ tutti quelli della casa – una panacea ideale utile contro ogni cosa che non va). Sarebbe semplice: Stefano pesa meno di quello che s’immagina, e la carrozzina è di quelle ergonomiche per cui non si fa molta fatica. Ma io sono io, e al solito non riesco a focalizzare l’attenzione.
Come va, Ste’? mi verrebbe da chiedergli, anche se so come va; come altro potrebbe andare se non bene? E lui fa un sibilo di approvazione, emette un suono lieve ma fermo, come un singhiozzo controllato. Tutto bene, Ste’?, penso. E immagino certo di sì. Il sibilo di Stefano aumenta solo leggermente di volume. Sembra un sorriso anche questo suo tentativo di esprimere qualcosa, il suono che fa un sorriso compresso. Che non riesce a uscire.
E poi però il volume aumenta, e aumenta ancora. Va su di giri. Finché diventa una nota urlata.
Senza che neanche me ne accorgo ci troviamo su una salita ripida dietro Piazza Labia, in mezzo al parco. Ho preso una scorciatoia, uno di questi sentieri che lui in carrozzina non fa mai. Un freddo tosto qui, non c’è nessuno in mezzo al parco, un parco tutto per noi, con Stefano che per ammortizzare i colpi della strada sotto le ruote, prende a dondolarsi sulla carrozzina, come se adesso il singhiozzo dall’esofago gli fosse passato a tutto il corpo. E io rimetto i freni alla carrozzina, provo a massaggiargli i muscoli delle spalle. Ma lui scuote la testa. Scuote le spalle e muove le braccia come i manici di un toro meccanico.
La carrozzina è instabile sul terreno, c’è il rischio che si ribalti. Ma proprio mentre sto provando a spostarla, lui senza volerlo mi strattona, e cadiamo tutti e due in terra, io su di lui con tutta la carrozzina.
Mi prende il panico. Ho il terrore di avergli fatto davvero male. Lui non piange, continua a singultare, ma penso che gli ho fatto così male che lui, così, a caldo, neanche lo sente il dolore.
Sicuramente gli ho rotto qualcosa. La botta gli avrà creato una fetita interna che si sta espandendo lungo i capillari del cervello. Mentre io non cosa fare. Perché lui non grida neanche. È completamente rigido, un uomo di pietra, un uomo di ossa.
“Stefano… Stefano. Mi vedi, sono qui. Sono io, è tutto a posto. Adesso con calma, ti rialzo. Eccolo. Devo fare con calma. Se faccio uno sforzo fatto male capisci poi non va bene. Ti strappo… Cioè, non voglio dire che ti strappo. Ma è che meglio che non ci facciamo male nessuno dei due…”.
Lui resta immobile, non è morto solo perché batte le palpebre, e trema.
Gli riesco a togliere la carrozzina di dosso, tenendolo con una mano. Non voglio che rotoli adesso, qua sul prato, o che si insozzi tutto. Chiudo, metto da una parte la sedia, e lo tengo bloccato, seduto sulla strada sterrata. Senza nessuno che ci metta fretta, senza nessuno intorno, “Ci dobbiamo solo tranquillizzare, Ste’”, ma lui fa peso col corpo, e dopo aver respirato a fondo per un po’ imitando il ritmo che imprimevo io al respiro, adesso ha allargato gli occhi verso di me, come se gli fosse arrivato un fiotto di sangue dalla bocca dello stomaco fin nella gola. Con la testa si rivolge dalla mia parte e mi fa dei gesti da cavallo drogato. Le labbra contratte, l’ovale della bocca stecchito in una morsa che non addenta. Fa su e giù con il mento, impazzito, pallido. Mi vuole indicare qualcosa. Io lo placco per le spalle, e a fatica lo rimetto seduto.
Lo lascio respirare. Poi mi rimetto velocemente seduto anch’io, vicino, gli controllo gli occhi. Aspetto che il respiro di entrambi si plachi. Non passa nessuno qui, tutta un’aria di morte.
In questi momenti in cui in fondo Stefano è solo un corpo e sta in silenzio e sorride, fa pensare che sia proprio un bambino di un anno, due. E questa è la prima gita di un padre e di un figlio piccolo in montagna. Siamo arrivati fino in cima, e adesso ci mettiamo qui a riposarci. È bello qui, vero?
Ma la regola che impari con gli handicappati come con i bambini è che il riposo è una falsa pista. Se una persona non è capace di esprimersi bene, puoi dargli più attenzione e starla a ascoltare. Ma se guarda nel vuoto, e si lecca compulsivamente le labbra, non puoi mai essere sicuro di quello che vuole dirti e di ciò che dovresti fare. Così la scena del padre e del figlio non è neanche una scena, dura meno di un minuto.
Stefano prende a respirare penosamente. Si ritrasforma in un animale. E io ricomincio a non sapere che fare, lo reggo per le spalle. Gli sussurro delle frasi standard, ma non cambia niente: non controlla il respiro, si sta strozzando, vorrebbe aria. E le cose accadono all’istante. Nessuno, un paesaggio di Marte, veramente nessuno qui intorno, neanche a chiamarlo.
Allora gli allargo la cerniera. Ho una sollecitudine paterna, o quella che è. Vado fino in fondo a qualche anfratto della mia memoria più potente. C’è un luogo abbastanza ampio dove i ricordi non sono stati rimossi, ma soltanto lasciati in custodia al tempo, insieme ai libri delle elementari che non abbiamo voluto buttare, ai primi denti da latte caduti e conservati come reliquie medievali.
Ho l’impressione che Stefano non parli ma riesca a riflettere i pensieri. I suoi occhi, siano degli specchi. Gli passo una mano dietro la schiena. Lui si sforza di respirare, come un bambino che sta imparando a nuotare. E qui per terra si gela. Emette dei singhiozzi che sembrano rabbiosi. Dondola avanti e indietro con il corpo. E con il mento, m’indica per terra. Quando gli provo a tenere la testa e massaggiarlo sulle spalle, mi scansa e si mette a lagnarsi senza voce, come una voce in un sogno, fiato sfiatato. E poi mi spavento sul serio, perché sembra veramente che non prenda aria, che ci sia qualcosa che gli intoppi il respiro. Lo faccio sdraiare leggermente e gli slaccio la cintura, lui si placa un po’, ma poi ricomincia. Da semisdraiato, si dimena, con la pancia, le spalle. Finché capisco cosa vuole. E provo a guardarlo negli occhi.
Ha gli occhi più grandi degli occhi normali, come se a forza di guardare il mondo esterno senza poter poi far molto, avesse sviluppato un’ipertrofia dello sguardo. Ha degli occhi troppo grandi. Chiede sempre. Non parla, ma è abituato a chiedere.
E quello che ora considero è che mi sta profondamente sul cazzo. Perché è talmente abituato a chiedere che in questo momento mi sta ricattando. Perché se adesso non faccio quello che vuole, lui potrebbe morire, o fingere di morire, fingere di stare male, di suicidarsi. Se io adesso non gli apro i pantaloni e non lo masturbo, penso, lui continuerà a non prendere aria, a lagnarsi, a fare il pazzo, a dimenarsi. E forse potrebbe sul serio farsi male. E per quanto lo guardi negli occhi, è come se lui fosse assente, come se mi dicesse: non è negli occhi che mi devi guardare, devi guardare il mio corpo, è lì che sono io.
Faccio presto, se devo odiarlo lo voglio odiare per poco. È un brutto gioco, un piccolo ricatto e non pensavo che me lo facesse. Presumevo che si fosse creato un rapporto di lealtà tra me e Stefano. Gli tiro giù solo l’elastico delle mutande, cercando di tenergli abbassato il maglione per non fargli gelare la pancia. In questo momento lo odio così profondamente che non mi frega niente che si ammali, prenda freddo, gli venga una polmonite, e fulminante. Ma non voglio perdere questo minimo lavoro con Raffo, non voglio perdere la faccia, non voglio immaginare la ramanzina furibonda di Raffo che mi grida contro perché ho fatto ammalare suo figlio. E quindi, che facesse presto. Con un braccio gli reggo il corpo, con l’altra mano gli muovo su e giù il pisello, provando a pensare a altro, a qualcosa che mi distolga il pensiero. E perché, quando mi servirebbe distrarmi, non ci riesco?
Per fortuna: Stefano viene subito, riesco a farlo schizzare per terra, di lato. Lo strizzo un po’, in modo da non doverlo poi pulire troppo a casa, spero. E a quel punto si volta verso di me e si lascia guardare finalmente negli occhi. Ha uno sguardo che è come se mi avesse nascosto fin adesso perché è uno sguardo che non è completamente suo.
Christian Raimo (1975) è nato a Roma, dove vive e insegna. Ha pubblicato per minimum fax le raccolte di racconti Latte (2001), Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? (2004) e Le persone, soltanto le persone (2014). Insieme a Francesco Pacifico, Nicola Lagioia e Francesco Longo – sotto lo pseudonimo collettivo di Babette Factory – ha pubblicato il romanzo 2005 dopo Cristo (Einaudi Stile Libero, 2005). Ha anche scritto il libro per bambini La solita storia di animali? (Mup, 2006) illustrato dal collettivo Serpe in seno. È un redattore di minima&moralia e Internazionale. Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi Il peso della grazia (Supercoralli) e nel 2015 Tranquillo prof, la richiamo io (L’Arcipelago). È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile Libero 2014).






ho lavorato degli anni con handicappati, quelli come Stefano erano i “gravissimi”, con cui comunicare era sempre un azzardo, e qualsiasi certezza era sgretolata dal dubbio. mi piace come viene descritto il gioco di potere: apparentemente assoluto quello di chi assiste, totalmente passivo quello di chi è assistito: tutta apparenza, appunto.
un elemento che mi colpisce sempre nei testi notevoli e intelligenti di Christian, è la cifra, il tasso di un cinismo che proviene da una disperazione di fondo, forse quella della sua generazione: studiata, preparata, colta e senza speranza. mi chiedo quale felicità terrena si immagina di non riuscire a realizzare, ma non ho ancora capito.
i miei complimenti,
cristiano
il corpo delle persone handicappate è uno di quei grumi di senso con cui la nostra società si ostina ancora a non voler fare i conti: si aprono le porte delle scuole, si moltiplicano categorie diagnostiche e ipocriti scivoli sui marciapiedi ma si continua a guardare loro come a esseri privi di memoria e desideri, angeli senza sesso.
Nel mondo della scuola, poi, la scotomizzazione per questo pezzo di realtà raggiunge livelli scandalosi e i ragazzi (tutti, normodotati e diversabili) vengono lasciati spesso soli con i loro dubbi, le loro fragilità i loro fisiologici pruriti. E’ assai più facile volgersi dall’altro lato, mettere a tacere, distrarre e distrarsi.
Grazie per questo bel contributo