
Questo pezzo è uscito sul Venerdì di Repubblica.
“La morte è sempre associata a una cifra, non possiamo nominarla senza metterle davanti un numero”. Così lo scrittore colombiano Sergio Álvarez, che nel titolo del suo terzo monumentale romanzo davanti alla parola morte ha messo un 35. “Dal momento che la storia racconta trentacinque anni della Colombia”, continua lo scrittore, “ho giocato con l’ironia, e già nella prima pagina del libro si supera di gran lunga il numero di morti evocati dal titolo”. 35 morti (La Nuova Frontiera, pp. 480, 19 euro) è un romanzo pubblico e privato, che del protagonista racconta la vita (dal 1965, quando nasce, al 2000), e della Colombia tutte le contraddizioni della seconda metà del Novecento. Dentro ci sono viaggi, c’è criminalità, amore e violenza, e la capacità di incantare il lettore narrando. Dieci anni per scriverlo, raccogliendo materiale d’ogni sorta per costellarlo di verità e storia. Ancora Álvarez: “Dieci anni per scoprire che non si finisce mai di scrivere un romanzo e che bisogna solo abbandonarlo e metterlo in mano agli editori”.
La sua Colombia lei ha deciso di raccontarla in forma di romanzo. Quanto la finzione avvicina alla realtà?
Il libro parte dalla realtà colombiana, è un tentativo di mettere in parole il misto di atrocità e vitalità in cui viviamo. Ma la realtà è così complessa e a volte così inenarrabile che la finzione subentra e aiuta a ricostruirla. Sarebbe quasi impossibile raccontare la Colombia senza finzione né ironia.
La critica ha definito 35 morti un “antiromanzo”. Ci si ritrova nella definizione?
35 morti può essere definito in qualsiasi modo. Si potrebbe anche dire che è un libro incompiuto e che si continuerà a scrivere per molti anni perché i personaggi che vi compaiono vivranno nuove storie e avranno nuove versioni. È accettabile la definizione di antiromanzo per il costante fallimento del protagonista, ma potrebbe anche essere un romanzo storico o d’avventura o, infine, una riscrittura del feuilleton latinoamericano sotto forma di libro.
O un romanzo d’amore. Possiamo essere testimoni o attori delle peggiori delle guerre, e però l’amore è la cosa che più di ogni altra ci devasta. È così, no?
La guerra distrugge i paesi, ma soprattutto distrugge a livello affettivo tutti coloro che ne vengono coinvolti. Inoltre, ci inventiamo guerre personali in mezzo alla pace e per l’essere umano sono guerre ancora più devastanti rispetto a quelle economiche e politiche.
Quanto è autobiografico il tutto?
Non saprei quantificare, ma scrivere 35 morti è stato un esercizio di esorcismo, mi ha aiutato a scardinare molte paure e tensioni che mi portavo dentro dall’infanzia. Il libro mi ha aiutato a sanare il rapporto con il mio paese e mi è servito come scusa per guardare con ironia storie personali che non avevo mai affrontato così tanto da vicino e così lucidamente.
Alla morte dello scrittore cileno Roberto Bolaño lei ha commentato: “Ci priva di uno scrittore visionario”. Cosa le manca, e più in generale cosa manca della scrittura di Bolaño dieci anni dopo?
Roberto è stato uno scrittore perfetto, è riuscito a inventare un universo ed è riuscito a far sì che i personaggi e le storie che creava dentro questo universo ci facessero innamorare e rimanessero impressi per sempre nella nostra memoria. Mi manca poter continuare a leggere queste storie e questi personaggi e, in realtà, poterlo vedere a passeggio per Barcellona con quella sua andatura così pacifica che era impossibile indovinare che dentro di sé ospitasse un’autentica bomba atomica letteraria.
È nata a Bolzano e ha vissuto ad Algeri e Palermo. Abita tra Roma e New York, dove traduce e scrive di libri, cinema e fumetti per La Repubblica, Il venerdì e D. Ha tradotto, tra gli altri, Charles Bukowski, Tom Wolfe, Jacques Derrida, A.M. Homes, Douglas Coupland, James Franco, Lillian Roxon e Lena Dunham, e ha tradotto e curato la nuova edizione italiana di Jim entra nel campo di basket di Jim Carroll (minimum fax, 2012). Insieme a Daniele Marotta è autrice del graphic novel Superzelda. La vita disegnata di Zelda Fitzgerald (minimum fax, 2011), pubblicato anche in Spagna, Sudamerica, Stati Uniti, Canada e Francia.

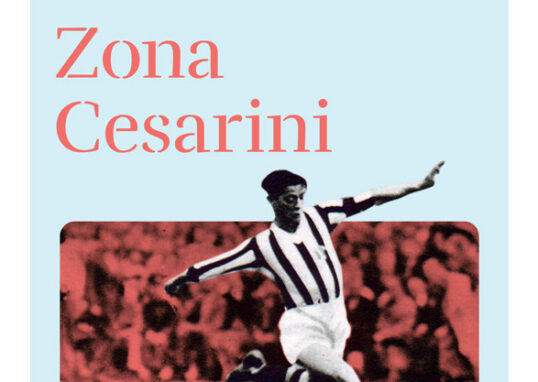


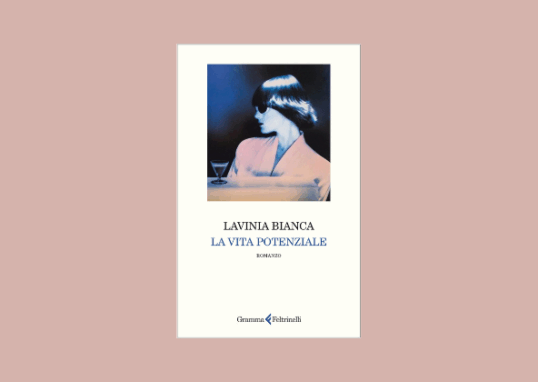

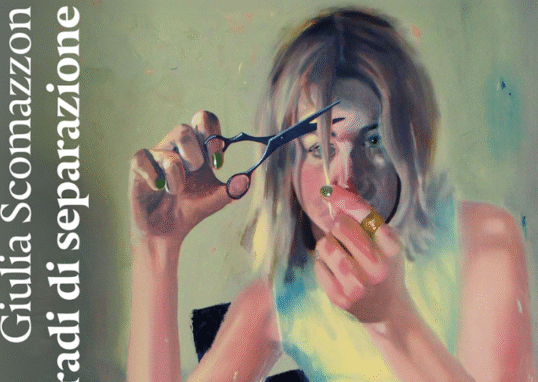
3 commenti