
di Teresa Capello
In medias res de L’isola che non c’era di Leonardo Bonetti, prima uscita della nuova Il ramo e la foglia edizioni, si legge di un’iguana, tenuta di giorno dai suoi due ineffabili anziani proprietari come animale da compagnia e la sera rinchiusa in un bungalow, su un terrapieno dentro uno stagno.
In un lampo disperato, gli occhi dell’animale svelano un amore.
«Insomma, la vedi o no?» insiste Aldina.
«Chi?» fa Leo riavendosi.
«Isolina, no? Te l’ho detto».
(…) «È innamorata di te, non l’hai capito? Ha perso la testa, ecco tutto»
L’amore – o per meglio dire la ricerca di senso nell’alfabeto dei sentimenti – è uno dei fili narrativi che vengono tesi nel lungo antefatto del romanzo nel quale Leo, il protagonista, viene brutalmente scaricato da un’amata; decide quindi di imbarcarsi su un peschereccio che lo condurrà su questa strana isola, una specie di Atlantide ionia che non c’è ma va ricercata, una sorta di punctum indistinto tra lo sprofondare e l’emergere.
Quest’isola non c’era. Non compariva nei portolani, immaginosi resoconti redatti dagli equipaggi del secolo decimosesto. Né in seguito nelle descrizioni dei mercanti o degli avventurieri che solcavano il Mediterraneo a loro rischio e pericolo.
Sull’isola le atmosfere di luce, di colore, di silenzio riescono ad essere contemporaneamente cristalline e fredde, in un viaggio che pare essere al termine del giorno. A mano a mano che la narrazione prosegue, si comprende infatti che, per il protagonista, questo percorso è anche rifiuto di una parte di sé e di quello che è stato, un po’ come per tutti coloro che vi giungono, scendendo fuggiaschi sul pontile, in bilico tra passato e futuro.
Il crescendo narrativo della seconda parte rende piacevole scoprire quale sistema sociale possa governare questo bizzarro scoglio, dove le presenze femminili sono assenze, hanno sorrisi bianchi e gelidi e sono costrette ad abbandonare i loro figli dopo averli partoriti. Aldina e gli altri personaggi femminili sono tutti esseri misteriosi che hanno qualcosa di selvaggio, come selvaggio è il mistero che lentamente si viene a scoprire.
La metafora della curiositas del protagonista è il fantasmagorico giardino dove i proprietari Arsenij e Oleksandra tengono prigioniera l’iguana.
Vi si possono trovare pitoni, anaconda, tartarughe, uno strepitoso serpente del latte che imita in modo pressoché perfetto il corallo, suo temibile gemello; un serpe del grano color arancio che manda cattivi odori; un marasso dagli occhi rossi messo dentro una teca sempre sporca – a sentire il Dottor Elwin – tanto da confondersi con lo strame posto nel fondo; e soprattutto un’iguana dal carattere indocile, certa Isolina, che Oleksandra spesso porta in grembo.
È sul lettore, infine, che il romanzo si avvita, gradualmente torcendo la spirale della narrazione come se incombesse la scoperta razionale di un ignoto che – sembra implicitamente affermare Bonetti – si attende perché siamo proprio noi esseri umani ad essere desiderosi di quello che l’ignoto sa dirci a proposito di noi stessi, chiusi nel giardino del nostro narcisismo.
All’inizio Robinson Crusoe, il protagonista Leo nel finale si trova in una narrazione di Buñuel a chiedersi se ci possa essere sia un senso nelle strambe consuetudini degli abitanti dell’isola che non c’era, ad interrogarsi sulla vita comunitaria e sul potere, in un non-luogo dove, ad un certo punto, neppure il corpo sembra avere più consistenza: l’aspetto filosofico infatti prevale, ti lascia con il desiderio di approdare a quel pontile, fermartici a pensare, svuotare di un vuoto momentaneo la tua vita per riempirla di molte domande future.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente

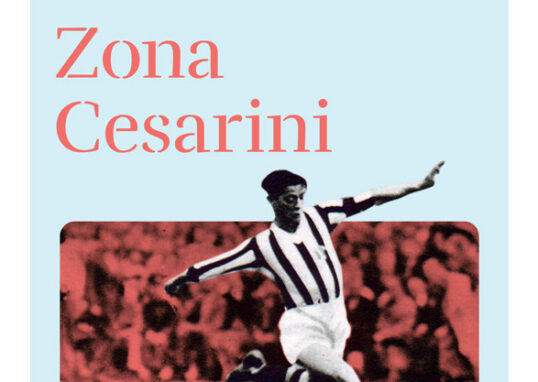

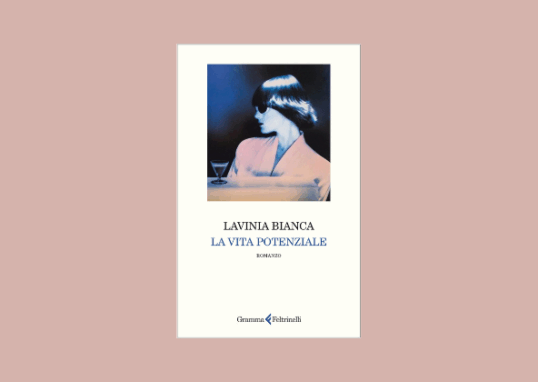


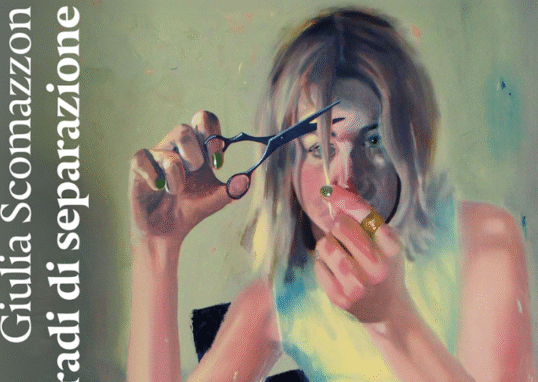
Leggerti è sempre puro piacere. Un blog su cui vale la pena soffermarsi!
Ringrazio Teresa Capello e minima&moralia per questa bella recensione.