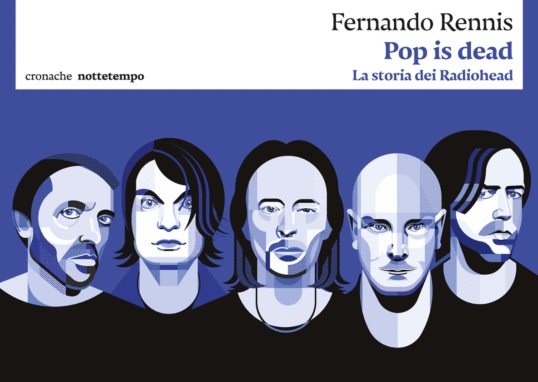Pubblichiamo, ringraziando la rivista e l’autrice, l’intervista di Giada Ceri a Carmelo Cantone (che ultimamente ha fatto parte della Commissione presieduta da Marco Ruotolo per l’innovazione del sistema penitenziario), uscita sul numero 278 di “Una città”. Si tratta della quarta di una serie di interviste (qui la prima, qui la seconda e qui la terza) a persone variamente impegnate nell’ambito penitenziario per capire se e come la “cultura” possa svolgere una funzione rieducativa in una istituzione totale e che cosa significhi concretamente, oggi, rieducare una persona.
***
Una giustizia che spesso sembra agire con il pilota automatico, mettendo in carcere persone che non hanno commesso reati di grave impatto in termini di pericolosità sociale; l’assenza di una discussione sulla preparazione della dimissione; una popolazione, quella carceraria, che in questi anni è cambiata e dove il disagio psichiatrico si è fatto più intenso e frequente; l’importanza di un approccio fondato sulla riduzione del danno.
Carmelo Cantone è attualmente provveditore dell’amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise e incaricato ad interim quale provveditore della Campania. In passato ha diretto gli istituti di Padova e Brescia e poi il carcere Rebibbia Nuovo Complesso. Più recentemente ha fatto parte della commissione per l’innovazione del sistema penitenziario presieduta da Marco Ruotolo, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre.
Giada Ceri: Cominciamo dalla parola rieducazione, che a qualcuno piace, ad altri no. Per quanto il carcere si sia dimostrato inadeguato o addirittura dannoso, nello svolgimento di questa funzione, continua a essere considerato non una extrema ratio ma la soluzione.
Carmelo Cantone: Provo a fare qualche considerazione… Ora, all’interno del carcere non ci sono soltanto detenuti condannati, che stanno scontando una pena definitiva e per i quali si deve perseguire l’obiettivo della rieducazione o risocializzazione o reinserimento, che dir si voglia; ci sono anche i detenuti in attesa di giudizio. Troppo spesso, come sappiamo, queste due categorie di detenuti convivono, ma sono persone che hanno esigenze ben diverse. Chi è imputato pensa al proprio processo, alle disgrazie che ha in corso, a come uscirne (o magari al prossimo reato che vuole commettere…). Dall’altro lato il condannato dovrebbe pensare a come guardare al di là della punta del proprio naso, a come impostare un futuro di recupero grazie anche alle sollecitazioni che riceve da un ambiente professionale che è appunto quello degli operatori. È un dato di fatto che questo sistema continua a non tenersi in piedi. Noi registriamo ancora una volta il fallimento del sistema carcere, ma non abbiamo un’alternativa al contenitore carcere. Anni fa c’erano i collettivi che parlavano di liberarsi dalla necessità del carcere. Erano gli anni Ottanta. Questo movimento, che si ricollegava a quello dell’antipsichiatria, dell’abolizione del manicomio civile, non ebbe la stessa fortuna; la scommessa è rimasta lì. Non si riesce a liberarsi della necessità del carcere, almeno non oggi. E allora? Allora direi due, tre cose. Una, il carcere, oggi più che mai, deve essere destinato a persone che hanno uno spessore criminale significativo. Per affrontare i casi di disagio sociale significativi e sparsi a macchia di leopardo nel nostro Paese, ma che non appartengono al crimine organizzato, bisogna trovare altre strade, altri “contenitori”. Non possiamo pensare di risolvere il problema delle plurime recidive continuando a seguire questo percorso di sliding doors, per cui nel tempo la persona rientra in carcere anche per scontare brevi periodi di pena. Ci vorrebbe un’analisi molto più accurata per quanto riguarda coloro che non hanno fatto un percorso senza soluzione di continuità in carcere, ma arrivano direttamente dalla libertà e devono scontare una pena definitiva o un residuo di pena definitiva; il ventaglio delle misure possibili che non siano carcere deve essere allargato, per esempio inglobando anche quei reati che appartengono alla fascia del 4-bis dell’Ordinamento penitenziario, cioè i reati che non sono quelli gravissimi di mafia e criminalità organizzata, ma stanno a metà strada fra questi e i reati – chiamiamoli così – di basso conio. Una truffa, un furto sono reati di basso conio; la rapina, l’estorsione, l’usura, lo spaccio in concorso con almeno tre persone invece sono reati di medio conio, molto frequenti. Su queste categorie, la fascia di basso e quella di medio conio – mi consenta questi termini – che ricomprendono un’umanità veramente molto intensa, si deve e si può fare molto per evitare l’ingresso in carcere. Comunque sto parlando del mondo dei condannati definitivi. Dobbiamo fare in modo che solo le persone che hanno un significativo spessore criminale, anche per i reati che hanno commesso, siano ospitate nei nostri istituti e qui svolgere una batteria di interventi che dovrà essere di sostanza ben più forte rispetto a quanto finora si è riusciti a ottenere. Poi c’è il mondo degli arrestati dalla libertà. Tutte le belle cose che ho detto prima vengono messe in crisi dal fatto che nel nostro Paese c’è una tendenza a procedere all’arresto (che porta in carcere) di persone che hanno commesso reati di non grave impatto in termini di pericolosità sociale né, spesso, di danno alla collettività. Il furto di una bicicletta… Ricordo proprio dei casi specifici che mi sono capitati. Nel momento in cui arresto un ragazzo di vent’anni del Ghana – ci possiamo immaginare: totalmente decontestualizzato – che ha rubato una bicicletta, il ragazzo comincia a reagire e commette resistenza, se non addirittura violenza, nei confronti del pubblico ufficiale. In questi casi dovremmo trovare un’altra risposta, perché quando questa persona entra in carcere possono sorgere non solo problemi significativi di adattamento all’ambiente carcere, ma in generale di disagio psichico. E qui le nostre risposte troppo spesso sono flebili. L’approntamento dell’accoglienza del disagio psichico come servizio sia psichiatrico che psicologico è insufficiente. Per quanto riguarda il magico mondo degli arrestati dalla libertà, il problema non è più solo del mondo penitenziario, ma va analizzato anche con le altre grandi agenzie, magistratura e forze di polizia operanti, e di questo dev’essere fatta una sintesi politica. Le forze di polizia operanti troppo spesso vanno avanti con il pilota automatico. Mi spiego. Se viene emesso un ordine di esecuzione per una condanna a pena detentiva da una certa procura, questo viene trasferito alla forza di polizia competente, che va a prendere la persona e la porta in carcere. Come provveditorato di Roma coordiniamo noi le assegnazioni dalla libertà in carcere, perché con il problema delle custodie cautelari e delle quarantene c’è una grandissima difficoltà, giorno per giorno, ad avere posti disponibili negli istituti, e quindi vediamo più concretamente e da vicino chi portiamo in carcere. Ebbene, capita, è capitato di portare in carcere persone che devono scontare una condanna definitiva a tredici giorni, a sette giorni… Un sistema di questo tipo non può funzionare. Se la forza di polizia vede che la persona rintracciata al suo domicilio per essere arrestata ha dei problemi di salute, la porta comunque in carcere. Come dicevo, scatta il pilota automatico. Poi magari il giorno dopo bisogna chiedere la scarcerazione provvisoria: ma intanto è entrata in carcere. Lì c’è una rete di intervento importante che dovrebbe essere attivata… È vero che quando si parla di reati penali si parla di fatti che vanno ricondotti alla fattispecie normativa. Quindi una soluzione definitiva non c’è. È necessario un certo tipo di sensibilità, di cultura all’interno del Paese, delle varie agenzie, soprattutto da parte delle forze dell’ordine, delle autorità giudiziarie, da parte nostra, per fare in modo che si diano risposte mirate, ragionevoli, cercando di evitare che si portino all’interno del carcere dei buchi neri, delle palline impazzite, e che si faccia più male alle persone di quanto non se ne siano fatto loro. In fondo non è un tema nuovo.
Dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere la ministra della Giustizia e il presidente del Consiglio sono andati a visitare quell’istituto, che è parte di un mondo organizzato in una certa maniera e resistente ai cambiamenti. Che cosa rappresenta quella visita secondo lei?
È stata un momento importante per la caratura del nostro premier e per quella che esprime la nostra attuale ministra. Hanno avuto la possibilità di vedere, di percepire. È importante che la visita l’abbia fatta il presidente del Consiglio, perché la ministra, in alcuni ruoli passati e soprattutto come giudice della Corte costituzionale, certi istituti li aveva già visitati; il premier no. È stato importante questo “assaggio”, con la possibilità di girare nei reparti, al di là della sua valenza simbolica – pur essa importante, perché adesso si tratta di mettere un punto, di dare un messaggio. Che è stato recepito benissimo dai detenuti, ma anche dal personale. Tutto quello che è accaduto e la visita devono consentire più che una ripartenza: un rinascimento vero e proprio, una costituente dell’amministrazione penitenziaria. Se non accade ora non so quando potrà avvenire. La vicenda di Santa Maria Capua Vetere per certi aspetti è la punta dell’iceberg, non solo rispetto ai diritti dei detenuti che sono stati violati, ma anche rispetto al malessere che tutti gli operatori penitenziari in tutte le realtà manifestano. Il valore della visita è fondamentale. Da lì si parte, e bisogna essere conseguenti a livello politico, con una capacità non solo di ascolto – che c’è – ma di sintesi e di comprensione della reale valenza del problema. C’è da fare una diagnosi corretta della situazione, e la diagnosi viaggia sulle gambe delle persone che conoscono quello di cui stanno parlando e hanno l’onestà intellettuale di dire con schiettezza quali sono i problemi. Poi c’è la cura, e la cura non è di poco conto. Bisogna decidersi a investire bene le risorse economiche e indirizzarle nella giusta direzione. Se continuiamo a parlare di costruire nuovi istituti per affrontare il problema del sovraffollamento… Il problema del sovraffollamento c’è oggi, c’era ieri, continuerà a esserci domani. È ben noto che la crescita dell’offerta aumenta la domanda.
Lei dice che è ben noto, ma siamo certi che lo sia anche al di là della cerchia degli addetti ai lavori? Il cittadino comune non legge riviste specialistiche, non partecipa a webinar su rieducazione, reinserimento, riparazione del danno e così via. La sua conoscenza del carcere viene in gran parte dagli organi di informazione.
Io continuo a sostenere che con la stampa non si fanno buoni affari. Ma la cosa non mi scandalizza. La comunicazione purtroppo non funziona per i soliti motivi, cioè perché dal punto di vista giornalistico e commerciale parlare e sbattere sul video le immagini, per esempio, di Santa Maria Capua Vetere è più interessante che parlare dei casi in cui gli agenti hanno salvato la vita delle persone. Su questo bisogna essere molto pragmatici. Nel mondo penitenziario non dobbiamo avere la tentazione di dettare l’agenda alla stampa: non se ne viene fuori. Quindi, qualche prezzo si paga, qualche pezzo si perde, quando ci sono degli usi della stampa assolutamente scorretti, fino ai casi macroscopici: il giornale Cronache di Caserta ha sbattuto i volti con i nomi, le qualifiche e addirittura le residenze di persone indagate e soggette a misure. Persone che vivono tra l’altro in territori piuttosto difficili, com’è la Campania. Cosa vogliamo fare, la caccia all’uomo? Questo è un uso giornalistico vergognoso. A questo livello francamente non si era mai arrivati… Ma comunque: corriamo il rischio di un’informazione di stampa distorta, che non aiuta a comprendere cos’è il mondo penitenziario, e ribaltiamo il ragionamento. Il fatto è che noi troppo spesso, come operatori penitenziari, continuiamo in un’ottica difensiva a dire, come Montale, “che cosa non siamo e che cosa non vogliamo”, mentre in un’ottica di attacco, di azione, di investimento dobbiamo presentare il “prodotto” carcere con i suoi problemi e le sue potenzialità. Le potenzialità possono essere tante: quello che si fa dentro gli istituti, gli investimenti sul recupero di non poche persone, anche i lavori di pubblica utilità, per quanto su questi direi adelante cum judicio. Si rischia infatti di strizzare l’occhio a quelle agenzie pubbliche che, utilizzandoli, non fanno altro che risparmiarsi un costo. In effetti non costano quasi nulla: il condannato che esce dal carcere per fare lavori di pubblica utilità, come sappiamo, non viene retribuito. Questa logica non mi sembra troppo lontana dalla logica dei lavori forzati. Mi è conveniente, quindi gli faccio pulire il parco cittadino e siamo tutti contenti… Meglio questo che stare dentro? D’accordo, però il messaggio rischia di essere equivocato. Noi dobbiamo puntare a immissioni all’esterno di più ampio respiro, dove la persona abbia un lavoro non dico necessariamente appagante, ma che comunque comporti una retribuzione, un impiego del tempo… Un lavoro che lo rieduchi alla fatica come per tutti noi che viviamo nella società libera. Abbiamo tante opportunità che, ripeto, devono consentire di presentare alla collettività esterna il lavoro che facciamo e soprattutto l’importanza di non fermarsi ai luoghi comuni sul carcere.
Un ruolo fondamentale, nella riabilitazione della persona detenuta, dovrebbe averlo l’istruzione. Eppure non è così, dell’istruzione si ragiona molto meno che del lavoro. Una volta fuori, i detenuti che possono accedere alle misure alternative ma hanno un’istruzione scarsa o sono addirittura analfabeti come vivranno?
Nel nostro Paese, e nel nostro mondo, manca una cultura della preparazione della dimissione dal carcere. Parliamo molto di misure alternative, ma dobbiamo pensare anche a quelle persone che non hanno ricevuto una misura alternativa e, per esempio fra tre mesi, usciranno dal carcere. Quale preparazione c’è? Già non andava bene prima, ma la situazione si è aggravata, secondo me, quando si è deciso di sganciare la cosiddetta esecuzione penale esterna dal mondo penitenziario. Adesso sono due dipartimenti diversi. E, com’era inevitabile (dalla pandemia in avanti, poi, non ne parliamo), per quanto siano sempre importanti i rapporti fra noi e i nostri cugini del servizio sociale penitenziario, gli operatori dell’esecuzione penale esterna si sono allontanati dal carcere e si è registrata quella flessione che rende ancora più difficile, per esempio, la preparazione della dimissione dall’istituto. Una persona senza fissa dimora, che non ha nulla, sta in carcere e non può avere la detenzione domiciliare. Fra tre mesi, comunque, uscirà. Ha un valore il preparare la sua dimissione? Siamo arretrati molto su questo versante. Dalla pandemia in poi abbiamo registrato due arretramenti importanti: quello che ho appena detto e quello che riguarda l’istruzione. Sì, è vero, l’istruzione scolastica ha avuto un percorso delicato, di difficile crescita negli anni passati, però questa crescita c’è stata, ci sono state delle piazze importanti. Non poche. Non citiamo solo la solita Volterra… Penso alle decine e decine di istituti in giro per l’Italia, da nord a sud, dove, avendo fortunatamente anche degli interlocutori motivati nei circoli didattici esterni, si sono costruiti percorsi scolastici di qualità a tutti i livelli. Questo, è chiaro, il lockdown lo ha frenato. Hai voglia a dire: la didattica a distanza… C’era il problema di riuscire a garantire davvero questa didattica con gli strumenti che si avevano. Adesso, pian piano, io penso già dal 2021-2022, ci sarà una forte ripresa, che però va accompagnata con percorsi di istruzione scolastica. Se gli insegnanti interpretano il loro compito in carcere, come non sempre ma spesso accade, come un ruolo davvero molto elevato, i percorsi di istruzione sono delle occasioni molto importanti. Da alcuni settori mi viene segnalato che si rischia di arrivare al 2021-2022 con la riduzione delle classi. È anche vero che i detenuti sono diminuiti dalla pandemia in poi (meno male). Nel mio distretto, Lazio-Abruzzo-Molise, siamo passati dai 9180 detenuti circa di gennaio e febbraio 2020 alle 7600 unità di oggi, però questo ha comportato il fatto che non la domanda, ma l’offerta scolastica è stata penalizzata. C’è il rischio di perdere qualche classe. A fronte di questo c’è la voglia da parte di tutti di allargare i percorsi. Nel mio distretto, per esempio, laddove è possibile si allargano i percorsi della scuola secondaria di secondo grado. Ci sono istituti medio-grandi che non offrono solo un percorso, ma due o addirittura tre. Penso al carcere di Rebibbia femminile, per esempio.
Molti dei detenuti che più ne avrebbero bisogno alla scuola non ci arrivano, per ragioni diverse. Una detenzione breve, un trasferimento, problemi di tossicodipendenza o di natura psichiatrica…
Il problema psichiatrico oggi è molto più serio rispetto a qualche anno fa. Piano piano, senza che ce ne accorgessimo, la popolazione detenuta è cambiata. Non che venti o trent’anni fa fosse facile, ma oggi c’è una presenza molto più consistente di soggetti con forte disagio psichico –chiamiamolo così, in modo generico. Persone che non si ritengono tossicodipendenti, che vengono spesso (non sempre) dai Paesi dell’Africa centrale o del Maghreb, di giovane età, oppure ragazzi che vengono dalle nostre periferie più disagiate e che sono abituati a farsi le sostanze più disparate. Sostanze che comportano danni anche neurologici molto gravi. Questo spiega l’aumento del senso di aggressività all’interno degli istituti. L’aumento delle persone classificabili come problematiche non è un dato generalizzato, ma, ci piaccia o meno, è un dato importante, e questo penalizza la vivibilità per tutti, anche per quelle persone che vogliono fare una detenzione tranquilla. Verso quali percorsi ci muoveremo? Beh, questa è l’occasione buona per capirlo. Bisogna creare dei percorsi differenziati all’interno del carcere fra chi, indipendentemente dallo spessore criminale, avrà voglia di fare una detenzione tranquilla e, se possibile, magari positiva e chi, invece, richiede una cifra securitaria più forte ma allo stesso tempo anche più trattamento, più attenzione. Non si possono tenere nella stessa situazione persone molto diverse. Dal Lazio in su questo è un leitmotiv continuo. Sollicciano, in questo senso, è esemplare.
Ecco, in condizioni non generalizzabili ma molto diffuse come quelle che lei descrive quale senso può avere la parola rieducazione?
La parola più giusta è reinserimento, non rieducazione, che in effetti è un termine – come potrei definirlo? Criptocattolico. Ce lo trasciniamo dal ’48, anche negli anni seguiti alla riforma dell’Ordinamento penitenziario ci siamo baloccati con questa parola. “Reinserimento” ci sta. “Riabilitazione” continua a essere un po’ troppo forte. Quindi: possibilità di ritorno in condizioni dignitose nella società civile. Ma ci sono due drammi che toccano direttamente il nostro mondo penitenziario: da una parte, la pressione dal sud, soprattutto, e dall’est del pianeta, perché vengono tante persone oneste, che hanno voglia di lavorare (siano più o meno in regola) e nessuna voglia di delinquere, ma in proporzione aumenterà anche il numero delle persone destinate a commettere reati; dall’altra, il fallimento delle nostre periferie, le periferie dei grandi centri urbani. Roma è una città difficilissima per chi la vive giorno per giorno, Napoli non ne parliamo, ma anche Bologna, un po’ Firenze, e Milano, Torino, Genova. Nelle grandi città, ma anche in quelle meno grandi, noi registriamo il fallimento delle periferie. Non a caso lo scorso anno, con le sommosse che ci sono state, nel nord Italia si trattava soprattutto di detenuti stranieri, gente che non aveva niente da perdere e si è lanciata in modo quasi irrazionale in quelle proteste con i risultati che abbiamo visto; ma nei grandi istituti, a Roma e a Napoli quelle sommosse sono state la punta dell’iceberg di un’umanità che proviene dalle grandi periferie urbane, che è a servizio, magari, della grande criminalità, pur non essendo composta da grandi criminali. Come si spezza questo meccanismo? Lo si deve spezzare prima, non all’interno del carcere. Il carcere potrà fare qualcosa per queste persone, potrà creare delle buone occasioni, ma sui grandi numeri questo meccanismo si spezza nel momento in cui cambia il volto delle nostre periferie. Nel momento in cui non diventano dei pesi per il resto della collettività, per l’alta, media, piccola borghesia normata, ma dei laboratori, dei luoghi di opportunità per la ricostruzione, anche in generale, del nostro Paese.
Sempre più spesso si parla di giustizia riparativa…
Di giustizia riparativa si è cominciato a parlare con maggior forza negli ultimi anni e questo macrotema avrà fortuna anche nel prossimo futuro, su questo non ho dubbi. Basti pensare anche all’attenzione che vi sta ponendo la nostra ministra. Certo il verbo della giustizia riparativa, della mediazione penale, si afferma all’interno del carcere con maggiore difficoltà. Questi percorsi però si stanno allargando. Non mi attendo un successo esponenziale, ma un graduale aumento dei casi in cui le équipe riescono a investire su percorsi di riparazione sì, questo sì. Sarà un percorso molto più lento di quello che è stato fatto nel mondo della giustizia minorile e di quello che, più timidamente, si sta facendo con le persone che si trovano in libertà e che per esempio dal 2014 in poi hanno cominciato ad accedere alla cosiddetta messa alla prova. Lì chiaramente è più facile perché parliamo di reati bagatellari, spesso ci si confronta con autori di reato che non hanno perso la sensibilità verso un ristoro della vittima attraverso i lavori di pubblica utilità. Per le persone che vivono in carcere questo risulta più difficile. Pensiamo per esempio a tutte le condanne che riguardano i delitti contro il patrimonio. Parliamo di storie già abbondantemente consumate, di piccoli o grandi drammi già chiusi. La rapina, anche se di rapine se ne vedono molte meno rispetto a venti, trent’anni fa, comporta un percorso penale di un certo tipo. Se fino a un certo punto non c’è stato un avvicinamento tra vittima e autore del reato è difficile immaginare che, a distanza di anni, quando si arriva alla condanna definitiva, si possa riavvolgere il nastro.
Nella situazione odierna il lavoro dell’operatore penitenziario in molti casi si avvicina piuttosto a quello dell’assistente sociale.
Una cosa che accomuna gli operatori è la sensazione di togliere l’acqua dal mare con un cucchiaino.
L’impressione che vado raccogliendo in queste conversazioni sul carcere, in effetti, è che almeno due cose siano necessarie a chi ci lavora: dotarsi di un cucchiaino e resistere alla stanchezza.
Mi piace questa metafora.
C’è anche quella del colibrì, che mentre porta acqua nel becco per spegnere l’incendio nella foresta dice: io faccio la mia parte. Lei quanti anni sono che lavora in carcere?
Quasi trentotto.
Ha visto il carcere nei suoi vari momenti, alti – pochi – e molti bassi. Ritiene possibile una sua evoluzione che non si riduca al tirare la coperta un po’ da una parte e un po’ dall’altra? Un po’ di lavori di pubblica utilità e misure alternative e un po’ di giustizia riparativa, qualche padiglione e magari l’acqua calda nelle docce…
Io vedo un’evoluzione positiva possibile se finalmente si investono risorse economiche in modo calibrato, serio. Allora vedremo una spinta, un cammino. In questi anni sono state tagliate le risorse nel campo dell’edilizia e della manutenzione straordinaria, il personale è stato ridotto in tutti i settori (questo è un dramma in tutta la pubblica amministrazione)… Lei va in un carcere di medie dimensioni, sei-settecento persone, e quanti educatori ci sono? Questo è sotto gli occhi di tutti. Quindi: investire sul carcere per portare a casa certi risultati. Altrimenti arrivano le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che ci bacchetta e rimaniamo in un’ottica difensiva, a volte magari inutilmente giustificazionista. Continuiamo a dire che cosa non siamo e che cosa non vogliamo.
L’avvocato Michele Passione in un’intervista precedente ha detto: volevo fare la rivoluzione, ora mi accontento di migliorare significativamente le cose. Riduzione del danno, dunque. La sua prospettiva qual è?
Mi pare che la logica debba essere questa. Ma per ridurre il danno bisogna essere attivi, propositivi. Ridurre il danno significa far crescere il sistema, non è un lavoro di rammendo.
Quindi bisogna comunque un po’ fare la rivoluzione?
Su certe questioni, anche se non avremo l’abolizione del carcere, bisogna comunque essere un po’ rivoluzionari, come lo fu il mio primo capo di dipartimento, Nicolò Amato. Che poi essere rivoluzionari in questo Paese spesso significa riuscire a fare le cose normali…
Giada Ceri (Firenze, 1972) ha lavorato presso case editrici, riviste (“Exibart” e “Testimonianze”), organizzazioni del Terzo settore impegnate nell’ambito penitenziario. Ha insegnato la lingua italiana a persone straniere (soprattutto migranti e immigrate). Dal 2020 lavora come docente di materie letterarie nella scuola secondaria di primo grado. Ha pubblicato “L’uno. O l’altro” (Giano Editore, 2003), “Il fascino delle cause perse” (Italic Pequod, 2009), “Gli imperatori. Sei volti del potere” (Melville Edizioni, 2016), “La giusta quantità di dolore” (Exòrma Edizioni, 2018). Nel 2014, per la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, ha curato il Quaderno «È una bella prigione, il mondo» sui temi del carcere italiano contemporaneo. Ha scritto per volerelaluna.it e attualmente collabora, oltre che con minima&moralia, con la rivista «Una Città» e il blog «Il primo amore».