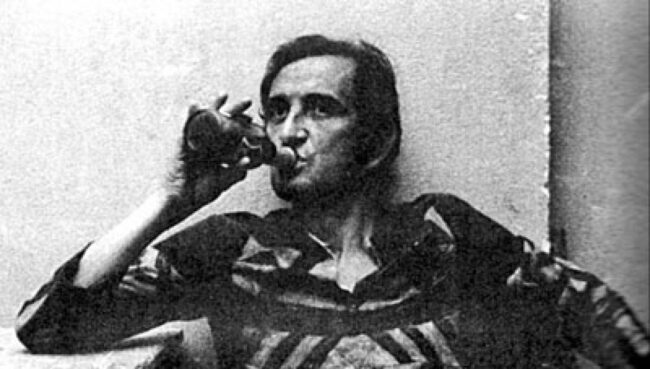
di John Vignola
Nel 2016 Goffredo Fofi mi chiese di scrivere un piccolo pezzo per ricordare l’unicità di Piero Ciampi, che poi uscì ne Lo Straniero di settembre di quell’anno.
Lo ripropongo in rispetto e in ricordo di uno dei miei padri intellettuali (parentela che, mentre era in vita, per pudore, non mi sarei mai immaginato di comunicargli), perché credo che il racconto di come era Piero a Fofi piacesse, non poco.
***
In un giorno d’inverno, proprio all’inizio del decennio dell’egoismo, Piero Ciampi partì per andare “a cena sulle stelle”. Trovò una carta dei vini imbattibile e decise di fermarsi. In quanto poeta, fra un calice e l’altro ebbe tempo di riflettere su come la parola “scomparso” possedesse per lui una doppia valenza. La prima era di puro stampo burocratico: “Piero Ciampi, scomparso il 19 gennaio 1980“. La seconda aveva invece connotati umani invero un po’ tristi: “Piero Ciampi, musicista livornese scomparso dal ricordo di quasi tutti persino prima della dipartita ufficiale”.
In realtà, il futuro ha risarcito un epitaffio così perentorio: oggi un cd dal vivo di Bobo Rondelli (Ciampi ve lo faccio vedere io) e una breve antologia dedicata a Piero (Il meglio di Piero Ciampi), raccolti insieme per Sony music, ci permettono di riallacciare qualche filo, ricordando che questo livornese, più che cantautore, era semplicemente un poeta.
di John Vignola
Fu verso il 1994 che si ricominciò a parlare di Piero Ciampi. Difficile spiegare il perché, tuttavia si può azzardare un paragone con la riscoperta più o meno contemporanea del cantautore inglese Nick Drake. L’artista che non vuole o non sa curarsi del proprio tempo è da quest’ultimo trattato con uguale fastidio. Si crea una sfasatura che solo un altro tempo può risistemare. Un altro tempo e un’altra situazione. Prima abbiamo definito Nick Drake “cantautore” e lo stesso termine era stato associato a Piero. In Italia se si dice cantautore si pensa a personaggi irsuti e politicizzati legati a un paese che, durante gli anni 70, credeva di vivere un grande cambiamento ‘verso sinistra’, un cambiamento destinato a rivelarsi illusorio. Piero Ciampi questa illusorietà magari non l’aveva colta razionalmente, ma di certo l’aveva fiutata e dunque era stato giudicato poco in sintonia con il sentire collettivo, proprio lui che si definiva anarchico e comunista. (Allo stesso modo Nick Drake poco aveva a che fare con l’idealismo più apparente che sostanziale degli hippie a cui esteriormente somigliava.) Occorreva dunque che quelle illusioni venissero sradicate e lasciate sul terreno a seccare perché non potessero mai più ricrescere. Trascorsi i vituperati anni 80, occorreva un’epoca smarrita e forse indifesa, ma anche curiosa di mille cose (dopo essersi affrancata da mille preclusioni ideologiche), perché Piero Ciampi divenisse un punto di riferimento. Ed ecco che quasi a metà dell’ultimo, affaticato decennio del cosiddetto secolo breve accaddero contemporaneamente due cose: un po’ ovunque in Italia giovani musicisti cresciuti con maestri ben poco cantautorali quali Joy Division e Birthday Party scoprirono l’esistenza di questo livornese inquieto e geniale al pari di Ian Curtis e Nick Cave e che, come loro, metteva a nuda la propria anima, ma lo faceva in lingua italiana. Insomma una figura assolutamente unica. Intanto a Livorno, c’era chi decideva che non si poteva lasciare nell’oblio un artista cittadino che aveva la stessa grandezza scapigliata di Amedeo Modigliani.
Non a caso La Repubblica così presentò la prima edizione del Premio Piero Ciampi, che ebbe luogo il 14 e 15 dicembre 1994: “Livorno ricorda Ciampi con i giovani rocker italiani”. Rocker strani, più interessati alla poesia che ai decibel, ma pur sempre rocker. Ecco l’elenco di chi salì sul palco del Teatro 4 Mori la sera del 14 dicembre: Frankie Hi-NRG, Ottavo Padiglione, Mau Mau, Diaframma, Settore Out (con Maroccolo, Magnelli, Ferretti dei C.S.I.), Yo Yo Mundi, La Crus, De Corto.
Ci volle poco perché il Premio Ciampi divenisse effettivamente… ciampiano, perché si cominciasse a lavorare a quell’opera collettiva che possiamo definire “il nostro Piero”. Forse fu anche merito di un posto, un posto che nei ricordi sembra quasi un sogno. Nei primi anni del premio, artisti, giornalisti e componenti la giuria erano ospiti di Villa Morazzana, sulle colline intorno a Livorno: vetrate liberty, vista sul Tirreno, un grande parco intorno e le prime case a mezzo chilometro. C’era sempre qualcuno che suonava, c’era sempre qualcuno con cui parlare; nacquero amicizie, collaborazioni, forse amori. Quanto ai post-concerti, duravano fino alle tre-quattro del mattino. E si beveva parecchio, ovviamente. Un ricordo personale molto bello: una ragazza che stava scrivendo una tesi di laurea su Gram Parsons (guarda caso altro personaggio riscoperto dopo lungo oblio quale maestro del suono roots) arrivò a Villa Morazzana per intervistare Sid Griffin, autorevole musicista statunitense nonché biografo di Parsons. Griffin parlò con lei a lungo e poi, per spiegarsi meglio, le suonò quattro o cinque canzoni di Parsons, proprio come se fosse un concerto per una sola, stupefatta ascoltatrice (in verità chi scrive transitò più volte nei paraggi facendo finta di nulla).
Nel corso di questi vent’anni il Premio Ciampi ha visto arrivare a Livorno centinaia di musicisti. A ottobre, ora al Teatro Goldoni, felicemente restaurato, si rinnova ogni anno non il rito del ricordo, ma una manifestazione che premia chi scrive canzoni nel segno di Piero.
E oggi, complice l’uscita di questa breve antologia, unita all’omaggio di un suo concittadino, Bobo Rondelli, altrettanto sfuggente e furioso, si può dire questo di Piero Ciampi,: che è stato capace, per indole o per abitudine, magari per entrambe, di cambiare l’idea della cosiddetta canzone d’autore e di portarla da qualche altra parte.
La sua vena anarchica, la sua spontaneità, il suo andare controcorrente in maniera così vitale, inesorabile, sono diventate qualcosa di tremendamente vicino a quella rivoluzione punk che, quando incideva le sue canzoni più importanti, non era ancora arrivata.
Ovviamente, Piero Ciampi non è stato un punk, anche se, come i punk, non sapeva suonare bene nessuno strumento. Come loro amava provocare, come i maestri della beat generation americana amava confondere vita e arte (pagando spesso questa scelta a caro prezzo) e lo faceva non come gesto studiato davanti allo specchio, ma come scelta inevitabile; quasi ogni sua parola è poesia, quasi ogni sua azione ha una potenza drammatica e diventa subito racconto. Gianni Marchetti costruì addosso ai suoi versi un vestito melodico, struggente, certe volte ridondante, ma lui non seguiva quasi mai le melodie, oppure le abbandonava per poi recuperarle quando sembrava troppo tardi.
Il suo modo di declamare le canzoni è più vicino alla poesia, ma le rime sono tutt’altro che baciate. Le storie attingono dalla sua esperienza personale, ma non sono solo brani di vita vissuta, magari male; riescono a essere epiche e picaresche, commoventi e grottesche fino a comporre un grande affresco umano degno, senza esagerare, di Musil e Carver. Sono storie impressionanti, perché Piero sapeva usare in maniera molto personale la voce. Una voce inconfondibile, paurosa, drammatica: non quella di un attore, ma, appunto, di un poeta come pochi, almeno nel mondo della musica sospesa fra i Festival di Sanremo e qualcosa che non si riesce a definire bene, per cui si usa il termine ‘d’autore’ con scarsa convinzione (degli artisti).
Non è un caso, alla fine, che il paragone tante volte tentato con Luigi Tenco allontani entrambi da qualsiasi appartenenza, che la passione di entrambi per il jazz li smarchi dall’ossessione italiana per il melodramma e che, alla fine, la gloria, se così si può dire, postuma, sia legata a questo precorrere i tempi che è assolutamente inconsapevole e al tempo stesso geniale.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente



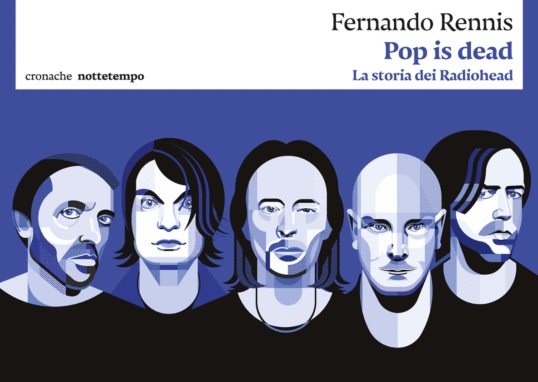



Buongiorno a tutti.
Mi chiamo Marie Therese Letacon, sono un prestatore di denaro professionista con contratto privato con diverse banche e istituti finanziari.
Il nostro obiettivo comune è quello di incoraggiare e sostenere le persone in difficoltà finanziarie.
Siamo dinamici nel concedere un prestito in 48 o 74 ore in tutta Europa.
Le nostre capacità di prestito vanno da 5.000 euro fino all’importo di cui avete bisogno a un tasso ragionevole del 2%.
Se avete problemi finanziari o difficoltà a chiedere un prestito in banca e siete alla ricerca di un prestito tra privati, contattatemi.
E-mail: mariethereseletacon@gmail.com
Non ci posso credere!
Se dal 9 agosto (un mese esatto) questo post non è stato rimosso, vuol dire che la redazione consente e avalla qualunque cosa venga scritta, compreso la pubblicità degli strozzini! Domani potremmo trovare quella di trafficanti d’armi …
Sai dove te li puoi infilare i tuoi soldi Marie Therese? Il nome è francese, dovresti aver letto Papillon!
Povero Piero Ciampi, un grande anarchico!