
Pierre Rivière è un contadino normanno che nel 1835, a vent’anni, uccide con lucida e premeditata ferocia la madre, la sorella diciottenne e un fratellino di otto anni per “liberare il padre” – così si esprimerà ripetutamente – dalle angherie di una moglie che ha fatto del contratto matrimoniale un’arma di sopraffazione e di dominio, ora violandolo e ora rivendicandolo a seconda del suo tornaconto.
Negli anni Settanta Michel Foucault e il suo gruppo di lavoro, da tempo impegnati a indagare le forme più sfuggenti – in quanto istituzionalizzate – con le quali il potere esercita il suo predominio anche nelle nostre democrazie liberali, si interessano al caso e pubblicano in volume (Gallimard, 1973; Einaudi, 1976) l’intero dossier della vicenda (perizie medico-legali, verbali di interrogatorio, testimonianze e la preziosa Memoria redatta dallo stesso imputato che, benché privo di istruzione, dà prova di straordinarie risorse da autodidatta), seguito da alcuni brevi saggi di interpretazione e di approfondimento.
Uno di questi, a firma Jean-Pierre Peter e Jeanne Fevret (L’animale, il pazzo, il morto, pp. 193-214), propone dell’intero caso una lettura sociopolitica dai risvolti a mio avviso straordinariamente attuali. In estrema sintesi: l’ordine liberale e borghese nato dopo la Rivoluzione, fondato sull’illuministica uguaglianza di tutti gli uomini, contraddice i suoi presupposti quando delimita il campo della sua stessa agibilità al potere economico e alla forza contrattuale, rendendo nuovamente subalterni quei cittadini che, pur essendo “pari” sulla carta (ormai costituzionale), di fatto non possono che sottoscrivere contratti per loro svantaggiosi, né sono in grado di difendersi da eventuali violazioni degli stessi ulteriormente peggiorative.
Naturalmente – ragionano i due autori – è questo il caso di Pierre Rivière e di suo padre, costretti a subire tutte le torsioni e le manipolazioni cui la madre-tiranno continuamente sottopone gli accordi matrimoniali, incapaci come sono di rivendicare i loro legittimi diritti e, con essi, il loro status costituzionale di “uguali”.
Ora, la scuola di Foucault ha in primo luogo concentrato tutta la sua attenzione sull’universo delle parole in cui viviamo immersi, sulle frasi (“gli enunciati”) che a seconda dei contesti godono di maggiore reputazione e si strutturano in discorsi dominanti, relegando ai margini o soffocando enunciati che avrebbero altrimenti la forza di determinare un radicale cambiamento della mentalità e delle cose; gli studiosi concludono quindi che agli esclusi di fatto come Pierre Rivière, che pure sulla carta dovrebbero essere uguali, è sostanzialmente sottratta anche la voce con cui poter denunciare l’ingiustizia subita e l’ipocrisia imperante, non restando loro altro che l’enunciato di protesta più radicale che esista: l’atto violento, l’atto di sangue che, in questo caso di parricidio, può essere plausibilmente interpretato come un nuovo tirannicidio, dove però il padre-tiranno non è più il sovrano assoluto, ma l’ordine (fintamente) democratico e (fintamente) liberale.
Le suggestioni in chiave attuale sono molteplici, dicevo. Analizzare il campo dei discorsi oggi, descrivere senza pregiudizi ideologici quali frasi e quali parole con il loro peso e la loro diffusione schiaccino e releghino ai margini e dentro asfittiche nicchie altre parole e altre frasi magari più credibili e foriere di inediti sviluppi futuri è a mio avviso un ottimo esercizio di consapevolezza.
L’esempio più efficace è offerto oggi dal Discorso dominante su Putin e sulla guerra in Ucraina, con i suoi enunciati seriali: Putin macellaio e guerrafondaio, l’aggressore e gli aggrediti, i civili uccisi, scuole asili e ospedali bombardati, la minaccia imperialistica all’intera Europa, la “Resistenza” ucraina e i nuovi partigiani contro la rediviva barbarie neonazista dei russi (Putin novello Hitler) etc. etc. Abbiamo visto tutti il fuoco di sbarramento riservato nel dibattito pubblico a chi faceva notare che la Nato aveva per prima “abbaiato alle porte della Russia” e che le guerre, tutte le guerre fanno inevitabilmente strage di civili; a chi avanzava l’ipotesi che in scuole asili e ospedali gli ucraini avessero dislocato i loro centri di comando militari e ammassato le loro armi per ragioni di strategia di per sé evidenti; a chi opponeva un sorriso sarcastico all’idea di una invasione dell’intera Europa da parte di un esercito già impantanato sul fronte ucraino e per altro verso descritto come privo di motivazione e male in arnese; a chi infine non nascondeva il suo disorientamento e la sua nausea a vedere arruolati nelle gloriose file della nostra Resistenza e dei nostri partigiani anche i volontari del battaglione Azov, che la loro fede nazifascista se l’erano fatta stampigliare a inchiostro indelebile sulla stessa pelle.
Avvertiva Foucault che nel campo del discorso, delle frasi che circolano e riempiono le nostre coscienze e le nostre vite, è in atto una guerra permanente per la supremazia, e che anzi ogni vero Potere si sostiene sulla supremazia del discorso ad esso collegato. E gli altri discorsi? Il dossier su Pierre Rivière testimonia con chiarezza le faticose ricomposizioni cui il Discorso dominante di giudici e medici – ceti rappresentativi dell’ordine borghese e liberale – è stato costretto di fronte alla Memoria lucida e spiazzante del parricida: lo si voleva estraneo alla comunità umana degli uguali, prima in quanto mostro, animale, poi in quanto pazzo, ma il suo scritto appare piuttosto il discorso argomentato di uno dei senza voce, un discorso che in concomitanza con l’atto cruento ha trovato la forza e l’occasione di rimuovere la sordina sociale e di essere pronunciato.
Straordinariamente significativa, nella Memoria, la testimonianza che lo stesso Pierre Rivière rende della sua creatività anche verbale, quando conia nomi nuovi per strumenti di sua invenzione: il più importante di essi, il calibene, serve a uccidere gli uccelli e viene sotterrato e dissotterrato come un oggetto sacro cui è legata la speranza di tempi nuovi e più giusti. Non usa le parole del Discorso dominante Pierre Rivière, reclama la giustizia e un mondo diverso che corrisponda a un discorso diverso, associa istintivamente l’auspicata trasformazione ad uno strumento di morte perché il nuovo può venire alla luce solo laddove il vecchio muore, si perde infine perché applica questa ovvia considerazione a sua madre, benché “tiranna”, invece che al Discorso e al Potere dominanti.
Che fine fanno dunque i discorsi “altri”, come vengono screditati, marginalizzati, neutralizzati dal Discorso dominante? Dopo lunghe discussioni tra giudici, medici e organi di stampa Pierre Riviére viene dichiarato pazzo, e le parole di un pazzo notoriamente non meritano neppure di essere prese in considerazione: la denuncia sociale e politica che il suo gesto e le sue parole “altre” rappresentavano viene così immediatamente cancellata.
Qualche sera fa ero a Polignano per il Festival del Libro Possibile e mi ha molto colpito l’analogia con il motivo verbale e concettuale posto da Michele Santoro a cornice del suo monologo. Santoro ha iniziato e ha concluso con la formula antifrastica “Io sono pazzo”, racchiudendo nel mezzo la nutrita serie di argomentazioni che contraddicono punto per punto la narrazione dominante del conflitto in Ucraina e di cui sopra si è dato un piccolo saggio. “Io sono pazzo” è una evidente concessione formale fatta alla prospettiva del Discorso dominante per godere appieno del diritto di parola sancito peraltro dall’articolo 21 della nostra Costituzione. Cittadini di pari diritto sulla carta, come nel caso di Pierre Rivière, dobbiamo poi fare i conti con il campo di forze degli enunciati e delle idee, in cui quelli dominanti – cui corrisponde di fatto un Potere tutt’altro che egualitario – sono così pervasivi ed esclusivi da inglobare anche la nicchia del dissenso, che diventa così un dissenso depotenziato, un dissenso per così dire sotto tutela.
Solo ad uno effettivamente pari si può parlare da pari: chi, e a quale prezzo, se la sentirebbe di esprimere il proprio dissenso pieno, ancorché sostenuto da ottime ragioni, in faccia a colui o a coloro che possono disporre del suo destino? Gli esempi odierni di dissenso “sotto tutela” si sprecano: partiti dal programma anti-draghiano che perseguono la sua attuazione attraverso il sostegno a Draghi; sindacati che concertano le forme della protesta con istituzioni e parte datoriale invece che con i lavoratori; docenti costretti a usare il Discorso dell’Invalsi e delle competenze per contestare la logica di Invalsi e competenze; scrittori che devono venire a patti con il sistema editoriale pur di denunciare la deriva del sistema editoriale etc. etc.
L’impressione è che non ci sia più spazio alcuno per pronunciare a testa alta e pubblicamente la parola calibene, la parola nuova che rompe con il vecchio e avanza un’ipotesi magari migliorativa per il futuro. Sopravviviamo scontenti dentro lo stagno fermo del Discorso dominante, che ormai glissa sul senso delle parole per concentrarsi sul giudizio ad esse correlato: è il caso del termine populismo, che tutti hanno imparato a disprezzare ma nessuno saprebbe ben definire (una forma di dissenso che si emancipi dalla tutela, un dissenso che verrebbe perciò subito etichettato come provocazione, può consistere nel domandare al conferenziere o all’intervistato di turno cosa significhi esattamente il termine populismo che egli con tanto disgusto associa, solitamente, a chi prova a pronunciare un discorso diverso).
Sappiamo in che modo terribile e drammatico Pierre Rivière abbia alla fine preso la parola che agli esclusi come lui era stata fino ad allora negata, come sia passato alle vie di fatto dell’enunciato radicale. Chiediamoci allora se non provengano anche oggi da queste sacche di dissenso inespresso o silenziato – nonostante tutta la nostra sbandierata libertà di espressione – le esplosioni di “insensata” violenza che affliggono la nostra democraticissima e liberalissima civiltà occidentale, dalle risse di strada tra giovani sazi ma costretti a recitare la parte assegnata in commedia, alle stragi familiari, alle sparatorie – quasi simboliche – nei centri commerciali e nelle scuole del Paese esportatore per eccellenza di libertà e di democrazia. Chiediamoci se non convenga lasciare spazio anche alle voci di chi dal fondo della sala vuole dire calibene, se non convenga ricucire lo strappo sempre più scandaloso tra la libertà e l’uguaglianza sanciti dalla Costituzione e la consuetudine clamorosamente illiberale ed iniqua della nostra vita associata.
(Copertina: fotogramma dal film “Moi, Pierre Rivière…” di René Allio)
Davide Gatto vive, insegna e – quando non può farne a meno – scrive a Francavilla Fontana, nel primo Salento, dove si è trasferito anni fa da Milano. Dopo una maturità scientifica e una laurea in letteratura greca antica sul Plutarco neoplatonico, ha collaborato alla stesura della Enciclopedia della filosofia e delle scienze umane De Agostini Compact (1996) con undici voci della patristica greca e latina. È inoltre autore di due opere narrative, Il male minore (2011) e In principio fu il male (2021). Suoi interventi di taglio prevalentemente sociologico e filosofico sono presenti su Nazione Indiana, Minima&Moralia e altre testate online.





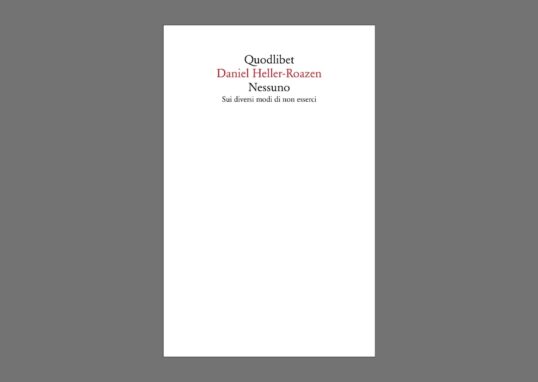

<>: questa affermazione mette in crisi il mio disfattismo ormai rassegnato e incancrenito sul presente. È uno spiraglio che mi invita a riflettere: forse non tutto è perduto, in un mondo in cui tutto intorno crolla e in un giorno in cui la tristissima notizia sul prof .Serianni mi ammutolisce.
“Chiediamoci se non convenga lasciare spazio anche alle voci di chi dal fondo della sala vuole dire calibene”: questa affermazione mette in crisi il mio disfattismo ormai rassegnato e incancrenito sul presente. È uno spiraglio che mi invita a riflettere: forse non tutto è perduto, in un mondo in cui tutto intorno crolla e in un giorno in cui la tristissima notizia sul prof .Serianni mi ammutolisce.