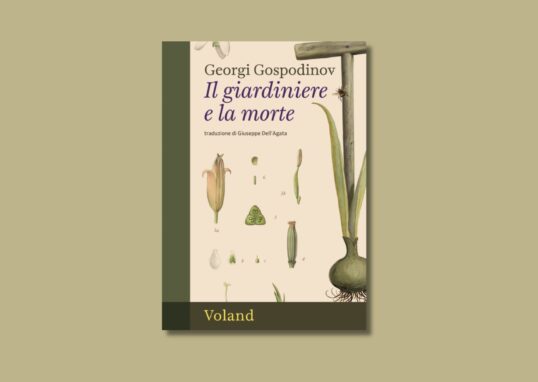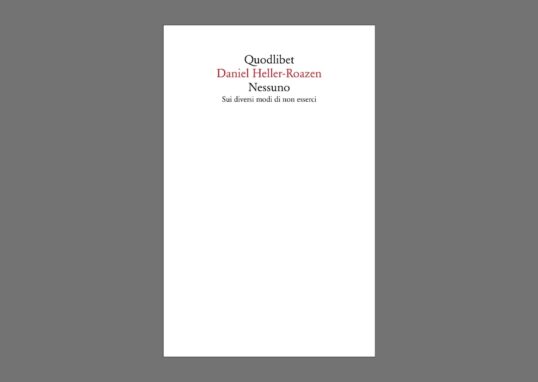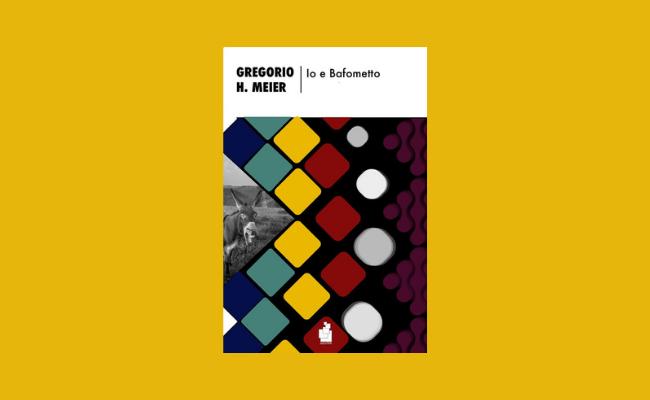
E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare
L’alba dentro l’imbrunire
Battiato – Prospettiva Nevski
Capitolo uno, riga uno.
Beato chi ci capisce!, una dichiarazione poetica che vale per il romanzo di Gregorio H. Meier – di seguito G.H.M. – ma anche per buona parte del catalogo Wojtek. Dopo le avventure con Teorie della comprensione profonda delle cose di A.P. e Timidi messaggi per ragazze cifrate di F. M., solo per citarne alcuni, sapevo che anche Io e Bafometto avrebbe solleticato tutte le mie sinapsi. Avete presente quando vi allenate e improvvisamente scoprire l’esistenza di muscoli che non sapevate di avere? Ci sono parti del corpo che vi fanno male e che fino a mezz’ora prima non pensavate fossero sotto la vostra giurisdizione, ecco. Con questo testo succede la stessa cosa, ma con il cervello e tutte le parti a esso connesse: cuore, vertebre e occhi. Ma potevo immaginarlo, dovevo immaginarlo.
Pollena Trocchia, terrazza con vista sulla croce blu, una notte di luglio.
Dovevo immaginarlo dalla prima volta che ho visto Bafometto, soltanto che non sapevo fosse proprio lui. C’erano delle pizze, qualche birra, vino e addirittura acqua frizzante il tutto servito in lussuosi bicchieri di plastica e c’era quella che, almeno nel dark side del web, viene chiamata Scenicchia napoletana con l’incursione, volontaria e in parte silente, di quella che fu, non so se è ancora in vita, Scenicchia toscana. In tale scenicchia, sullo sfondo, nascosto nella penombra, Bafometto ci osservava. Mi osservava. Ci ho parlato, non mi crederete, mentre A.R.D.V. citava a memoria le Ultime lettere di Jacopo Ortis e A. Z. dimostrava la superiorità del metodo sudamericano nella preparazione del tè al limone. Bafometto che non era ancora Bafometto, ma era già Bafometto, mi ha detto cose che voi potreste trovare nel libro. A proposito, il libro.
Raccontare Io e Bafometto è un’operazione complessa perché, ogni volta che ho tentato di scriverci delle righe, mi è parso di ridurre, comprimere, semplificare eccessivamente. Siamo di fronte a un condensato, sono appena 150 pagine, di filosofia, scienza, poesia, mitologia, etnologia, fiabe per citare l’autore. G.H.M. ha saputo, spetta al lettore valutare se sia un bene o un male, anni di riflessioni, studio e scrittura restituendo un romanzo che non è un romanzo, una raccolta di poesie che non è una raccolta di poesie, una storia che non è una storia. Provo a fornivi un’immagine e spero abbiate sufficiente immaginazione, è essenziale per lasciarsi guidare dalla lingua di Bafometto. Immaginate, dicevo, di entrare in un bar: siete soli, il locale è frequentato dai soliti avventori, che si ritrovano lì tutte le sere e voi siete degli intrusi, non vi conosce nessuno, non conoscete i discorsi che ogni sera si affollano attorno i tavoli, non avete mai visto il barista, non riconoscete nessuno. Ma tutti si conoscono. Provate a immaginare di sedervi accanto a una comitiva piuttosto rumorosa, alticcia il giusto, molto presa dalla propria personale conversazione. Discutono in modo tanto animato che quasi non si accorgono di voi. Non lasciatevi ingannare, quando sembra che vi chiamino, che vi coinvolgano nel chiacchiericcio, in realtà parlano soltanto tra di loro: sono tanti, rumorosi e ognuno racconta la sua storia. Anzi, ognuno inventa. Siete seduti accanto a un gruppo di amici che si racconta storie, frottole, che gareggia per dirne una in più dell’altro, di gente che ne conosce una più del Diavolo e cerca in tutti i modi di primeggiare. E il livello alcolico della tavolata cresce con la narrazione. Più bevono e più sono euforici, più sono euforici e più le storie sono straordinarie. Voi siete lì e non vi resta che goderne. Però è anche vero che quando le birre riempiono il tavolo capita di veder spuntare un velo di tristezza, i racconti si fanno più cupi, le storie drammatiche. L’euforia lascia posto a versi di consapevolezza. E così il Diavolo torna sulla scena a scoperchiare tutte le bugie perché è proprio vero che fa le pentole, ma non i coperchi. Siete riusciti a immaginare la scena? Perfetto, adesso proverò a raccontare di cosa si racconta attorno a questa fantastica tavolata abitata da personaggi piccoli, grandi nelle loro miserie di uomini qualsiasi, scissi tra i loro sogni e la realtà. Che è sempre più stretta dei propri desideri.
Quel che colpisce del libro di G. H. M. è innanzitutto la struttura: un’architettura complessa, e non soltanto per la commistioni di forme, dal racconto, alle poesie, ma la stessa suddivisione del libro lascia sottendere qualcosa. Si ha l’impressione che ci sia qualcosa sotto, l’autore è stato in grado di disseminare numerosi indizi che legano le storie, indizi che spingono verso una circolarità del libro. Ciò che è circolare rotola e se rotola è perché può contare su infiniti assi di simmetria ortogonale e nella lettura ne possiamo trovare almeno tre, ma non escludo che ve ne siano degli altri che non ho trovato. Il primo asse è puramente fisico, visivo, basta sfogliare pagine: 5 capitoli principali, articolati in due gruppi da due, a loro volta correlati da una doppia appendice, e un capitolo centrale che fa appunto da asse. Non solo permette alla storia di proseguire, ma di ribaltarsi, specchiarsi, suggerisce al lettore una visione fatta di continui apposti. Buona parte della filosofia taoista si basa su un concetto tanto semplice quanto profondo: ying e yang non sono due opposti, ma nell’uno si conserva sempre una goccia dell’altro ed è proprio questo che permette il continuo mutare delle cose. Non è una contrapposizione rigida tra bianco e nero, anzi, e in questo G. H. M. sembra averne ripreso la forza motrice. L’altro asse di rotazione sono due personaggi epici, Edipo e Teseo, psiche e corpo, saggezza e irruenza, pensiero e azione: nella tragedia di Sofocle i due archetipi permettono il continuo della storia, la trasmissione della conoscenza, il vecchio saggio che lascia tutto nelle mani del giovane re e così entrambi completano il proprio destino. Nell’impalcatura immaginata da G. H. M. questo ponte è interrotto, il loro incontro è mancato, Edipo si dispera circondato dall’oblio e Teseo è condannato a perdersi ripetutamente nel labirinto. La costruzione del testo non nasconde una certa ossessività, portata all’estremo e in ogni dettaglio: si pensi soltanto all’utilizzo delle lettere α e ω, principio e fine, luce e buio, che enfatizzato la polarizzazione del racconto. Un’ossessione reale, che ci offre un testo coerente nelle sue minime parti, che non è una posa ma sostanza. Il terzo, e almeno per me ultimo asse di rotazione, sono le stagioni: tornano le mattine di inverno, le mattine di agosto, c’è una primavera sempre eterna, una suddivisione del tempo che è impermanente, circolare, rappresentando gli alti e bassi della vita, e delle vite dei personaggi, ancora la realtà e il desiderio, momenti di lucidità e perdizione, di follia e consapevolezza che sono destinati a ritornare. Nonostante i protagonisti siano due, due ombre, in realtà pare che vi siano al contrario due Soli alti nel cielo e le due ombre appartengano in realtà alla stessa persona. Forse a Bafometto stesso perché come notava A.P. Bafometto sono io, Bafometto siamo tutti.
In questo calderone, nel quale grandi figure si mescolano a miseri umani, a vicende di disperazione quotidiana, sbronze che si confondono con le riflessioni sui massimi sistemi, traspare un velo di continua burla. G. H. M. gira i piani, crea una linea temporale che si può leggere partendo da uno qualsiasi dei due estremi lasciandoci nell’incertezza ripetuta. Ma non è uno straniamento inquietante, al contrario apre una crepa, prima sottile poi via via più larga fino a diventare voragine, nella tragicomicità dell’esistenza. Ho riconosciuto l’odore di quello che Freud chiama spirito, nell’accezione di ironia, e che secondo l’austriaco era una delle componenti essenziali del sogno. Quelli di G. H. M. sono infatti sogni, o incubi, che si rincorrono e ironizzano l’uno sull’altro, che sdrammatizzano i grandi temi della vita- chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo, un fiorino – e riportano tutto a una dimensione più umana, più piccola, contenuta. La stessa ironia che è affidata alla parte poetica del testo che, mentre la prosa tende all’ideale, spinge costantemente verso il basso. Ribalta la sua concezione di pratica divina, o divinatoria, non cercando il contatto con il cielo, ma con la terra. I piedi ben saldi al terreno. Il gioco del rituale che rimanda alle splendide riflessioni di B. C. Y. nel volume La scomparsa dei riti: una società che dimentica la propria mortalità, che dimentica di giocare, che prende le cose troppo seriamente e si allontana dalla propria dimensione, inseguendo desideri irrealizzabili. La via di fuga, in questo labirinto giocoso, è accettare chi siamo, il vedersi finalmente come non necessari. Questa è l’unica chiave che ci permette di uscire, una liberazione che l’autore suggerisce ma non sentenzia, perché non vi è mai il tono declamatorio di chi conosce la verità, al contrario è una messa in discussione perenne. Il filosofo indica di non essere filosofi. L’abracadabra di uno stregone che non si prende più sul serio.
Di elementi allusivi il testo è pieno: c’è il carillon che si rompe, l’ingranaggio infantile che smette di funzionare, che forse simbolizza il cervello stesso del personaggio che si riconosce pazzo e poi dimentica se stesso; la crapula e il ritorno dell’eguale, che a chi ha praticità con le riviste letterarie dovrebbe ricordare qualcosa o qualcuno, A. Z. per esempio; le brevi storie, gli incisi simil storiografici, i saggi da interpretare che rimandano ancora alla Teoria di A. P.; paesi irreali che portano nomi di cibo, personaggi identificati attraverso acconciature o ancora una volta pietanze, a ricordare una realtà meno alta di quanto sembri; Kafka che si affaccia nella storia di Cupido, che non è il Dio dell’Amore, ma un piccolo topolino, l’unico personaggio che dopo aver subito varie metamorfosi ed essersi ritrovato al centro di un processo assurdo e asfissiante, forse è l’unico personaggio che troverà la soluzione al gioco perché lo riconosce come tale; c’è la disperazione ironica di Piero Ciampi in alcuni passaggi tremendamente vivi e sentiti, dove la poetica sposa una visione terrestre, contingente, povera della realtà; ci sono le maschere, gli Arlecchini, che altro non sono se non Diavoli sotto altre forme, sotto altro nome; e c’è la Civetta, simbolo di saggezza, che riporta ancora al mondo greco, alla mitologia, nella stessa chiave in cui si può interpretare l’ultimo racconto, un simil Ulisse che si abbandona ai piaceri di Circe – o che compie uno stupro di gruppo senza la consapevolezza dello stupro stesso. Perché la sorpresa più grande di Io e Bafometto è la sempre possibile doppia chiave di lettura di ciò che si trova sulla pagina: un’interpretazione simbolica oppure una più concreta, reale, quindi più tragica, sulla quale interrogarsi non per un piacere teorico ma con una valenza fortemente pratica. Come accade con le poesie, che sono forse l’ossatura stessa del testo, il calco dell’impalcatura che l’autore ha creato, e grazie alle quali si sfonda continuamente il muro della finzione tornando nel reale, tra crack e pub dove la vita è più misera, ma forse più semplice.
Ma di chi parla G. H. M., a chi appartiene la voce e a chi sta raccontando? Sono tutti, siamo tutti. L’io è anche l’altro, l’altro è anche l’io, si può leggere nel Zhuang-zi e sembra quasi, ma non sono io risponde l’autore. Un testo da crittografare alla maniera di F. M. Una lettura così tremendamente reale e nello stesso tempo impossibile. Una scrittura di grande intelligenza che non ti fa sentire stupido, al più stimola il porsi delle domande alle quali non è importante trovare una risposta, quanto fermarsi semplicemente a riflettere. Alla Socrate, so di non sapere. Alla Zhuang-zi, chi non sa parla, chi sa non parla. E Bafometto sa e proprio per questo racconta, racconta e basta. Che il lettore legga, entri al pub, prenda posto alla tavolata, beva una birra e torni a casa ubriaco lercio, se vuole, leggermente alticcio, se preferisce, oppure sobrio, sobrissimo, se è così che gli aggrada.
Francesco Spiedo (1992) nasce a Napoli, da madre ansiosa e padre operaio, sperimentando fin da subito le conseguenze dell’iperattività. Cresciuto a San Giorgio a Cremano, studia per diventare ingegnere anche se non praticherà mai. Precedentemente animatore, cameriere, concierge, addetto alla sicurezza e ad altre attività non riconosciute dal Ministero del Lavoro, inizia a scrivere su commissione e su riviste, sotto falso nome e come ghostwriter. Stiamo abbastanza bene (Fandango Libri, 2020) è il suo primo romanzo. Crede in Maradona e Woody Allen.