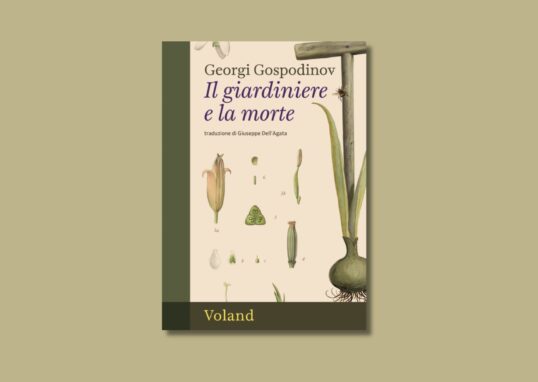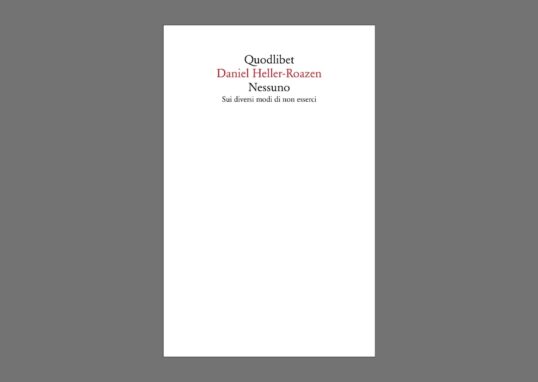Di tanto in tanto un grido copriva le distanze
e l’aria delle cose diventava irreale.
Summer on a solitary beach – F. Battiato
Tratto da una storia vera sono le cinque parole dell’orrore, il mio incubo più grande. Il rischio si nasconde nella fascinazione dell’evento, della storia che cattura l’attenzione, nella ripetizione banale dei fatti, in un pappagallo che tramortito dalle potenzialità si dimentica di trasformare la vicenda in storia. Come un diario delle elementari custodisce le confessioni della preadolescenza o come un pezzo di cronaca racconta un delitto, un romanzo non può ridursi a questo. Scrivere è un’altra cosa: un piano di realtà che allude, presuppone o lascia immaginare, un’altra realtà. Poi c’è lo stile. La tecnica. La capacità di cucire un intreccio. I riferimenti interni. La ricerca di una voce. Quando leggo Tratto da una storia vera vado in panico e sono stato più che felice di scoprire in Valentina Mira una scrittrice come si deve. X è un romanzo, strano, ibrido e coraggioso, ma pur sempre un romanzo: che sia una storia vera, potenzialmente vera, principalmente vera, presumibilmente vera, l’ho dimenticato per ricordarmene soltanto quando i ringraziamenti a fine libro hanno sollevato il velo dell’irrealtà. Perché V. mette lo stupro nelle prime righe, poi lascia andare e quella parola torna venti pagine più avanti, quasi dimenticata, spunta in un’adolescenza qualunque, in una vita qualunque. Vera, falsa, reale? Che appartiene a V., alla stessa V. che scrive o a un’altra che porta solo il suo nome? Non lo so e, a dirla tutta, neanche mi interessa.
Per citare un autore che di autofiction se ne intende, W. S. scrive che il realismo si esercita soprattutto nel ribaltare le convenzioni culturali. In questa visione X può essere considerato un romanzo estremamente realistico. La capacità di Valentina di delimitare i primi anni duemila, e poi gli anni dieci, ha la stessa intensità di una fotografia leggermente distorta: caso vuole che tra le nostre date di nascita passino meno di 12 mesi e che nelle pagine di X abbia potuto riconoscere la mia infanzia, la mia adolescenza, il mio apprendistato al mondo, lasciandomi la costante sensazione di un’incrinatura del reale. Il doppio strato c’era senza vedersi, si percepiva, e non si può ridurre questa impressione a una semplice questione di prospettiva: sono uomo, V. è donna, troppo facile. Non è questo. Non è neanche il tabù al centro della storia, lo stupro, a creare questo effetto disturbante e affascinante. È qualcos’altro ed è per questo che X è un romanzo romanzo e V. una scrittrice scrittrice. Dentro queste pagine c’è tutto ciò che ho già vissuto eppure c’è un’altra cosa, è la mia realtà e un’altra realtà, è la mia vita che diventa un’altra vita. V. ci racconta il disequilibrio familiare che è una forma di equilibrio necessaria, di un fascismo vero che si torna a respirare tra i ragazzi, di una promiscuità lavorativa che trasforma i capi in predatori sessuali, che educa al compromesso, che espone al crollo emotivo, che ci spinge a sacrificare ideali e principi pur di resistere. Altro che resilienza, questa è una forma di resistenza nel tempo in cui ci è dato di vivere.
Mi perdonerà il lettore se ancora una volta preferisco glissare sulla trama, su ciò che avviene nel romanzo, potreste leggerne ovunque, e in modo certamente più approfondito e preciso. Però una cosa voglio dirla: X non parla solo di stupro, ma tutto un mondo nel quale molti di noi siamo diventati adulti. Le regole, le convenzioni, i tabù che senza rendercene conto ci siamo portati dentro. E ci portiamo dentro. Sfrutta un escamotage letterario ben riuscito per tenere insieme la narrazione, per gestire le continue analessi e prolessi, i salti avanti e indietro nel tempo: le lettere. I romanzi epistolari, qualcuno sostiene, non vendono più, perché sono fuori epoca come fuori epoca sono le lettere. E invece, proprio perché scritte a un fratello che non c’è, che appartiene al passato, al tempo in cui scriversi lettere, infilare bigliettini nello zaino, inventare dediche sul diario era pane quotidiano, quelle pagine diventano piccoli momenti solenni. Colpi di pistola, quando c’è da sparare. Colpi di fioretto, quando c’è da infilzare. Colpi di labbra, quando c’è da baciare. L’idea di intervallare la narrazione con queste lettere è una trovata a dir poco romantica, riequilibrando e dando concretezza a quanto la protagonista dice di sé nelle altre pagine. Le lettere permettono di vedere una realtà che non esiste più. Di mettere ordine a una verità complessa. V. non si tira indietro di fronte a una complessità che spaventerebbe chiunque, figuriamoci chi scrive e sente l’esigenza di mettere ordine. Di trovare l’incognita, la X, a un’equazione che sembra irrisolvibile. Famiglia, lavoro, società, ruoli, realizzazione di sé, casa, affitto, tradimento, bugie, bellezza sono soltanto alcuni dei parametri che compongono X. Tutto è immagine, in un gioco proustiano di ricordi, e le madelaine sono Goku SuperSayan, i Kinder Pinguì, i rollerblade, il Crystall Ball. Sono visioni che si sovrappongono, pietre mistiche con le quali rievocare il passato, ma anche sdrammatizzare, fulminare la realtà. Questa leggerezza, combinata alla costruzione spesso in negazione delle frasi, sono una perfetta sintomatologia linguistica dello stato d’animo della protagonista, di una vittima che cerca di schermirsi. Quello che accade nelle pagine è impossibile come nei romanzi e non c’è bisogno di esagerare con l’orrore per ottenere narrazione. La trasfigurazione delle cose che diventano immagini altre: spostarsi sempre con una metafora o similitudine, far parlare gli oggetti al posto della protagonista, mi ha ricordato molto i racconti di F. M. Le autrici sono quasi coetanee, l’immaginario non soltanto è quello, ma anche l’uso degli elementi narrativi si somiglia molto. V. ha elevato all’ennesima potenza il gioco di rimandi tra il mondo che era e il mondo che c’è.
Il matematichese degli ultimi paragrafi non è scelto a caso. Fin dalla prima pagina si respira un tentativo di chiarezza, una ricerca della risposta più logica a quanto accaduto, il tentativo di V. di trovare la quadra di una verità complessa. Ho scoperto che l’alternativa a Giurisprudenza c’era, e per l’autrice era proprio Matematica. V. ha scelto X perché è la croce sulla mappa di un tesoro introvabile, ma anche e soprattutto l’incognita per eccellenza. V. non conosce la verità, deve desumerla, proprio come un matematico, e intuirla laddove manca qualsiasi riferimento, trovare nuovi appigli, nuove logiche, anche a rischio di sbagliare. Quando bisogna confermare una teoria si usa la deduzione perché dal generale si scende al particolare, tutto si giustifica grazie a se stesso, tra assiomi e teoremi. Si deduce quando si ha tutto da perdere, ma quando dal particolare si vuole giungere al generale, bisogna lavorare di induzione, così simile all’intuizione, per presumere qualcosa che prima non esiste e un attimo dopo c’è. V. ha bisogno della verità, di rompere il meccanismo che ti trasforma in vittima, e anche attraverso la penna riesce ad allentare lo schema e proporre una sua teoria. Deve azzardare.
L’effetto è quello di immergersi dentro una lavagna fitta di appunti, in una nuvola di gesso bianco, sommerso dalle possibili varianti e alla ricerca di un’unica verità. L’eccezionalità di V. è quella di non aver rincorso a occhi chiusi questa verità, cosa che spesso accade a chi scrive, ma anche a chi sente un bisogno che non permette di fare altro. È rimasta lucida davanti al problema, proprio come una matematica, e ha ammesso candidamente che di verità ce ne sono molte, diverse, in una sorta di relativismo einsteiniano. E la sovrabbondanza di elementi non rende le cose più difficili, semmai il contrario. In questo è ancora la logica ad aiutarci con quelle che vengono comunemente dette tavole della verità, utilissime per affermare se frasi complesse siano o meno vere.
Ogni frase complessa, per definizione, è composta da frasi semplici e ognuna di queste frasi può essere a sua volta vera o falsa. Tra queste frasi semplici ci sono dei connettivi logici, i più usati sono e, o e non, che permettono di instaurare un legame logico tra le parti e aiutarci a determinare la verità, o falsità, della frase complessa di partenza. Tante più sono le frasi semplici, tante più variabili della realtà si possono osservare, tanto più è possibile risolvere la frase complessa e sapere se è vera o è falsa. Semplificare non sempre significa rendere la vita più lineare, perché a furia di togliere si finisce per precipitare nella tautologia dove A è uguale ad A, come ricorda V. a pagina 109. La logica ha bisogno di A, B, C, D etc. e così la realtà. Altrimenti ci restano soltanto tabù, tautologie, contraddizioni ed esclusioni.
Un processo che, se applicato con lucidità, permette di fare chiarezza anche laddove coesistono verità opposte, contraddittorie, che però confrontate, valutate, possono portare con presumibile ragionevolezza in una direzione o in un’altra. Accanto alle tautologie o alle contraddizioni, esiste un ventaglio di verità complesse che diventano più facilmente risolvibili tanto maggiore è il numero di frasi semplici che le compongono. Vanno a imporre condizioni e a cascata influenzano il ragionamento. In questo senso la ricerca di una quadra all’interno di situazioni complesse diventa essenziale. L’incognita cerca un suo posto. La realtà è un quadro complesso, farne parte spinge ad assumersene delle responsabilità. X è l’incognita di una verità complessa: quella dei genitori che non capiscono o non vogliono capire, quella di un fratello che non ti crede o non ti vuole credere, quella di uno Stato che non ti difende o non ti vuole difendere, quella di te stessa che non riesci a perdonarti o non vuoi perdonarti. Di chi si sente colpevole anche quando è vittima.
X è una nuova consonante muta, ma più che K. di Kafka ricorda la Trilogia della Città di K, di quell’adolescenza interrotta, raccontata con un linguaggio quasi onirico, dissacrante anche quando la realtà si fa cruda, autoironico forse per difesa, ma che si mantiene credibile.
La prima volta in cui ho mai letto di stupro è stato in Un bravo ragazzo di Gutiérrez. Di punti in comune con la storia di V. ce ne sono tanti: la normalità del gesto, lontani dal clamore suscitato dalla violenza, dal sangue, da quegli elementi scenici che, sommati alla morte della vittima che in quanto deceduta riesce a sottrarsi alla trasformazione in colpevole, o quanto meno complice, dello stupro, rendono la vicenda mediaticamente non interessante. Quello stupro che lontano dai telegiornali è noia. Che non è un reato. Che è spesso incapacità di capire l’altro, di immedesimarsi, di uscire dal paradigma del gioco, dello scherzo, della bravata. Che tratta con leggerezza ciò che per un altro o un’altra non è assolutamente un dettaglio.
Gli esseri umani per comunicare hanno bisogno di un linguaggio condiviso, non necessariamente verbale. Diversi orizzonti socioculturali generano una reale incomprensione, creano mondi diversi che non si capiscono ma che continuano, per forza di cose, a toccarsi finché il più fragile dei due si rompe. Questa incomunicabilità e incomprensione non sono una scusante, anzi. Sempre restando in ambito matematico, per meglio dire ingegneristico, laddove è nota una difficoltà si impone una doppia precauzione: quando non so, quando so di non avere gli strumenti per prevedere con certezza, allora devono procedere più lentamente, non più velocemente. Se sono al buio e non vedo procedo a piccoli passi, con le mani ben tese davanti, così forse eviterò di schiantarmi nel muro. Invece sembra che molti decidano di correre allegramente verso il buio, consapevoli forse di essere loro stessi il muro, il mondo più duro, che difficilmente si romperà. Almeno in apparenza. E attenzione, non stiamo parlando soltanto di stupro. Parliamo di tutto, parliamo di noi.
Harari scrive nel suo 21 lezioni per il XXI secolo che l’uomo dovrà affrontare due prove: una ecologica e una scientifica, strettamente legate e dalle cui risposte dipenderà il futuro del mondo. Vero, verissimo. Ma l’uomo non deve dimenticare che ogni giorno risponde di una sfida etica non trascurabile. Se far finta che il problema non esiste è un atteggiamento del singolo persino comprensibile, la società dovrebbe rispondere ad altre leggi. Dovrebbe porre rimedio alle carenze dell’individuo. In questo il diritto, la Giurisprudenza tanto cara a V., trova il suo senso. Ma se la società gioca a fare lo struzzo? Ben vengano romanzi come questo capaci di metterci di fronte alla realtà delle cose. A sottolineare, come scrive ancora W. Siti, che le verità del mondo vengono fuori controvoglia. Sempre Harari dice che l’uomo preferisce pensare in termini di storie, non di fatti, numeri, equazioni, e tanto più e semplice la storia meglio è. X ha sfruttato la lucidità dei fatti, la precisione dei numeri, la limpidezza delle equazioni per arrivare al punto. Una componente importante della narrazione è il punto di vista, nel cercare di inglobare più verità assieme, stridenti, contraddittorie, faticando il triplo mentre solitamente ci si accontenta delle proprie verità e tanti saluti. Entrare e uscire, ripescare nel passato, negli oggetti, nelle abitudini, salti avanti e salti indietro nel tempo per consegnarci non un fatto ma una storia.
Mi chiamo Valentina Mira, come tutte per parafrasare il già citato W. Siti, è l’incipit mancante, che non c’è ma poteva esserci. V. ci coglie impreparati davanti alla realtà e, alle volte, è capace addirittura di cogliere impreparata la realtà stessa. Come la donna in copertina, X è la Medusa sopravvissuta e pronta a pietrificarti. Questa è la mia storia raccontata male, no. Questa è la tua storia raccontata bene, benissimo.
Francesco Spiedo (1992) nasce a Napoli, da madre ansiosa e padre operaio, sperimentando fin da subito le conseguenze dell’iperattività. Cresciuto a San Giorgio a Cremano, studia per diventare ingegnere anche se non praticherà mai. Precedentemente animatore, cameriere, concierge, addetto alla sicurezza e ad altre attività non riconosciute dal Ministero del Lavoro, inizia a scrivere su commissione e su riviste, sotto falso nome e come ghostwriter. Stiamo abbastanza bene (Fandango Libri, 2020) è il suo primo romanzo. Crede in Maradona e Woody Allen.