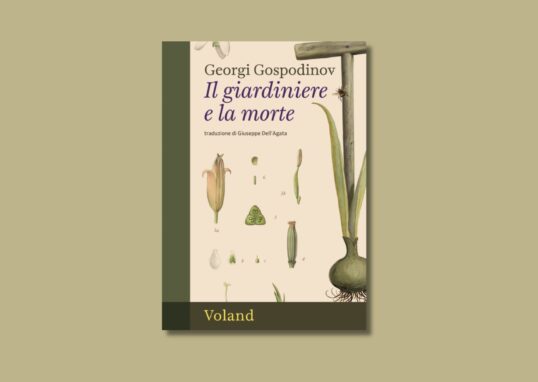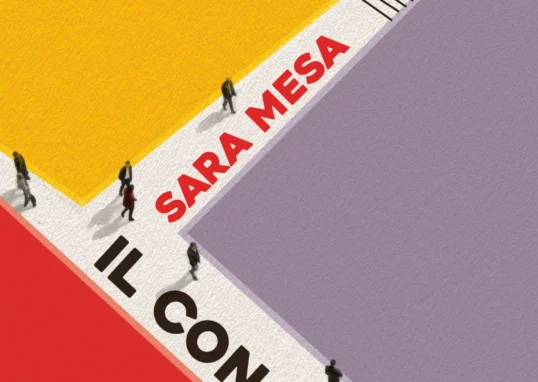di Filippo Polenchi
È un continente tattile, invisibile, in transito: la geografia umorale della foresta amazzonica di Latitudine 0° – esordio, per i tipi di 66thand2nd, dello scrittore e traduttore dal francese Marco Lapenna – si sposta di continuo, ma ha vie d’accesso in un certo senso sempre disponibili. Come il viaggiatore dantesco, il cui sonnambulismo peccatorio, un peccato vagante, magnetico, lo lascia smarrire in una ormai proverbiale selva, anche colui che s’addentra nel «matorral» scoprirà che la foresta «[…] non ha limiti, ma confina con il mondo di fuori. E lungo questi confini ci sono delle vie di accesso».
Confini mobili, si diceva. Eppure, questa opacità, questo barbaglio vulcanico che sobbolle sulla terra secca, abrasa di un Messico che pertiene sia all’Herzog di Fitzcarraldo che al Lowry di Sotto il vulcano, l’allucinazione delirante di Carvajal, concretamente aggrappato alla dipendenza (a rischio che la metafora sia troppo parlante) di Nina, eternamente fuggente, è anche l’estrema trasparenza del romanzo.
La foresta-continente, con la sua complessa tassonomia creaturale – nativi, «porci», «percorritori», cioè cacciatori o prede e poi la fantastica apparizione tarkovskijana dei demoni, avatar guerrieri, che precedono, seguono, illuminano, danno corpo material/immateriale ai desideri dei personaggi (ma forse sarebbe meglio parlare di “godimento”) – questo terzo paesaggio prodigioso, come il terzo paesaggio canonizzato da Clément (Gilles Clément, Manifesto del Terzo Paesaggio, trad. it. Giuseppe Lucchesini, Macerata, Quodlibet, 2005.), è proprio visibile e trascurato al tempo stesso.
La foresta esiste ed entrarvi – entrare nella bolgia decoloniale, nelle lotte tra un Columbus (rovesciamento del segno) e un egemone – è anche molto semplice. Le vie che conducono alla dipendenza dai propri desideri, alla sofferenza quasi di matrice buddista che questi producono, nelle forme incarnate dei demoni platonici e post-platonici, sono quasi eccessivamente prodighe di aperture. Per essere un mondo fantastico, dunque, è fin troppo disponibile all’esplorazione. È un mondo che circonda il nostro mondo come un albume. Non sarà, allora, che questo cosmo fantastico, questo Altro è, in realtà, quel corpo vitreo che cade nell’angolo trascurato del nostro campo visivo? Non sarà, cioè, che Latitudine 0°, dentro un solido impianto di romanzo di avventura e guerra, alla Nostromo di Conrad, celi una dialettica puramente culturale, una sorta di studio sui materiali di una metafisica cannibalistica? Lapenna affonda la spada nell’ormai standard dicotomia antropologica Natura/Cultura, allo stesso modo di uno studioso radicale come Edoardo Viveiros de Castro (si cita volutamente il bel saggio di Eduardo Viveiros de Castro, Metafisiche cannibali. Elementi di antropologia post-strutturale, trad. it. Mario Galzigna e Laura Liberale, Verona, Ombre corte, 2017.), vale a dire per smembrarla: l’Altro, in Lapenna, si mostra per lampi improvvisi, per nascondimenti fenomenologici; l’Altro rimane pur sempre un problema del soggetto, del nostro Carvajal, che come il Marlow di Conrad (o come il vero Carvajal: attribuzioni consentite dallo stesso autore) deve anzitutto riabilitare una posizione di vista molteplice, atrofizzata dal comodo dualismo dominante. Scrive Viveiros de Castro: «L’etnografia dell’America indigena è popolata da questi riferimenti a una teoria cosmopolitica che descrive un universo abitato da diversi tipi di attanti o di agenti soggettivi, umani e non – dei, animali, morti, piante, fenomeni metereologici, e spesso anche oggetti e artefatti – muniti di uno stesso insieme di disposizioni percettive, appetitive e cognitive, detto altrimenti, di un’”anima” simile». Allo stesso modo Lapenna non teme la triturazione di materiali e feticci – quasi relitti direi – culturali: non è un caso che il demone di Carvajal abbia l’aspetto di David Bowie.
Relitti/ricordi: gli artefatti culturali (non solo il dàimon, ma anche la «Montagna sacra» [Jodorowski], il Deserto rosso [Antonioni], l’ansia memoriale dei replicanti di Philip K. Dick) sono, per contrasto, tester di una afasia immaginativa. Non si riesce più a immaginare perché le prospettive sono schiacciate sull’animale umano, trascurando tutti quegli animali non-umani che da John Berger a Nancy, fino appunto, a Viveiros de Castro, sappiamo essere portatori di sguardo. Uno sguardo corporeizzato. L’addestramento al corpo, ch’è addestramento al riconoscere il demone e tutto quello che comporta – il «pasto di sangue», la terribile possibilità del «costringimento», la fame immedicabile, la nutrizione vampiresca – non cancella, tuttavia, una preminenza della vista (ma Laura Pugno, in quel bel saggio uscito che è In territorio selvaggio (Milano, Nottetempo, 2018), avvertiva: «Il corpo è la mente. La mente è il corpo. Invecchiano»). Corpo e vista/mente, corpo e occhio sono la stessa cosa, eppure la cerniera s’inceppa: la simbiosi fallisce. La foresta è ovunque, ma non la si vede: eppure l’attrazione magnetica è così potente.
Scrive Donna Haraway, nella sua fabula speculativa sui «bambini del compost» (e cita apertamente il Philip Pullman della Bussola d’oro): «I compostisti capivano quei demoni in modi ontologicamente più purificati, più legati ad animismi situati in mondi diversificati, moderni e tradizionali, passati e presenti. I legami tra l’umano e il demone erano molto simili alle connessioni simbiogeniche tra i bambini nelle comunità compostiste» (Donna Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, trad. it. Claudia Durastanti e Clara Ciccioni, Roma, Nero Edizioni, 2019).
Il «con-vivere» sembra allora impossibile, a leggere le pagine della foresta: dominare ed essere dominati, la necrosi oftalmica per immaginare un vero Altro (quindi forse un Altro che ha slogato la propria catena articolatoria della sterilità desiderante – «nella foresta non c’è posto per la libido»; «il sesso si riduceva a una forma di onanismo del demone»): sono questi gli unici codici. Siamo senza via di scampo? Ma noi leggiamo ancora Viveiros de Castro, che cita il cosiddetto «incidente delle Antille» raccontato da Lévy-Strauss:
«Nelle grandi Antille, pochi anni dopo la scoperta dell’America, mentre gli spagnoli spedivano commissioni di inchiesta per stabilire se gli indigeni fossero o no dotati di un’anima, questi ultimi si occupavano di immergere i prigionieri bianchi sott’acqua per verificare, con una sorveglianza prolungata, se il loro cadavere fosse o meno soggetto a putrefazione».
La chiosa dell’antropologo brasiliano sembra un riassunto della malta simbolica che sorregge, quasi miracolosamente nel suo tentativo sincretico e d’invenzione, l’esordio di Marco Lapenna:
«Il fatto di favorire la propria umanità a detrimento dell’umanità dell’altro, mostra una somiglianza fondamentale con questo altro che viene disprezzato: poiché l’altro del Medesimo (dell’Europeo) si mostra uguale all’altro dell’Altro (dell’indigeno), il Medesimo finisce per mostrarsi, a sua insaputa, uguale all’Altro». Chi s’addentra nella foresta vivente di Latitudine 0° cercando l’alterità forse dovrà correggere il tiro: quello che troverà non è l’altro-da-sé, ma è l’altro-di-sé: la sua amigdala cerebro-stellare, la memoria del cosmo nei rottami culturali di una mente presente che collassa.
Il riassemblaggio – che è poi una pratica ecologica della narrativa di Lapenna – dei cartoni culturali e storici tenta davvero di fuoriuscire dalla dannazione seriale di una vita senza vocazione, guidata dal cieco impulso del godimento dei demoni. Ecco perché Carvajal e Nina divengono così importanti, nella contesa del Potere: perché è convinzione che da essi possano ri-generarsi i ricordi. Merce rara, nella foresta, ma prezioso elisir: con i ricordi la psiche mutata dalle proliferazioni vegetali, dalle bio-architetture che costituiscono le strutture (in)visibili della Fortezza, aprirà forse a un nuovo spazio mentale, dove le sedimentazioni geologiche condurranno a una «“posterità” quasi-freudiana, o meglio, una continuità a venire tra il presente moderno e il “passato” non moderno – una continuità mitologica o, in altri termini, cosmopolitica» (Déborah Danowski, Eduardo Viveiros de Castro, Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine, trad. it., Alessandro Lucera e Alessandro Palmier, Milano, Nottetempo, 2017) . «E chissà che un giorno le grandi dorsali non si sollevino come rettili e tornino a camminare la terra, perché sono insondabili anche i desideri di Columbus».
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente