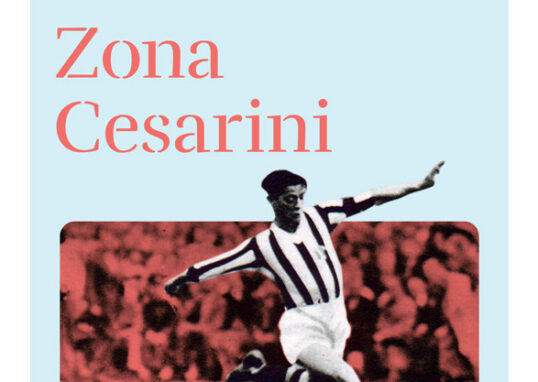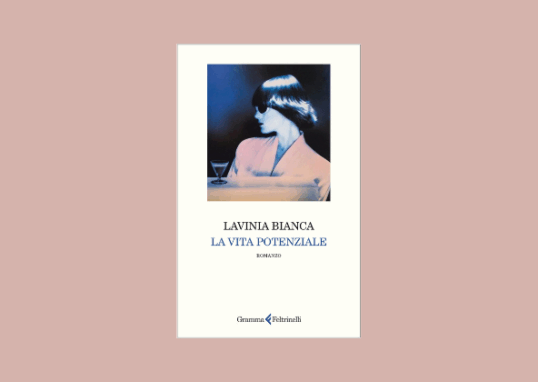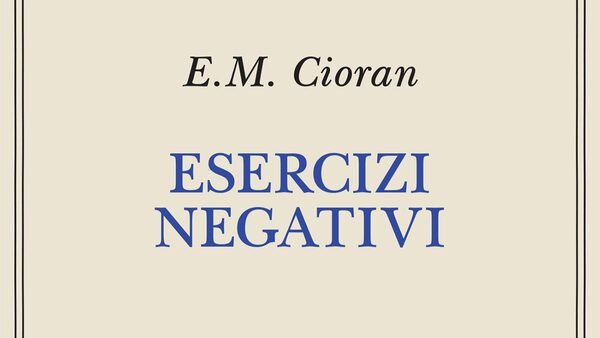
di Ludovico Cantisani
“Da quel giorno abito un fondale di paura
Guardo il mondo senza gli occhi che vorrei
Perché che conosco bene gli uomini
Racconto i loro demoni
Ma non riesco a vivere coi miei”
Francesco Bianconi, L’abisso
“Vi fu un tempo in cui mi sembrava di vedere, eretta all’interno di ogni casa, una forca alla quale era appeso un cadavere. Percorrevo in lungo e in largo le strade ossessionato da innumerevoli esecuzioni; e, mentre gli istanti si dispiegavano come bare aperte, mi dilettavo a sopravvivere a un’impiccagione universale. Vi fu un altro tempo in cui, da ogni passante, – mi aspettavo una coltellata piantata nella carne. Quante volte ho dovuto rinascere dopo la prova ideale della pugnalata!… Ma, al di sopra di questi terrori, ne troneggiava un altro; volendo liberarmene, interrogavo i filosofi, i poeti: al termine dei loro ragionamenti e dei loro versi non c’erano risposte. Ed è così che un giorno corsi verso il poliziotto all’angolo: ‘Signor agente, saprebbe dirmi se questo mondo esiste, se io esisto?’”. È fin troppo facile intuire a chi si può attribuire questo brano di pessimismo sardonesco: viene dalla penna di Emil M. Cioran, uno dei filosofi più cupi e controversi del secolo breve, nato a Rășinari in Romania nel 1911 e morto a Parigi nel 1995.
Cioran esordisce come filosofo in rumeno verso la metà degli anni trenta, pubblicando opere come Al culmine della disperazione, Lacrime e santi e Il crepuscolo dei pensieri; trasferitosi in Francia nel 1937 grazie a una borsa di studio dell’istituto francese di Bucarest, dopo la seconda guerra mondiale riuscì a entrare nelle grazie di Gallimard e a pubblicare per la prestigiosa casa editrice nel 1949 il Sommario di decomposizione, scrivendo per la prima volta nel suo percorso direttamente in francese, dopo la dolorosa e problematica decisione di distaccarsi dalla lingua materna. Nemico giurato di ogni accademismo non meno che delle mode esistenzialeggianti à la Sartre, sbeffeggiatore del Maggio francese, spesso criticato riesumando la sua adesione giovanile alla Guardia di ferro e al fascismo rumeno, Cioran continuò imperterrito a scrivere libri sempre più frammentati e aforistici, classici del pensiero negativo come i Sillogismi dell’amanrezza, La tentazione di esistere, La caduta nel tempo, Il funesto demiurgo e L’inconveniente di essere nati. Sempre più disgustato dalla stessa attività di scrivere, Cioran diradò le pubblicazioni nel corso degli anni ottanta, per poi manifestare sintomi sempre più gravi di Alzheimer che lo portarono alla morte a metà degli anni novanta.
Se già nel 1997 a cura della compagnia Simone Boué erano stati pubblicati i Quaderni che radunavano scritti inediti risalenti al quindicennio tra il 1957 e il 1972, negli ultimi anni sono emersi due importanti inediti cioraniani: La finestra sul nulla, tratto da un manoscritto in rumeno conservato nel fondo Cioran della biblioteca Jacques Doucet di Parigi, ed Esercizi negativi. In margine a Sommario di decomposizione, che raccoglie gli appunti scartati durante la stesura del suo esordio in lingua francese. In Italia l’editore di Cioran è da più di quattro decenni l’Adelphi, grazie a un forte rapporto strettosi tra il pensatore rumeno e Roberto Calasso, e, vent’anni dopo l’edizione originale francese curata da Ingrid Astier, grazie all’Adelphi arrivano adesso in Italia gli Esercizi negativi, per la traduzione di Cristina Fantechi.
Emil Cioran viveva già in Francia da una decina d’anni quando, accortosi dell’impossibilità di tradurre in rumeno il Renouveau di Mallarmé, nell’estate del 1947, prese la decisione drastica di abbandonare la sua lingua madre e di iniziare a scrivere in francese. “Alla Crise du vers mallarmeana, egli reagisce con una crisi di lingua”, commenta Ingrid Astier, curatrice del volume. Il ripudio del rumeno da parte di Cioran, che riecheggia il parallelo transitus di Samuel Beckett dall’inglese al francese, nasce da un insieme di esigenze: un parziale rigetto delle proprie origini, un esercizio di espiazione e disciplina, costringendosi a scrivere in una lingua più fredda e razionale, una ricerca di maggiore impersonalità, la scelta dell’esilio linguistico come destino. Nel tentativo di impadronirsi della lingua francese, Cioran riscrisse quattro volte il Sommario di decomposizione, con l’aiuto di un amico basco noto per essere un purista inflessibile della lingua e della grammatica francesi. Esercizi negativi nasce da questo tavolo di lavoro e, pur essendo composto da “materiali di scarto” e formulazioni alternative dei passi della sua prima opera in francese, il libro si impone subito come un passaggio importante nella riflessione cioraniana, denotato anche da accenti più personali e formulazioni più tranchant sulla scena intellettuale a lui contemporanea rispetto ai testi di quel periodo pubblicati in vita.
Sin dall’apertura Esercizi negativi ci mostra uno Cioran critico della cultura e autocritico: “avevo diciassette anni e credevo nella filosofia. Ci credevo con l’ardore del parvenu e di chi non si sente al passo con la cultura, con quella sete di istruzione tipica dei giovani dell’Europa Centrale, desiderosi di impossessarsi di tutte le idee, di leggere tutti i libri, e di riscattare, avidi di sapere, il proprio passato vergine, ignorante e umile. Avendo deciso di conoscere tutto, dovevo divorare indiscriminatamente tutto quanto era stato pensato e concepito; e la prima cosa che affronta il barbaro è l’astrazione perché è quella che più lo abbaglia”. Sono tante le frasi memorabili contenute nel libro, alcune poi riprese o riecheggiate in Sommario della decomposizione, altre no. “Abbiamo un’anima per perderla”- “un pessimista che non adori segretamente la vita è un cadavere” – “date uno scopo preciso alla vita ed essa perderà all’istante il suo terribile fascino”; l’uomo ormai diventato “l’autunno della Creazione”, il destino liquidato a “un ritornello che guizza intorno a qualche macchia di sangue”, la storia è un “indecente miscuglio di banalità e apocalisse”, la delusione porta con sé un “fardello di luce”, la società che “non è un male, è un disastro” – sono tanti i passaggi degli Esercizi negativi che possono essere annoverati tra il meglio di Cioran.
In questi appunti pubblicati postumi assistiamo anche alla nascita del titolo del suo esordio in francese: “è curioso che nessun autore di manuali abbia avuto l’idea di scrivere un Sommario di decomposizione interiore, in cui avrebbe tracciato le nostre fluttuazioni e i nostri crolli quando noi non ci imponiamo né costrizioni né impedimenti, quando noi ci consegniamo a noi stessi”. Negli Esercizi negativi la lucidità assurge più che mai a condanna, maledizione, malattia, vertigine del vuoto: “vedere chiaro è vedere il nulla. L’insopportabile è l’elemento della vita proprio come la stanchezza ne è la categoria” – “un orologio che si ferma – ed è consapevole di essersi fermato, tale è la nostra condizione di oggetti irrimediabilmente lucidi”.
Tra le pagine più interessanti e preziose degli Esercizi negativi di Cioran è impossibile non annoverare quelle in cui il pensatore rumeno si scaglia contro la “tribù filosofica” da lui tanto esecrata, innanzitutto per l’incapacità di affrontare i problemi più urgenti degli esseri umani: “quando si scorrono i grandi filosofi – da Platone fino a Leibniz, Kant o Hegel – si direbbe che si sono fatti un punto d’onore di non guardare la morte in faccia”. La vita, dice Cioran, è stata uccisa dal vitalismo, che voleva convertirla in assoluto: “la frenesia di Nietzsche e quella un po’ più discreta di Bergson ce ne hanno fatto intravedere il fondo; a furia di esaltarla, l’hanno consumata”. La situazione non va meglio, agli occhi di Cioran, se si rivolge lo sguardo verso la filosofia del Novecento. “Heidegger ha raccolto da professore l’eredità di Kierkegaard: ne è risultata una costruzione magnifica, ma senza sale, in cui le categorie racchiudono le esperienze essenziali: un catalogo di angosce, uno schedario di disastri. Vi si insegnano le tribolazioni dell’uomo come la poesia della sua lacerazione.
È l’Irrimediabile diventato sistema”. Ancora più feroce è il giudizio di Cioran nei confronti di quello che era, nel momento in cui il rumeno scriveva questi appunti a Parigi, il maggior filosofo francese: Jean-Paul Sartre per Cioran è “un impresario di filosofia, di letteratura, di politica, il cui successo ha soltanto una spiegazione e soltanto un segreto: la sua mancanza di emozione; non gli costa niente affrontare qualsiasi cosa, poiché non ci mette nessun accento personale”. Le direzioni intraprese dalla filosofia e dalla letteratura di Sartre sembrano a Cioran stabilite a tavolino, le sue formule studiate a effetto per creare la maggiore eco possibile e la più grande risonanza mediatica. Sartre “parla della morte, ma non ne conosce il brivido, i suoi disgusti sono riflessi; le sue esasperazioni fisiologiche come inventate a posteriori; egli è l’anti-poeta inevitabilmente parallelo ai sogni”. Collocato così tangenzialmente alla filosofia e al pensiero francese del suo tempo, non sorprende affatto l’isolamento di Cioran nella scena cultura del suo tempo, con le dovute eccezioni e frequentazioni come quella con Samuel Beckett, mentre pure, di decennio in decennio, si andava sotterraneamente imponendo, anche al di là della Romania e della Francia, la fama di questo outsider come negatore del secolo e come pessimista catartico anche nelle sue riflessioni più radicali.
Gli Esercizi negativi ci mostrano uno Cioran in fieri, ma i suoi strali contro l’esistenza, anche negli accenti più cosmogonici, mantengono una grandeur incisiva e magniloquente nello scudisciare, letteralmente, tutto ciò che esiste: “solo Dio – e il verme – hanno una posizione chiara: Uno crea – e l’altro rosicchia la Creazione”. L’appendice del libro presenta anche degli appunti preparatori a Sillogismi dell’amarezza, il suo secondo libro in francese pubblicato da Gallimard nel 1952; e anche qui troviamo un grandioso aneddoto in cui Cioran prosegue la sua costruzione di un’auto-mitologizzazione cupa e graffiante, feroce innanzitutto contro sé stesso: “un giorno di non so più quale inverno, mi saltò in mente di spingere la sedia a rotelle di una giovane paralitica. Contentissimo di essermi imbattuto in qualcuno in grado di comprendermi, le feci i discorsi più tetri. Le parlai dei vari tipi di sonniferi, della loro inefficacia, dell’ossessione del suicidio nelle camere d’albergo, di non credere in nulla, nemmeno nella propria disperazione… Contavo sul fatto che la sua bontà sarebbe stata grande abbastanza da accrescere il mio quadro, da schiacciarmi con i suoi rimpianti, lei a cui la sorte aveva negato l’unico piacere, quello di calpestare la terra. Ma quando la sconosciuta alla fine aprì la bocca per assicurarmi: ‘Comunque la vita è bella’, il mio disappunto fu tale che la lasciai andare di colpo, furioso e perplesso, deluso”. Questi tre aggettivi sembrano costituire una sincera sintesi del sentire di Cioran.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente