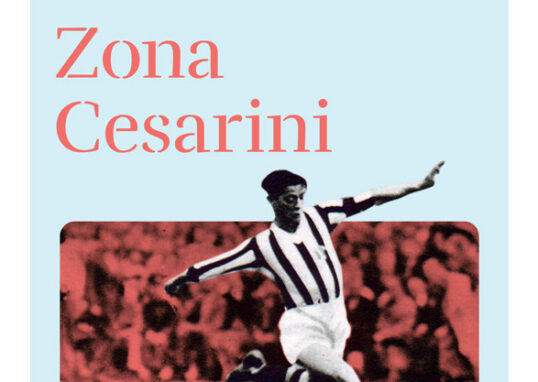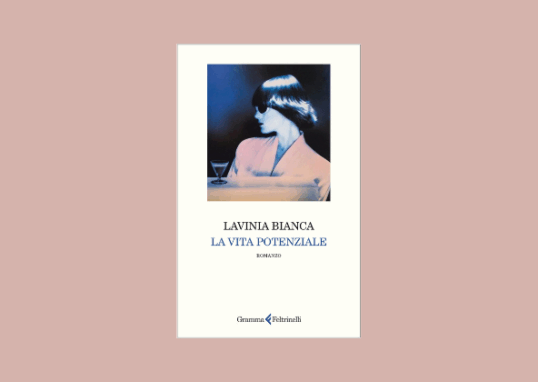Quando un autore è politicamente schierato accade che le sue storie risultino intrise di una certa rabbia. Se poi quello scrittore affianca alla vita intellettuale un concreto attivismo è probabile che lo stile, le vicende, i personaggi finiscano in qualche modo per catalizzare lo spirito guerrier ch’entro gli rugge. Questa rabbia esibita però, pur raccogliendo facilmente il plauso di chi condivide le stesse idee, tende a tenere lontana l’altra metà dei lettori, quelli che stanno dalla parte opposta, gli avversari, i contrari.
Un esempio oggi molto evidente è quello delle opere di matrice femminista. Romanzi, film, serie tv in cui la condanna del patriarcato è urlata e dove il binomio donna-vittima e uomo-carnefice è assai poco sfaccettato, favorendo così l’apertura di dibattiti solo all’interno di ambienti già sensibilizzati. È molto difficile che quella provocazione, quello spunto sia raccolto da un sedicente “maschio alpha”, portandolo ad avviare se non un ripensamento almeno un confronto con chi protesta. Viene allora da chiedersi quale possa essere la chiave affinché un testo femminista arrivi a far riflettere anche chi tende a minimizzare il problema, a negarlo, o peggio a scaricare la responsabilità sulle donne stesse.
La libertà è un passero blu di Heloneida Studart ci offre in tal senso, e retrospettivamente, degli appigli su cui ragionare. Il romanzo è apparso per la prima volta in Brasile, patria dell’autrice, a metà degli anni ’70, mentre in Italia è arrivato solo nei primi 2000 grazie alla casa editrice Marcos y Marcos che di recente ne ha pubblicato una nuova edizione, tradotta da Amina Di Munno.
Heloneida Studart corrisponde in pieno al profilo dell’intellettuale battagliera: scrittrice e giornalista da sempre esposta in prima persona per i diritti delle donne in un contesto socio-storico non facile come poteva essere il Brasile all’epoca della dittatura militare. Ciò nonostante riesce a fondare, insieme ad altre attiviste il Centro da Mulher Brasileira, la prima organizzazione femminista nella storia del suo Paese. Dopo aver subito un arresto e alcuni giorni di reclusione per via dei suoi scritti contro il regime e della vicinanza al Partito Comunista, Studart entra in politica e diventa parlamentare. Continua così le sue lotte, questa volta dall’interno, per ben sei mandati.
Da un’autrice, da una donna, di questo stampo ci si potrebbe allora aspettare un romanzo dall’indole pasionaria, un atto d’accusa solido e partigiano.
Invece la scelta stilistica del libro è rivelata già nel titolo, che se in italiano è leggermente parafrasato in La libertà è un passero blu, in originale è O pardal è um pàssaro azul, ossia “Il passero è un uccello blu”. Leggendo scopriamo che questa frase è parte integrante della storia, si tratta infatti di uno slogan sovversivo che innesca la linea narrativa principale: João, il cugino nonché grande amore della protagonista Marina, finisce in prigione per averla scritta sui muri della città. Per Studart dunque la lotta politica parla una lingua poetica, immaginifica, quasi fiabesca, alimentata dalla scelta di non esplicitare mai la metafora, ossia di non spiegare perché quella frase fa infuriare così tanto il regime.
La violenza, sia fisica che psicologica, che pervade l’intero romanzo è sempre in qualche modo smorzata, suggerita, ammorbidita dalle parole, senza alcuna enfasi da comizio. Più che una forma di auto-censura sembra essere un escamotage, un lasciapassare affinché l’orrore possa arrivare più in profondità. Restituirne una descrizione tollerabile, anche se sulle prime risulta meno disturbante, può permettere al messaggio di entrare anche nei cuori di chi fa presto a voltarsi dall’altra parte.
La giovane Marina, che fa da voce narrante, non può allora che essere un personaggio sfaccettato, una ragazza che sa essere pragmatica, realista, ma allo stesso tempo capace di slanci romantici, di sogni tanto irraggiungibili quanto struggenti. Studart le affida anche alcuni riferimenti autobiografici, primo fra tutti l’appartenenza a una famiglia molto ricca e dagli illustri antenati, che vive in una sorta di villa/prigione/cattedrale immersa in una zona disagiata del Brasile come può essere il Nordest. L’impostazione dei Carvalhais Medeiros, questo il nome fittizio scelto per il romanzo, è strettamente matriarcale: al vertice c’è nonna Menina, donna tradizionalista e autoritaria che fa il bello e il cattivo tempo con la vita quotidiana e sentimental-sessuale delle figlie. Non esita a relegare in convento chi desta scandalo perché “corre dietro agli uomini” ma allo stesso tempo disprezza i matrimoni quando sono sconvenienti, come quello della madre di Marina, rea di aver sposato un modesto impiegato. Casa Carvalhais Medeiros dunque pur essendo un micro-mondo composto da donne – gli uomini sono tutti morti o in prigione – ospita paradossalmente una femminilità repressa e annichilita.
L’unica per cui Nonna Menina stravede è proprio Marina perché, a suo dire, nonostante sia di bell’aspetto, non pensa ai ragazzi, s’impegna nello studio e soprattutto ha un carattere forte. Marina in realtà si dissocia dalla sua bellezza non per un senso della morale ma perché l’unico uomo che ama, suo cugino, non può né potrà mai ricambiarla. Quando la madre di Marina le rivela, con una certa dose di dispetto, che João è omosessuale, lei piuttosto che smettere di amarlo preferisce rinunciare al proprio essere donna, perché se a João non piace, non sa che farsene. A portare invece la sensualità, con forza uguale e contraria, all’interno della severa casa Carvalhais Medeiros è Pablo, un giovane e affascinante ragazzo muto, straniero, anche lui ricercato dal regime, che nonna Menina decide misteriosamente di ospitare. La carica seduttiva – e sessualmente violenta – del clandestino finisce per sconvolgere la vita della sorella minore di Marina, Dalva, e dell’eternamente nubile zia Nini.
La condizione femminile è dunque raccontata da un punto di vista insolito, Marina che si spoglia della sua femminilità lo fa certamente per amore ma il suo appare fin da subito come un atto di ribellione contro il clima tossico che respira sia fuori che dentro casa. Fuori ha a che fare con il maschile dei soldati, dei carcerieri, delle spie e di un João sempre più agonizzante, mentre dentro subisce un paradossale patriarcato al femminile, figlio di un retaggio che impedisce qualsiasi forma di sorellanza ponendo le donne sempre e comunque all’interno di una gerarchia di potere.
Studart si guarda bene dal dividere il mondo in buone e cattivi: in ogni personaggio, uomo o donna che sia, convivono emozioni complesse, spesso contraddittorie, il bene e il male si compenetrano e coesistono rendendo noi lettori più spettatori che giudici. Non ha bisogno di tagliare con l’accetta per far passare le proprie idee progressiste, la denuncia è tutta nella storia e poco nelle parole. La libertà è un passero blu non ci aggredisce ma allo stesso tempo non ci rassicura: chi è sensibile al tema non troverà solo conferme al suo pensiero, ma chi ancora si ostina a negare il patriarcato si ritroverà costretto a porsi qualche domanda.
Questo ci suggerisce che l’affabulazione verbale, le immagini malinconiche, perfino la dolcezza possono avere una valenza sovversiva e che una rivoluzione si può fare anche senza limitarsi agli slogan. La letteratura e la poesia possono avere un potere inclusivo che va molto al di là di quello didascalico. In un momento storico in cui sembra che i dibattiti su ogni minimo aspetto della nostra esistenza si svolgano sempre e solo tra due tifoserie contrapposte, ciascuna con le proprie grida di battaglia, forse sono proprio le storie e lo stile in cui si sceglie di raccontarle a poter tracciare un ponte. Leggere un’autrice come Studart ci fa pensare che è ancora possibile scrivere un racconto militante che non sia divisivo, che non accentui ma attenui la separazione tra due fazioni. Se dunque la rabbia separa, forse l’immaginazione può unire. Se invece di sinistra e destra, di Roma e Lazio, di vax e no vax, di filorussi e filoucraini, ripartissimo da un’immagine chiara e allo stesso tempo sibillina come il volo di un passero blu, forse riusciremmo non solo a creare dei confronti che non siano guerre fra sordi, ma anche a tirare giù la letteratura dalla sua torre d’avorio e a farle sporcare di nuovo le mani nella realtà quotidiana, ripensandone il ruolo attivo nella società (oltre che nell’arte) e restituendo dignità e concretezza alla bistrattata e sempre più evanescente figura dell’intellettuale.