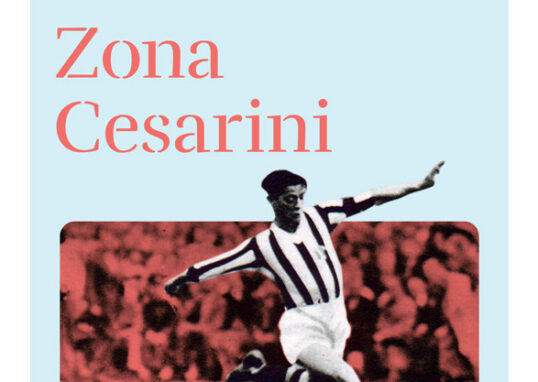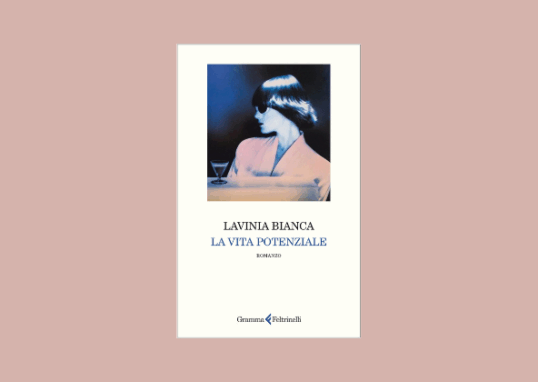(foto di Federico Pitto)
di Mario De Santis
“Devo punirmi da sola!”. Lo esclama Lavinia in una delle ultime battute de “Il lutto si addice a Elettra” di Eugene O’Neill. È il segnale che la riscrittura che il drammaturgo americano fece dell’Orestea, nel 1930 aveva espunto il divino. Oggi Davide Livermore ha rimesso in scena questo dramma di tormenti familiari anche perché il Teatro Nazionale di Genova – che Livermore dirige e che produce lo spettacolo in coproduzione con Centro Teatrale Bresciano per il 2026 – ha dedicato convegni e mostre a Luca Ronconi, che aveva a sua volta diretto. Il testo di O’Neill in una coproduzione del 1996 che vedeva assieme l’allora Teatro Stabile di Genova e il Teatro di Roma. In quella versione una delle protagoniste era proprio Elisabetta Pozzi, nel ruolo di Lavinia, mentre oggi l’attrice interpreta la madre, Christine, che allora fu ruolo di Mariangela Melato.
Uno scambio di ruoli è del resto uno dei cuori neri e inquietati del testo di O’Neill, che prevede che nella terza parte, morta la madre, Lavinia ne assuma le fattezze, vesta gli stessi colori, abbia lo stesso taglio di capelli che Christine aveva da viva (ovvero nel primo atto). Un dettaglio simbolico, che Livermore sottolinea, oltre a decidere – disegnando anche le scene – di ambientare la piéce negli anni ’30 del ‘900, all’epoca in cui è stata scritta, con l’aiuto dei bei costumi di Gianluca Falaschi e delle musiche di Daniele D’Angelo, richiamando compositori italiani di quel tempo (Bruno Maderna e Giorgio Federico Ghedini) con tocchi anche di jazz, crea un contrappunto di umanità a queste psicologie, estreme, crude, quasi da grandguignol.
Tutto il dramma poggia su una tempesta geometrica di complessi intrecciati (nel senso di Edipo e Elettra, secondo la vulgata freudiana) dentro la famiglia Mannon, ma in qualche modo il drammaturgo americano sposta il perno principale della meccanica di vendetta familiare rispetto ad Eschilo, dal Orin-Oreste (Marco Foschi) figlio incerto e nevrotico, succube dell’amore materno, a Lavinia-Elettra che in questa nuova edizione è interpretata, con l’ eleganza austera e dura, da un’intensa Linda Gennari.
Livermore, con la traduzione della grecista Margherita Rubino, che insegna Tradizione del Teatro Antico, ha sia modernizzato gli scambi rapidi di battute, sia compresso a tre ore il lunghissimo testo originale (quella di Ronconi ben oltre le cinque ore) con il risultato di esaltare, anche grazie al bel gruppo di attori, quel terremoto di coscienze in cui il destino di ognuno non è più appeso ai fili del cielo, ma è tutto nel labirinto-ragnatela tra conscio e inconscio dei personaggi. In O’Neill l’asse edipico madre-figlio segue quasi alla lettera lo schema psicoanalitico, lasciando affiorare anche l’incesto, tanto che Orin non è interessato alla giovane Hazel Niles (Carolina Rapillo) sorella di Peter (Davide Niccolini) un caro amico di Orin, ma soprattutto pretendente di Lavinia che però è a sua volta indifferente al matrimonio borghese (ma non al sesso e al desiderio, chiave di volta di tutta la pièce e che Livermore lascia emergere con segnali più espliciti).
A Lavinia interessa l’ufficiale di marina Adam Brant (che Aldo Ottobrino rende efficacemente con la giusta mescolanza di seduzione e risolutezza virile). Lei è però inconsapevole – nell’intricato rimando di doppi – che egli è anche l’amante della madre, la quale lo spinge a corteggiare la figlia. Christine è tratteggiata da O’Neill come pura passione e Pozzi ne fa una presenza magnetica, sanguigna, un personaggio mantide, che ha mentito a Ezra fin dalla prima notte di nozze, e fa del sesso l’arma della sua trama: scioccando il marito, tornato dalla guerra, con le rivelazioni su Adam e finendo il lavoro col veleno.
Il rapporto tra Lavinia e il padre Ezra Mannon (un potente Paolo Pierobon pur nella brevità del suo ruolo) è invece più complicato e non è di tipo smaccatamente sensuale e dipendente come tra Christine e Orin. Più che per amore, Lavinia è devota al suo potere (simbolica sarà la riconquista in solitaria della casa, che abiterà da sola). In sé porta i marosi del desiderio, un sesso extra borghese (si scatenerà nelle isole del sud, dove viaggerà col fratello dopo la morte del padre e il suicidio della madre, causato a sua volta dall’omicidio di Adam da parte di un manipolatissimo Orin). Come in un crime seriale, “Il lutto si addice a Elettra” è un susseguirsi di accuse e di colpe e di morti (ma sono morti che “non muoiono mai”).
Lavinia, diventata dopo i funerali un doppio della madre, farà lo stesso con il fratello: userà il sesso per farsi consegnare da lui la lettera in cui ha scritto la verità sui genitori morti.
Ci si può chiedere se un certo aumento di riprese dei classici tragici americani, sia solo il sicuro interesse del pubblico per certe trame (che si rinnovano con le serie tv). Forse la presenza costante da due o tre anni di O’Neill, Tennessee Williams, Miller e altri ha un riflesso inconscio anche nell’attualità politica e culturale, perché la famiglia tradizionale, il patriarcato, i ruoli sociali dei gender e la rivoluzione sessuale più o meno mancata, sono tornati ad essere prepotenti temi politici, con la virata conservatrice se non reazionaria che si osserva nelle società occidentali e non solo. Se questa è la tragedia “senza dèi” della modernità, della coscienza personale, e se abbiamo a cuore i cambiamenti di paradigmi del patriarcato, quanto le nostre scelte personali influenzano la storia collettiva? La filosofa femminista Donna Haraway scrive ad esempio: “Non fate figli, fate legami”. Ogni nostra scelta, anche privata, è politica, la lacerazione del desiderio è il tragico che ci attraversa.
Livermore fa bene ad esaltare questo punto. Il desiderio e il sesso (O’Neill è agli albori della diffusione della psicoanalisi) come i fulcri di tutto, tra potere e appagamento di sé e si concentra sulla componente femminile del dramma. In particolare, Lavinia, un personaggio che O’Neill ci consegna con una spavalda modernità (ricordiamo O’Neill ambienta la vicenda nel XIX secolo) e che si manifesterà in pieno alla fine, nell’impeto passionale per Peter che però, nel climax erotico, chiama “Adam” (come Brant e con richiamo biblico fin troppo scoperto). Si è incerti se pensarlo come un lapsus tragico, se il nome dell’amante della madre sia “agito” dallo spettro di lei (a proposito di spettri, O’Neill era dichiaratamente debitore di Strindberg). Oppure se sia una deliberata “coltellata simbolica” per cacciare Peter e finalmente rimanere sola, nel pieno potere della casa, nel pieno potere di punire sé stessa. Linda Gennari è brava nel far balenare in controluce questo sdoppiamento psicologico. Lo è anche nell’evocare il doppio attoriale, un sotteso meta-referenziale diffuso, ci è sembrato di cogliere in certi toni l’impostazione che diede al personaggio Elisabetta Pozzi (Livermore ha anche inserito frammenti di audio della versione del “Lutto” di Ronconi per la Rai, che si ascolta da una radio). Il bel cast genera un crescendo di espressionismo psicologico, che dal realismo si fa noir, un gotico americano con punte d’horror (ma alla Shirley Jackson). Il colore del lutto si fa sempre più dominante (dai fiori neri alle sovrapposte geometrie a mise-en-abyme o labirinto, gelide e optical, alternando bianco e nero cinematografico).
Già concepita da O’Neill come trilogia da fare in una sola replica, per un totale di 14 scene, Livermore forse ne aggiunge altre e le separa tutte da una calata di sipario, e buio, a mo’ di pausa con musica e ad ogni chiusa, scatta l’applauso del pubblico, come dopo un’aria d’opera o un musical. Interruzioni funzionali a cambi di abito e scena, che rallenta, è dà saliscendi di tensione. Come “puntate” di una serie – o di una soap – forme diverse di un’evoluzione, da Eschilo a noi, di come uomini e donne si rispecchiano nelle rappresentazioni delle proprie azioni e desideri. Spariti gli dèi, ci resta lo spettacolo del nostro inesauribile senso di colpa, che si addice a Broadway.
Dopo Genova, la tournée riparte nel 2026 da Palermo (Teatro Biondo), dal 7 all’11 gennaio, poi Napoli (Teatro Mercadante), dal 14 al 18 gennaio; Torino (Teatro Carignano), dal 21 al 25 gennaio; Brescia (Teatro Sociale), dal 27 gennaio al 1° febbraio; Trieste (Teatro Rossetti), dal 5 all’8 febbraio; Treviso (Teatro Del Monaco), dal 12 al 15 febbraio.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente