
di Marco Renzi
«Eccetera» è la parola con la quale si conclude Pianura, e sta a significare che tanto ancora ci sarebbe stato da dire su un argomento sconfinato come la Pianura Padana: sconfinato non tanto per la sua superficie, quanto per la ricchezza di spunti, di riflessioni, di immagini e reminiscenze letterarie – e non – che questo territorio può suscitare.
Col suo ultimo libro, Marco Belpoliti decide anzitutto di omaggiare il luogo dov’è nato, e lo fa mediante una lunga lettera indirizzata a un amico sul quale pian piano scopriamo qualche dettaglio: per esempio, sappiamo della sua formazione scientifica e che è stato un compagno di liceo dell’autore.
La scelta della lettera permette quindi allo scrittore di eliminare qualsiasi gerarchia tra i temi trattati, procedendo su un filo intimistico-emotivo e seguendo la mappa della Pianura posta in apertura che, come le altre illustrazioni a corredo del testo, è opera dello stesso Belpoliti.
Se è difficile definire uno spazio come quello che va dall’Emilia fino alla Lombardia, è al tempo stesso arduo decidere cosa sia Pianura: un romanzo? Un saggio? Una confessione? Non c’è una risposta corretta; ma è pur vero che l’autore riesce ad amalgamare bene vari elementi presi in prestito dalle forme di cui sopra e a restituire, pur nella apparentemente ristretta selezione di rimandi e suggestioni, la molteplicità di sfumature incarnata da una porzione d’Italia che tanto ha dato alla storia culturale del paese.
Ed è proprio in questi anfratti, non necessariamente i più importanti o rivoluzionari, che si addentra la prosa asciutta e avvolgente di Belpoliti, tipica della scuola emiliana.
Il libro, da un lato, è in primis un manuale per chi è a digiuno riguardo alla fenomenologia della Pianura padana; dall’altro lato, è un prezioso regalo a chi quei luoghi li ha visitati – poco importa se fisicamente o per mezzo di quadri, libri, film eccetera.
Sono tante le figure e le storie che popolano Pianura: se il tutto comincia con la «romanizzazione» dell’Emilia, nel capitolo successivo ci si sofferma sul fotografo Luigi Ghirri – autore peraltro del brumoso scatto di copertina –, appoggiandosi al grande Gianni Celati, uno dei nomi più ricorrenti in queste pagine e del quale Belpoliti ha curato il Meridiano.
Dalla vicenda di Ghirri si comincia a delineare lo spirito del libro, o meglio il suo filo conduttore; ossia: cosa vuol dire abitare nella Pianura? Cosa significa essere padani?
Lo sai che qui da noi nella pianura tutto sembra annodato, tutto si rimanda, ed è una strana sensazione d’appartenenza a qualcosa che c’era prima di noi e ci sarà dopo di noi, qualcosa che ci rende sereni, anche se a volte ho l’impressione che sono dovuto uscire da quell’incanto, andarmene via, lontano, per vedere meglio.
Ecco, qui si comincia a delineare uno degli argomenti-chiave dell’opera, dove lo scrittore racconta di aver vissuto prima in Emilia, poi in Brianza e a Milano – Milano della quale qui si parla in relazione a Manzoni e alla sua Storia della colonna infame –, dunque senza mai davvero staccarsi dal cordone che lo legava alla Pianura. Eppure è come se il trasferimento dall’Emilia alla Lombardia lo abbia aiutato a perfezionare il suo sguardo, a renderlo più sensibile, potendo così dilungarsi in un testo tanto peculiare permeato dal profumo del ricordo e della memoria.
Sono molti gli scrittori che hanno abitato e celebrato tali posti; pensiamo a Cesare Zavattini, a Gianni Celati e al suo infinito camminare, a Daniele Benati; o a Ermanno Cavazzoni e al suo Poema dei lunatici, portato al cinema da Fellini (e chi altri avrebbe potuto farlo?) con La voce della luna, dove si estremizza in qualche maniera la tesi di fondo di Pianura, secondo la quale il padano, ma anche il John Berger che passeggia sugli argini del Po e descrive il fiume nel suo Sacche di resistenza, è appunto un po’ umorale e un po’ lunatico, per riprendere Cavazzoni.
Se non proprio dei lunatici, molti dei personaggi qui raccontati rappresentano dei tipi umani singolari, come lo sono a loro modo le città in cui vivono.
Se andiamo a Modena, per dire, «una città misteriosa come una vecchia signora adagiata sul fondo della pianura che ti attende da secoli», ci imbattiamo nel pittore Giuliano Della Casa, che lì ha sempre abitato e che possiede gli occhi per vedere l’ora blu, «quella particolare condizione di luce che accade all’alba, oppure al tramonto, quando il sole è scomparso dietro l’orizzonte e tutto si tinge di questo medesimo colore».
Modena è sì la città di Giuliano Della Casa, ma è anche la patria dell’aceto balsamico; ed è naturalmente la città di Antonio Delfini, scrittore eretico, se vogliamo marginale, autodidatta, nato benestante e poi finito in povertà, autore di splendidi racconti e poesie, nonché del Manifesto per un partito conservatore e comunista, amato tra i tanti da Montale e soprattutto da Cesare Garboli, il quale scrisse memorabili introduzioni a Il ricordo della Basca e ai suoi Diari.
È grazie a un antico incontro con Garboli che Belpoliti ricostruisce il ritratto di Delfini, andando a toccare anche alcune corde della personalità del celebre critico rifugiatosi a Vado di Camaiore dopo il delitto Moro. Ma è Antonio Delfini a rimanere l’assoluto protagonista.
Era, disse Garboli, uno strapaesano e un ribelle. E con queste parole quel giorno sanzionò in modo definitivo il carattere di chi vive in questo pezzo della pianura: puerile, strapaesano e ribelle. Delfini era un modenese; meglio, un emiliano allo stato puro. […] Con quella definizione, per quanto oscura e tortuosa, aveva spiegato […] gli aspetti salienti del carattere di noi emiliani. Forse non proprio di tutti, ma almeno quelli che avevano cercato di essere artisti e scrittori, contravvenendo in questo modo alla natura pratica e edonistica di chi vive dalle nostre parti. E c’era un altro paradosso che mi si illuminò allora: proprio perché sono puerili, paesani e ribelli, gli emiliani appaiono così goderecci e pratici. Antonio Delfini aveva compiuto un capolavoro: fallire in modo perfetto scrivendo dei capolavori.
Come non citare, a questo punto, il magòn, il magone in dialetto reggiano? Se già Delfini ne fu immenso cantore, un altro campione indiscusso fu Pier Vittorio Tondelli. Originario di Correggio, umorale come ogni padano che si rispetti, nel suo folgorante esordio Altri libertini e nei romanzi successivi, descrisse come pochi altri il paese natio e i posti limitrofi, sempre accompagnato da quel magone che lo portò a viaggiare incessantemente, con gli occhi però sempre rivolti all’Emilia, alle sue strade, alla sua gente, specie i tossici e gli emarginati come i protagonisti di Postoristoro, il racconto che apre meravigliosamente Altri libertini.
Si potrebbe scrivere a lungo di Pianura e delle storie che lo popolano: per esempio, quella della folle avventura teatrale di Giuliano Scabia coi Giganti del Po; o quella di Angela Ricci Lucchi e Yervant Gianikian, «due amanuensi dell’immagine, dei copisti che hanno trascritto un intero continente d’immagini composto, invece che di parole, di segni e di figure».
Belpoliti racconta poi l’esplosione, da lui vissuta in prima persona, dei CCCP, e qui dedica bellissime pagine sia a Giovanni Lindo Ferretti, sia ad Annarella Giudici: una compagine punk possibile solo nel perimetro dell’Emilia paranoica.
Non mancano poi altre incursioni nella letteratura, come il capitolo dedicato alle strade boscose e selvatiche che ispirarono Boiardo e Ariosto per L’innamorato e il Furioso, o Il padano Petrarca firmato dal professor Camporesi; per non parlare di nuovo del più volte menzionato Gianni Celati e dei suoi Narratori delle pianure, di Pinocchio, di Primo Levi – che non poteva essere assente in un libro di Belpoliti. Le anguille di Comacchio divengono infine un espediente per discorrere sull’Anguilla montaliana.
Le riflessioni si spostano infine anche sull’archeologia, la geografia e la geologia della Pianura: dalla «godena» al Delta del Po passando per la Romagna e i suoi confini, fino alla forma «a losanga» di Reggio Emilia.
Ciò detto, malgrado tutto, resta complicato definire un libro stratificato come Pianura, la cui complessità risiede nei dettagli e nei più improbabili e rilucenti interstizi, senza tuttavia cedere a nulla di cervellotico; anzi, il testo scivola via leggero, come se il lettore fosse l’amico-destinatario al quale Belpoliti ha indirizzato questa lunga e sentita missiva; un’epistola che i migliori lettori, umorali o meno che siano, non dovranno lasciarsi sfuggire, poiché si tratta di merce rarissima nel panorama letterario odierno.
Marco Renzi (1989) è dottore di ricerca in Italianistica.
Ha scritto di musica per «Audiodrome», «TheNewNoise» e «Indieforbunnies». Ha collaborato per quattro anni alla sezione Re:Books del «Mucchio Selvaggio». Collabora con «Il Foglio», «Minima et Moralia» e «L’Eco del Nulla«». Altri suoi articoli e racconti sono comparsi su «Duemilauno», «PULPLibri», «CrapulaClub», «Nazione Indiana», «In fuga dalla bocciofila», «Narrandom», «Spore», «Bomarscé» e sulle antologie I giorni alla finestra (Il Saggiatore, 2020) e Cronache dalla Quarantena (Nutrimenti, 2020).

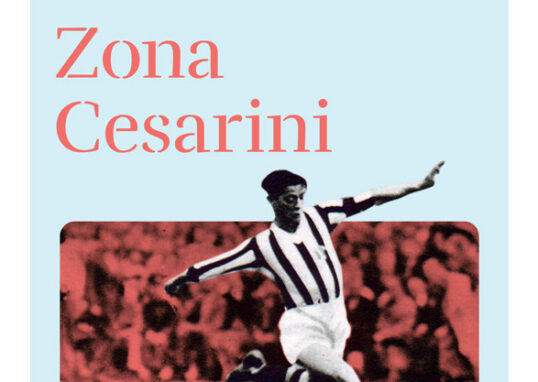


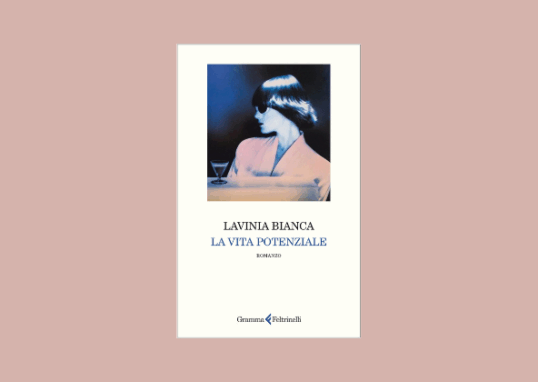

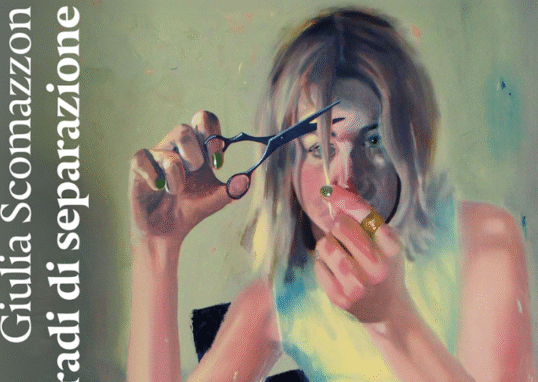
Mazzacurati!