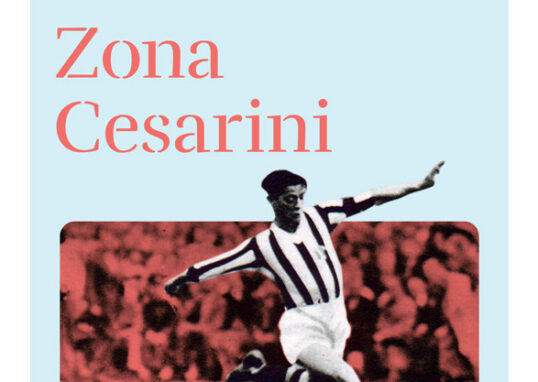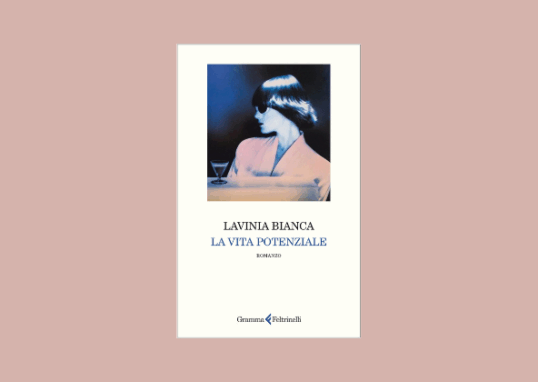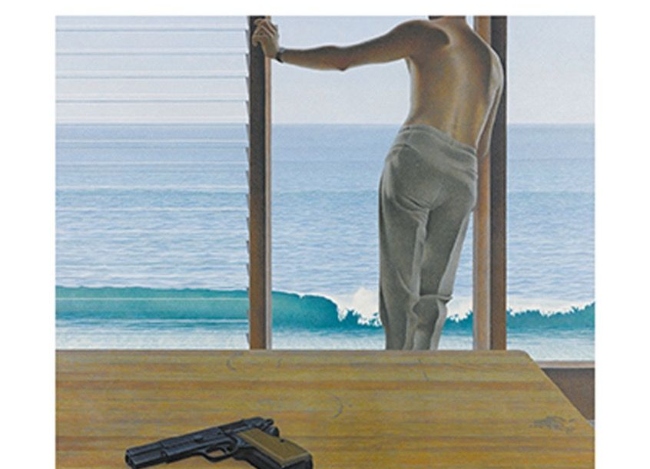
di Marco Carratta
In un articolo pubblicato sulla rivista “Gli asini” nel 2016, Taddeo Mecozzi raccontava la sua esperienza di tirocinante presso il Tribunale di Genova, che gli ha permesso di darci una descrizione impietosa ed appassionata di quella che è la parte vecchia della città. Quel centro storico che pochi conoscono veramente, chiuso e autonomo, fatto di vicoli bui, piazze strette e chiese rinascimentali, in cui vive, ma forse sarebbe meglio dire cerca di sopravvivere, la maggior parte di coloro che oggi sono ai margini della collettività e del benessere economico. Un ghetto di esclusi e, tra questi, un gran numero di delinquenti di ogni risma.
E a questa collettività, fatta di reietti, di criminali grandi e piccoli, è dedicato il romanzo di Sara Benedetti “Sulla cattiva strada” pubblicato dalla casa editrice nottetempo. L’autrice conosce Genova e i suoi vicoli grazie alla sua esperienza professionale di documentarista impegnata nella realizzazione di un lavoro sulla prima squadra di rugby nata in un carcere che partecipava ad un campionato ufficiale. Da lì la necessità di raccontare con altre forme artistiche le parole, le storie e i luoghi di chi ha incontrato.
Il libro si apre con Tedesco, “ragazzino biondo e con gli occhi azzurri, con l’aria sveglia e attento a non fare domande stupide” intento ad apprendere tutto ciò che serve per superare l’apprendistato criminale per diventare “grande” tra i carruggi, e lo ascoltando le storie di Pagano, un ragazzo dieci anni più grande di lui, “un mohicano arrivato con qualche nave cargo”. Una scena che non viene descritta come una delle tante “scelte sbagliate” indotte da contesti difficili, bensì come l’unica possibilità per sopravvivere, in luoghi dove “per mettersi nei guai bastava dire cose che non si dovevano dire e sentire cose che non si dovevano ascoltare.” E allora a dare un ordine ci sono delle regole che, per quanto crudeli, restano le uniche certezze.
Inizia così il racconto che per trenta anni segue le vite di un gruppo di ragazzi, di fratelli di strada, che toccano tutti i grandi eventi della storia contemporanea di Genova, a partire dalla costruzione dell’Acquario fino al crollo del Ponte Morandi. Per ironia della sorte, la tragedia che ha stravolto la vita di decine di famiglie e portato l’immagine del ponte spezzato a metà sul Polcevera sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo avviene lo stesso giorno di 26 anni dopo l’inaugurazione dell’Esposizione universale che ne cambiò il volto.
Vite ingarbugliate, sporche, malfamate, nascoste si sviluppano in una simbiosi fortissima con i vicoli e la città di Genova che entrano anche nella lingua usata nel libro, in cui la trascrizione fonetica delle espressioni del suo dialetto danno ai dialoghi l’effetto di un bagno di realtà. Tedesco, Pagano, Lateef, Toso, Lord Jim, Morango e gli altri protagonisti che incontriamo in questo romanzo corale condividono violenza, povertà, processi, prigione, lutti in una città che è come “un’arena bellissima, dove qualcuno si divertiva a vedere i vicolari scannarsi tra loro”.
Sono carruggiai del quartiere Maddalena anche se le loro origini possono essere diverse; “puzzano di povertà” e hanno poco da spartire con gli studenti figli di papà con “le treccine e i pantaloni da odalisca” che incrociano nelle serate trascorse tra i locali della città vecchia.
Le uniche figure di riferimento sono i fratelli maggiori incontrati per strada, nulla li eccita più delle azioni criminali. Tifano la Samp anche se per loro il Marassi è soprattutto il carcere, “l’inferno in terra. Corridoi pieni di celle con otto o dieci detenuti per ognuna. Una sola guardia che stava seduta col banchetto nel corridoio e veniva chiamata in continuazione. Uno voleva andare in doccia, uno voleva compilare la domandina, in una cella scoppiava una rissa. Un continuo e le guardie impazzivano. Le dovevano cambiare come lampadine fulminate. Però, prima che le cambiassero, le guardie erano già esaurite, piene di odio da buttare fuori e la facevano pagare a chi era nella loro sezione.” Tutti i vicolari ci dovevano finire, molti non ne uscivano più se non morti, “funzionava così, ci si conosceva nei vicoli da bambini e ci si ritrovava nei collegi. Collegio, poi comunità, poi carcere. Questa era la carriera”.
Nei giorni del G8 del 2001, mentre tutti guardavano con attenzione il fallimento di una delle democrazie più ricche dell’Occidente e si chiedevano cosa sarebbe rimasto delle istanze urlate da migliaia di dimostranti venuti a Genova dai quattro angoli della terra, a loro non restava che “infilarsi nei negozi con le vetrine rotte e prendere quello che riuscivano”, a mo’ di compenso “per aver dovuto cedere Genova agli estranei”. A lasciare il segno non fu i il sangue sull’asfalto “di uno visto qualche volta in giro, incontrato agli Asinelli”, bensì la consapevolezza che per qualche giorno, ad essere inseguiti dalla polizia, erano stati i bravi ragazzi e non loro, e che presto le cose sarebbero tornate alla normalità.
Scontri per il controllo del quartiere e delle sue attività criminali, combattimenti clandestini, prostituzione, spaccio e consumo di droga da reperire anche grazie viaggi all’estero e a carruggiai che hanno esteso la loro rete criminale, riti di iniziazione che si rivelano vere e proprie azioni delittuose pronte a segnargli in modo indelebile la vita e la fedina penale. Ma anche amori, gelosie, ideali politici a tratti ingenui, fantasie romanzesche, stupide bravate che grazie alla maestria dell’autrice ci ricordano quanto la giovane età dei protagonisti li renda ancora maldestri e a tratti buffi, e quindi non diversi dai loro coetanei di ogni dove. Trent’anni in cui sfumano le poche occasioni di creare un’alternativa reale ad un futuro che fin da piccoli percepivano come scontato, che non riescono a spezzare l’incantesimo che puzza di maledizione, quella di essere un carrugiaio.
Tutto questo rende il romanzo un affresco universale che va ben oltre il particolare contesto in cui prende vita, perché Sara Benedetti raccoglie tanti temi che convergono nella stessa necessità: quella di raccontare la complessità della vita di quelle persone, e nei vicoli ce n’erano più che da altre parti, “con un buco nero dentro. Un buco che ti nasceva nel cervello o nella pancia per le cose che avevi visto e che ti avevano fatto fin da quando eri piccolo. Ed era difficile tirarsene fuori, perché tutto quello che succedeva, anche il bello, finiva lì dentro, risucchiato da una forza sconosciuta, e scompariva”.
________
Riferimenti: Taddeo Mecozzi, Genova. Stranieri tra i vicoli, Gli Asini, marzo-aprile 2016
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente