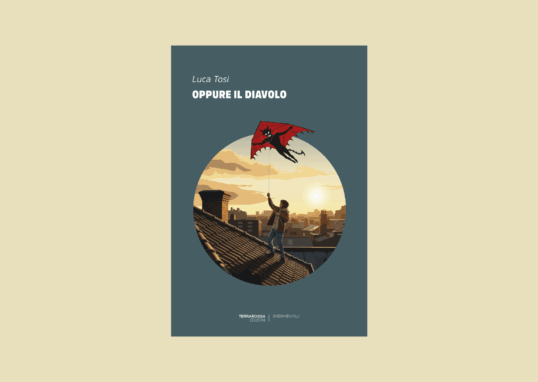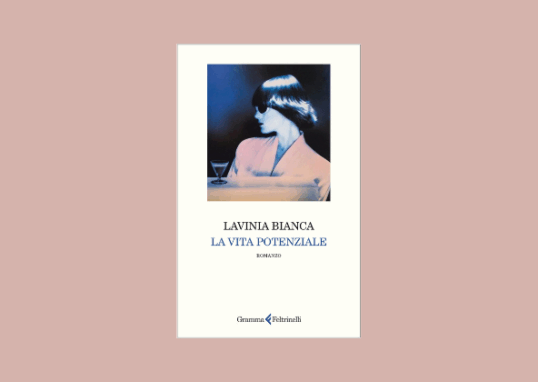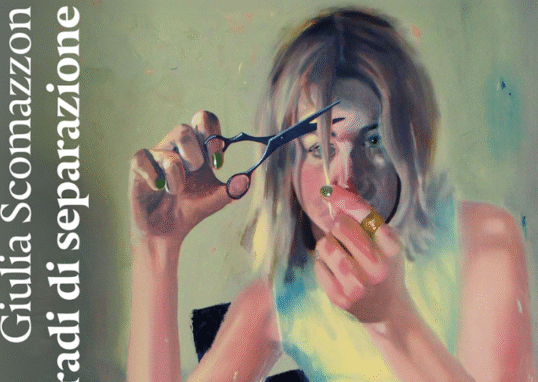Pubblichiamo, ringraziando editore e autore, un estratto da “Eco” di Cesare Sinatti, pubblicato da Italo Svevo Edizioni nella collana Incursioni.
*
Snudo i denti, succhio aria gelata. Il treno sarà qui fra poco. Guardo l’albero che cresce sul retro della kebabberia della stazione, in un giardino da cui qualche volta ho visto scappare fuori i topi, questo albero appesantito dai rampicanti che nessuno si cura di sradicare. Penso alla mia destinazione; penso all’idea che ci ha tentati e legati assieme e guidati in questo sogno non tanto del leggere i libri ma dell’amarli come se contenessero verità, come se il poetico nei libri potesse rivelare qualcosa della vita; penso ai viaggi che ho fatto e a quello che sto per fare. Non sarà tanto diverso da quelli per raggiungere Resi a Siena. Penso a ciò che pensavo allora e a ciò che penserò tra poco, nell’accompagnamento ritmato e meccanico del treno, quando vedrò dilatarsi i paesaggi di questo paese di colline, montagne, pianure nebbiose e lastre di mare: staranno comparendo per me, questi paesaggi, per parlare a me, per rivelarmi qualcosa; starà calando per me questo buio che non lascia altro da fare che leggere e dormire, leggere e sognare e vedere i sogni diramarsi nelle vite e nelle opere degli autori che, come me e Resi, avranno cercato il bello e il poetico.
Avranno viaggiato anche loro lungo questi binari, su uno di questi treni che, magari tagliando per Faenza anziché procedere fino a Bologna, avranno attraversato la Toscana passando per villaggi appenninici che immagino sempre e solo innevati e sempre e solo immersi nella notte, incendiati dalla luce livida che splende tra una galleria e l’altra; avranno attraversato questi villaggi, i poeti, portandosi dietro le loro allucinazioni, come ad esempio avrà fatto Dino Campana, di cui non saprei citare a memoria nemmeno un verso ma di cui mi è rimasta impressa l’espressione con la quale ai tempi si definiva la sua malattia: mania deambulatoria.
Avrà sentito, Campana, questo bisogno immotivato di partire, di andarsene, di scapparsene altrove a praticare altri mestieri e a vedere altre persone. Anche Campana, di sicuro, maniaco e deambulante, sarà passato per ognuna di queste stazioncine duobinariche tumulate nella neve alla ricerca di qualcosa o di qualcuno, e avrà camminato con le scarpe rotte e i piedi fasciati attraverso tunnel scavati nella roccia e sentieri battuti soltanto dai suoi passi, portando con sé un bagaglio minimo di libri e di quadernacci color sangue, intento ad appuntarsi nel cervello le crepe di dolore che straziano ogni brano dello spazio percorribile. Sarà sembrato chiaro anche a lui, nella sua ipersensibilità di pazzo secondo i criteri del suo tempo, quello che a tanti comincia a diventare chiaro solo alla fine dell’età adulta, ovvero che per rimanere ancorati saldamente a qualcosa, qualunque cosa sia, è necessario continuare a muoversi; lo avrà realizzato, Campana, traversando quei paesini che vanno spopolandosi anche delle poche anime canute rimaste a rimuginare ai tavoli ominosi di locande e bar, in un aldilà di montagne agglutinate e di strade tese come stringhe sul punto di spezzarsi.
Ma lo avrà sentito ancora più intensamente quando, fuggito da quei microcosmi isolati verso l’universo più ampio della pampa argentina sferzata dai venti dell’Atlantico, si sarà finalmente fermato e riposato in quelle pianure, trascorrendo ore e forse giorni disteso sulla schiena lungo il suolo smisurato del continente americano, sapendosi in moto perpetuo anche se fermo. Proprio là, disteso immobile, in pace a osservare la rotazione dei giorni e delle notti sopra di sé, avrà iniziato ad avvertire la dilatazione polmonare della Terra distanziare attorno a lui gli steli variopinti delle piume della pampa e, allo stesso tempo, simmetrica sopra di sé, la dilatazione polmonare del cielo separare fra loro le quattro stelle della Croce del Sud, che così, un giorno, avrebbe cessato di esistere. Proprio là, disteso immobile, Campana avrà avvertito l’espandersi di un cosmo che per nascere è esploso all’interno di un altro, squarciandolo e straziandolo da dentro, e che a sua volta continua a esplodere, squarciato e straziato al suo interno dall’avvento del cosmo successivo. E avrà pensato, là dove ogni uomo si sarebbe sentito perso nel nulla, che è il nulla a essere perso nelle cose, e nell’uomo fra tutte le cose, premendo dall’interno di ciascuna per emergere da essa come l’embrione che stia consumando, sviluppandosi, i succhi nutritivi contenuti nell’oscurità piombata del suo uovo.
Là, nella solitudine della pampa, lo avrà colto un terrore panico totale e senza oggetto, percepito più che concepito; un terrore della stessa natura di quello sentito alla vista di un cadavere, quando il dispiacere per il morto è superato, anche se solo per un attimo, non dall’idea ma dalla visione immediata di un annientamento che riguarda noi stessi e di cui un giorno faremo esperienza dall’interno di noi stessi, naufragando e annegando nelle profondità materiche del nostro stesso corpo, mentre assistiamo allo spegnersi graduale delle luci dei pensieri.
Campana, a quel punto, si sarà alzato. Avrà pensato di dover tentare qualcosa, qualsiasi cosa, pur di trattenere vicine le quattro stelle divergenti della Croce del Sud nel cielo argentino, pur di mantenere il globo polveroso e arido della luna vicino a quello liquido e lussureggiante della Terra, pur di far sì che entrambi restassero ancorati alla sfera tiepida del sole, e il sole a tutti i soli nella ruota radiante della galassia, e tutte le galassie al fusto luminoso dell’albero del cosmo. Avrà sentito di dover correre da un punto all’altro, ritornando con l’ostinazione di una cometa impazzita in luoghi che si sarebbero fatti sempre più lontani; e correndo per le infinite praterie argentine avrà pensato di dover guardare, ricordare e appuntare nel cervello in una lingua propria la materia smembrata dei villaggi appenninici, degli sguardi offuscati degli anziani, delle distanze impercorribili della pampa, delle costellazioni frantumate nella notte. E avrà creduto, deambulando, guardando, appuntando e ricordando, avrà creduto, con tutti questi gesti inutili e infinitamente delicati, di poter salvare l’universo. Come tutti i poeti.
E anche tu, come me, ti sarai voluta alzare, sollevare, e poi avrai voluto correre, tentare. Anche tu, come me, avrai sentito, avrai capito, guardando me che ti guardavo, guardando me che rimanevo lì al piazzale Est, anche tu mi avrai pensato e immaginato sulla via di casa. Anche tu avrai provato mille volte, in mille modi, a spiegartelo e a spiegarmelo che cos’è che succede nel poetico e nel bello; anche tu avrai cercato di spiegarti e di spiegarmi perché soffrivi, ripetendomi che le tue poesie perdute erano segni. Anche io, come te, guardando te che mi guardavi, ho cercato di pensarti e di pensare quello che pensavi; e attraverso la mia pelle ho creduto di sentirlo dilatarsi, ciò che pensavi, ciò che avevi in te, come le immagini del sogno di questa notte e come le fantasie dei miei viaggi in treno; e mi è sembrato di poter vedere tutta la tua piccola vita legando fra loro le parole che mi avevi detto, il tuo modo di muoverti e di vestire, le tue espressioni, le tue fotografie e gli ambienti che abitavi; e ho creduto di vedere anche, nella tua piccola vita, l’incubo vegliante di questo mondo senza segni né sensi né destini, in cui ciascuno si risveglia a mano a mano, crescendo, e da cui anche tu, come me, hai fatto di tutto per non risvegliarti, cercando ovunque al suo interno la scintilla del poetico, del bello che non c’è. Anche tu: come me. Questo ho creduto di vedere. E credendo di vederlo, e poi vedendolo, ho sentito lo stesso rapimento che sentivo quando leggevo i romanzi che mi prestavi, quando li leggevo in treno mentre venivo da te e fantasticavo sulle vite, le opere e le malattie degli autori; lo stesso rapimento che provavo ascoltando poesie lette ad alta voce, a volte in lingue che nemmeno conoscevo, da stranieri che pure hanno catturato interamente la mia anima col ritmo delle parole; il rapimento in cui il flusso della mia concentrazione arrivava a coincidere del tutto con quello della lingua di un altro e del pensiero di un altro, come ci è accaduto certe notti in cui ci siamo rivelati a vicenda le nostre ingenue e totalizzanti visioni della vita, cospirando per continuare a raccontarci la storia che riposa placida nell’abbandono del cosmo sognante; la storia per cui nonostante tutto siamo arrivati a incontrarci, a essere qui, confabulanti e sperduti, a guardare l’altro che ci guarda, a riconoscere nell’altro il nostro stesso guardare, a guardare, cioè, come se stessimo leggendo.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente