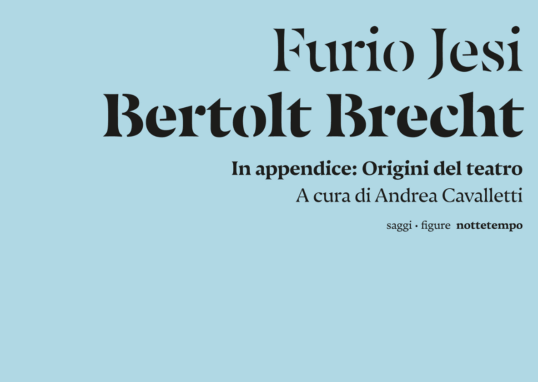Con “La valigia dell’autore” proviamo a creare un racconto e una mappatura della scrittura per il teatro in italia. Drammaturghe e drammaturghi italiani di questo primo quarto di XXI secolo si raccontano, riflettendo attorno al metodo, agli incontri essenziali, all’immaginario che hanno plasmato sul palcoscenico (G.G.).
Puntata n°10 – Sedici domande a Fabrizio Sinisi, drammaturgo, poeta e critico letterario, che ha cominciato il suo percorso di scrittura a fianco di due pilastri della scena italiana come Sandro Lombardi e Federico Tiezzi. Nel suo percorso di scrittura figurano collaborazioni e commissioni, come la riscrittura del Giulio Cesare di Shakespeare per Andrea De Rosa e Il ministero della solitudine, realizzato in collaborazione con lacasadargilla; e testi sviluppati autonomamente come La gloria e Jekyll, finalista ai premi Tondelli, Testori e Platea.
Dove nasce la prima scintilla della tua scrittura teatrale, l’idea di partenza e l’incipit: in sala o sulla scrivania?
Da qualche parte Paul Valéry scrive che nella poesia il primo verso è sempre donato. Per me è così anche per la scrittura teatrale, la scintilla può essere ovunque: un aneddoto raccontato da un amico, un episodio sul giornale, una frase di un libro, un incidente qualsiasi, l’incontro con un regista o con un attore con cui accade una particolare sintonia; a volte un pensiero casuale, un ragionamento inesplorato; qualcosa che succede camminando (cammino moltissimo, mi muovo sempre a piedi, anche se devo andare dall’altra parte della città, per me camminare è un po’ quello che per un attore è il training, qualcosa che attiva lo sguardo e mette in movimento pensieri e processi). La questione cruciale poi non è la scintilla iniziale, le idee sono sempre moltissime, ho taccuini e note del telefono zeppe di ipotesi e trame e frammenti di monologhi e dialoghi; la questione per me è capire quale idea può effettivamente diventare un testo, qual è il testo da scrivere, o la strada da percorrere all’interno di un lavoro che già esiste magari per commissione.
Nel tempo mi sono accorto che la strada giusta non è quella che mi fa scrivere tanto e subito, ma quella che sento più fertile, più ossessiva, quella su cui la mente ritorna anche involontariamente. Io non mi sento uno scrittore di storie, mi sento uno scrittore di temi, intendo temi nel senso sia concettuale che musicale del termine, lavoro sul linguaggio molto più che sulle psicologie, e quindi per me un’idea funziona se ha dei temi forti, che mi restano in testa, che continuano a “suonare”, quelli che fanno nascere prima il desiderio e poi la necessità di svilupparli, di andarli a verificare. Non so mai bene cosa succederà in un testo, per saperlo devo scriverlo, è come un lavoro d’improvvisazione però con la scrittura, la scrittura è il processo di verifica di un’idea. Se andando avanti mi accorgo che in quello che scrivo ci sono certi battiti, certe musiche, si aprono certi spazi, si attivano processi, si toccano delle corde che a me interessano, allora proseguo. Altrimenti lascio perdere e provo qualcos’altro.
Come funziona la parte di scrittura in solitaria? Dove scrivi? Quante ore al giorno? Hai una routine?
Mi sveglio molto presto, verso le sei, e mi metto alla scrivania. Quelle sono le ore più importanti, a cui non rinuncio mai, le prime tre o quattro ore della giornata, quando tutto è ancora silenzioso, la mente è sgombra e ricettiva, il telefono spento. Poi, siccome ogni lavoro ha le sue esigenze e le sue fisiologie, il resto della giornata può cambiare, ma quel momento di scrittura è il punto fermo. Poi ci sono le prove, che sono sempre un momento preziosissimo, quasi sempre le prove sono una vera e propria continuazione della scrittura.
Come funziona la revisione dei tuoi testi? Sono influenzati dal lavoro in sala? Riscrivi scene che vengono provate?
Il lavoro in sala mi influenza completamente, nonostante io non sia un regista (o forse proprio perché non lo sono), è un momento imprescindibile. Per me la prima stesura di un testo è sempre poco più che una bozza. Poi inizia una serie di riscritture, prima col regista e poi con gli attori, in un continuo rimbalzo fra sala e scrivania. Anche se non è sempre facile riuscirci, cerco sempre di avere una piccola sessione di prove lontane dal debutto, in modo che se serve posso anche riscrivere completamente il testo.
Carta o computer? Che differenza c’è per te? Il mezzo influenza la scrittura?
Scrivo tutto a mano. Poi ricopio al computer, ma le prime stesure sono sempre su carta.
Hai dei rituali per la tua scrittura? Scaramanzie?
Veri e propri rituali o scaramanzie no. Magari abitudine ossessive: uso sempre gli stessi quaderni e le stesse penne dello stesso colore. E poi sono fedele allo scrivere la mattina; non mi fido di quello che scrivo dopo le sedici.
Qual è il testo teatrale che nella tua carriera ha rappresentato il momento di svolta? E perché?
Sicuramente il mio primo, La grande passeggiata: un po’ perché era appunto il mio inizio come autore “in proprio”, è un testo che ha quel candore un po’ selvatico che hanno sempre gli esordi. Non avevo idea di quello che stavo facendo, avevo ventidue anni. La regia era di Federico Tiezzi, il protagonista era Sandro Lombardi, due mostri sacri del teatro italiano, l’emozione è stata indimenticabile.
A quale dei tuoi testi sei più affezionato? E perché?
Tra tutti ti dico Uccidere il Tiranno, che feci a Napoli nel 2017 con la regia di Andrea De Rosa. Era un azzardo da tanti punti di vista, mi ero preso dei rischi abbastanza grossi, sia tecnici che politici, diciamo così, di cui per fortuna non mi rendevo pienamente conto. Andò benissimo, vinse anche un premio importante, ma soprattutto scrivendolo ho scoperto delle possibilità espressive che prima non conoscevo, e che poi ho sempre usato in seguito, insomma ha chiarito anche a me stesso un’identità autoriale. Non so se è il mio testo migliore, magari ne ho scritti di più belli, ma a livello di percorso è stato una svolta nell’approccio alla scrittura in cui mi riconosco ancora oggi.
Quale dei tuoi lavori è stato il più difficile? E perché?
Forse il più difficile è anche uno fra quelli a cui sono più affezionato: Il ministero della solitudine, una drammaturgia collettiva per cinque attori realizzata con lacasadargilla. Difficile non nel processo in sé, che invece è stato organico, spontaneo e molto felice, ma per come ci arrivavo io: quando abbiamo cominciato ero abituato a lavorare come una monade, a “fare parte solo per me stesso”, e invece questo lavoro (che per via della pandemia è stato anche molto lungo) mi ha costretto a mettermi in ascolto, a lavorare in un collettivo, a scrivere durante le prove e le improvvisazioni molto più “a caldo” di quanto fossi abituato a fare. Insomma ho dovuto cambiare metodo e mettermi in connessione. È stato un bellissimo momento di crescita, di maturazione artistica e umana, per me e credo anche per tutto il gruppo di lavoro.
La tua scrittura e il tuo metodo sono cambiati nel tempo? Come?
La scrittura è un percorso, quindi si cambia di continuo. Ma di base penso di essere rimasto alla mia vocazione iniziale e profonda. Le mie caratteristiche di fondo non le sento particolarmente cambiate. Quello che volevo fare quando ho iniziato a scrivere – un teatro di poesia abitato da necessità politiche; il desiderio di produrre ragionamenti per la comunità; fare del linguaggio un luogo di performance accessibile a tutti, anche al grande pubblico – ecco, sono le stesse cose che voglio fare ora. Quando ho iniziato quindici anni fa ero infinitamente più rozzo e istintivo, più retorico e più ingenuo, meno intelligente, meno lucido, mettici quello che vuoi, e se leggo certi vecchi testi provo persino imbarazzo per certe ingenuità. Penso sia normale, magari fra quindici anni i testi che sto scrivendo oggi mi faranno lo stesso effetto. Ogni testo d’altronde è sempre un tentativo di superare e migliorare i tentativi precedenti; l’insoddisfazione è la condizione permanente di ogni artista e ogni lavoro è un rilancio innanzitutto su se stessi. Ma di base, nelle motivazioni profonde, penso di non aver mai veramente deviato o cambiato rotta: ho sviluppato, ho approfondito, ho sperimentato, ma – spero – andando mai di lato e sempre avanti.
Cos’è per te oggi la drammaturgia? Di cosa deve occuparsi? Cosa la distingue dalla letteratura e dalla scrittura per il cinema?
Posso dirti quello che la drammaturgia è per me: uno spazio di processi collettivi, un luogo dove produrre figure, movimenti, simboli per la comunità. Sono un po’ ossessionato dal fatto che il teatro non possa mancare alla sua vocazione politica, e credo che per la drammaturgia oggi sia necessario tornare a chiedersi quale dev’essere il suo ruolo nella società. E io credo che quel ruolo sia appunto da riscoprire in una dimensione più politica del fare teatro, in un senso completamente diverso da quello che oggi s’intende come “teatro civile”. C’è stato forse un tempo in cui il ruolo del teatro poteva essere quello di “raccontare storie”, di conservare una mitologia culturale. Ma oggi che il tecnocapitalismo ha superato ogni limite e viviamo in una società dove quasi più niente riesce a raccogliere due, tre, quattrocento persone in una sala dove avviene un rito culturale, il teatro non può più ripararsi nell’intrattenimento colto, ma deve raccogliere la sfida di essere il luogo in cui la società elabora il suo linguaggio e i suoi strumenti di decrittazione della realtà. La drammaturgia dev’essere un catalizzatore di coscienza, aumentare l’intensità della coscienza personale e collettiva. Scrivere solo “belle storie” secondo me oggi non basta, serve qualcosa in più. Per ogni lavoro che faccio mi chiedo se quello che sto scrivendo è qualcosa che interessa solo a me, oppure ha qualcosa di importante da dire oggi, a questa società, con le esigenze che ci sono nel presente; se quello che faccio ha la dignità di stare di fronte ai problemi e alle domande e anche alla desolazione e alla disperazione delle persone del mio tempo. Come diceva Brecht, può fare teatro solo chi pensa che la realtà sia modificabile. È un’ambizione forse un po’ puerile, ma penso che, senza, abbiamo già perso la battaglia, non solo col cinema ma anche con netflix.
Quali sono i testi teatrali di “maestri” che ti hanno influenzato o che hai amato di più?
Non ti dico tre testi ma tre autori classici che per me sono stati fondamentali (per ragioni diverse): Georg Büchner, Peter Weiss e Pier Paolo Pasolini. Poi come ti dicevo ho avuto la fortuna di avere due maestri veri, Sandro Lombardi e Federico Tiezzi, che mi sono stati fondamentali per sviluppare un gusto e un’idea di stile. Vengo da una famiglia di operai, in casa non c’erano libri, ho iniziato a lavorare con la loro compagnia quando avevo vent’anni e non avevo idea di come si costruisce una “identità culturale”. I primi anni li ho passati a leggere libri, vedere film, guardare spettacoli che mi suggerivano loro. È un privilegio di cui sono grato.
Quali sono gli spettacoli importanti della tua vita di spettatore?
Demoni di Peter Stein; Scene di Amleto di Federico Tiezzi; Panico di Luca Ronconi; The repetition di Milo Rau; Rosa oder Die barmherzige Erde di Luk Perceval; Répétition di Pascal Rambert. Non so se sono gli spettacoli più belli che ho visto, ma sono quelli che, nel mio percorso, mi hanno impressionato di più.
Cosa non deve mai fare un’autrice/autore teatrale?
Non c’è niente che un autore bravo non possa fare bene. Posso dirti quello che non piace a me, la famosa “tazza di tè” che non è la mia: il naturalismo, la drammaturgia situativa di matrice anglosassone; il minimalismo del linguaggio, il tentativo di imitare sul palco la lingua che si parla tutti i giorni. Non c’è niente, neanche un fazzoletto, che portato sul palco di un teatro non si amplifichi sino a diventare qualcos’altro; figuriamoci il linguaggio. Il teatro, come diceva Testori, è un catalizzatore, un amplificatore vertiginoso anche delle cose minime. Un linguaggio che aspiri a essere “quello di tutti i giorni”, portato sul palco non regge, si polverizza, diventa insulso. Lo si può usare, ma bisogna sapere bene che non è quello che sembra.
Cosa non può mancare in un testo teatrale che consideri ben fatto?
Una dimensione linguistica forte, un’operazione sul linguaggio abbastanza potente da giustificare il fatto che ci sono tante persone zitte (e perlopiù paganti) ad ascoltare. E poi – anche se è banale ribadirlo – non può mancare la dimensione del conflitto. Il teatro occidentale è da sempre teatro del conflitto: conflitto tra persone, conflitto di simboli, conflitto di posizioni e di idee, qualcosa insomma di molto più simile a una lotta che a una celebrazione. Nessun testo teatrale funziona se dentro non c’è una battaglia.
Si può davvero insegnare a scrivere un testo teatrale? Fino a che punto?
A scrivere non si insegna. Si possono insegnare certe cose che non devono essere fatte, individuare gli errori, far capire come funziona un dispositivo drammaturgico e certi accorgimenti più o meno tecnici per metterlo in piedi e dargli una forma. Ma poi se il testo c’è o non c’è non dipende dalla tecnica, e non si può insegnare. L’allievo – se vogliamo chiamarlo così – è promettente non se è diligente e mette in pratica quello che gli dici, ma se ha una sua voce, qualcosa da dire e un modo potente di dirlo. Il compito del docente non è tanto quello di insegnargli a scrivere, ma di aiutarlo a sviluppare la sua voce. La vera didattica, credo, soprattutto per la scrittura, non è tanto passare delle nozioni o delle tecniche ma trovare e aiutare il talento di qualcun altro, stimolarlo, sostenerlo. Quando succede questo – e non succede sempre – la didattica è la cosa più bella del mondo.
Se vuoi, aggiungi una tua riflessione.
Mi fermo qui.
Graziano Graziani (Roma, 1978) è scrittore e critico teatrale. Collabora con Radio 3 Rai (Fahrenheit, Tre Soldi) e Rai 5 (Memo). Caporedattore del mensile Quaderni del Teatro di Roma, ha collaborato con Paese Sera, Frigidaire, Il Nuovo Male, Carta e ha scritto per diverse altre testate (Opera Mundi, Lo Straniero, Diario). Ha pubblicato vari saggi di teatro e curato volumi per Editoria&Spettacolo e Titivillus. Ha pubblicato l’opera narrativa Esperia (Gaffi, 2008); una prosa teatralizzata sugli ultimi giorni di vita di Van Gogh dal titolo Il ritratto del dottor Gachet (La Camera Verde, 2009); I sonetti der Corvaccio (La Camera Verde, 2011), una Spoon River in 108 sonetti romaneschi; i reportage narrativi sulla micronazioni Stati d’eccezione. Cosa sono le micronazioni? (Edizioni dell’Asino, Roma, 2012). Cura un blog intitolato anch’esso Stati d’Eccezione.