
di Paolo Landi
Fra gli scrittori e i critici contemporanei, Walter Siti è forse colui che più di ogni altro rovescia, nel lettore, il rapporto consueto tra l’autore e l’argomento di cui parla: non è tanto l’oggetto della sua riflessione a interessare (gli spunti di Siti sono a volte respingenti: Dubai, Michela Murgia, le periferie, la televisione spazzatura, i culturisti), quanto piuttosto lui stesso, la sua intelligenza febbrile, il suo modo di consumare ciò che affronta e come lo restituisce. Leggere Siti significa trovarsi continuamente sospinti oltre il tema, come se la materia fosse soltanto un pretesto per mettere in scena il laboratorio del suo pensiero, sempre aperto. Accade così anche con La fuga immobile - Lo strano caso della generazione Z (Silvio Berlusconi editore, 2025): ci si avvicina al libro per la solita curiosità verso i giovani – questi sconosciuti – ma ci si scopre presto più attratti dal riflesso che l’indagine proietta su Siti stesso, sul suo modo di pensare la critica e di esercitarla.
Interessano i giovani d’oggi a Siti? Direi di no. O meglio: gli interessano fino a un certo punto, quanto basta per prenderne le misure e rifletterne l’immagine dentro il proprio specchio critico. Il libro si apre con una ricognizione sulle università americane e sui safe space, dove Siti mostra di aver imparato diligentemente il linguaggio – lui che si definisce “nonno di nessuno” – e i gerghi di moda delle élite giovanilistiche: la French Theory, la standing theory, il FOMO, il binge watching, la iGen, l’intersezionalità. Li elenca quasi per dovere, ma il Siti che spiazza affiora altrove, magari nelle note: “non credo che c’entri, ma in casa mia muoiono tutte le piante grasse perché non riesco a trattenermi dall’annaffiarle troppo”, scrive a margine della constatazione che “il nostro cervello non si è evoluto e differenziato per funzionare nel mondo dell’abbondanza, siamo dei cactus nella foresta pluviale”. Oppure quando, dentro questo tessuto linguistico aggiornato, infarcito di categorie prese in prestito dalla sociologia dei media digitali, compare all’improvviso una citazione (tra quelle trash del figlio d’anima Alessandro Giammei e di Paolo Crepet) di Sandro Penna o di Eugenio Montale: incrinature, piccoli scarti di registro, che finiscono per svelare quello che Siti ha spesso sostenuto, che l’autore non scrive mai solo o tutto quello che intende, ma quello che il proprio desiderio, la propria memoria, le proprie ossessioni, finiscono per costringerlo a dire, ben oltre le intenzioni consapevoli. Squarci che tradiscono Siti e nello stesso tempo lo espongono: non è mai l’intenzione a decidere, ma un dettaglio che irrompe, e dice la verità dell’autore meglio di quanto l’autore stesso sappia. Appurato, dopo aver letto questo libro, che della generazione Z a Siti non gliene importa una beata mazza, possiamo addentrarci nel suo vero significato: non un’indagine sociologica travestita sui giovani, ma un ulteriore capitolo dell’autoritratto intellettuale di Siti, il suo modo inconfondibile di usare il pretesto dell’attualità per parlare di sé, dei propri fantasmi e delle proprie ossessioni.
Inevitabile allora che il pensiero corra alle sue ricerche pasoliniane, e che nasca il desiderio di interrogare non tanto la gioventù osservata nel libro, quanto il rapporto intimo e combattuto che Siti intrattiene (o, sarebbe meglio dire, ha intrattenuto) con la figura e con l’opera di Pasolini. Scrive in La fuga immobile: “Alla maggior parte degli adulti la capacità di utilizzare la nostra vita come materia prima per i suoi prodotti commerciali continua ad apparire mostruosa: ci sentiamo sfruttati, manipolati, furiosi con noi stessi di non saperci opporre, insomma passivi. Per i ragazzi che avevano uno o due anni al tempo della bancarotta di Lehman Brothers credo sia diverso – loro nell’acqua salmastra ci nuotano dentro, il neocapitalismo finanziario e tecnologico è anche un’occasione per fare esperienze che allarghino i confini della realtà”.
In questo passaggio, Siti coglie con chiarezza la frattura che separa adulti e giovani. Gli adulti, cresciuti in un’epoca che precede il capitalismo digitale, ne percepiscono ancora lo scandalo: lo vivono come sfruttamento e alienazione, come mercificazione della vita privata. I ragazzi, invece, vi sono immersi fin dalla nascita: non lo subiscono come una violenza esterna, ma lo riconoscono come l’ambiente naturale dell’esistenza. Ciò che agli adulti appare mostruoso diventa per loro un’esperienza normale. Il confronto con Pasolini illumina la portata di questa differenza. Negli anni Sessanta e Settanta, Pasolini osservava i giovani delle borgate nel momento stesso della loro conversione al consumo: ragazzi che, sedotti dalla televisione, dalla moda, dai capelli lunghi, dal motorino, abbandonavano un mondo popolare e arcaico per inseguire i simulacri del benessere. Quella improvvisa attrazione per i beni industriali era per lui un trauma antropologico, una lacerazione violenta che cancellava culture millenarie. Pasolini denunciava lo scandalo di una mutazione in atto, di cui i giovani erano insieme vittime e inconsapevoli protagonisti. Siti, al contrario, osserva un’altra condizione: il trauma è già stato consumato, il “prima” non esiste più. I ragazzi che descrive non scoprono il capitalismo digitale, ma vi nascono dentro. Non attraversano soglie, non conoscono strappi: abitano un mondo già mutato, per il quale non è possibile immaginare alternative. Dove Pasolini vedeva il dramma dello sradicamento, Siti registra l’inquietante normalità dell’adattamento.
In fondo, tanto Pasolini quanto Siti appaiono come due adulti posti di fronte a un’identica esperienza di impotenza, ma in forme diverse. Pasolini è impotente davanti alla violenza del mutamento: vede i giovani travolti dal consumismo e non riesce a trattenerli. Siti è impotente davanti all’assenza stessa di mutamento: osserva giovani già formati dal neocapitalismo tecnologico e non può indicar loro un altrove. L’uno impotente a frenare la metamorfosi, l’altro impotente a riattivarne una nuova. In entrambi i casi, l’adulto resta disarmato, incapace di aprire ai giovani non tanto un modello, quanto un varco verso la libertà. Pasolini si trovava ancora di fronte a un dramma di iniziazione (i giovani che scoprivano il consumo e venivano da esso trasformati), mentre Siti osserva un dato di nascita (i giovani che non possono immaginare un mondo fuori dal consumo tecnologico-finanziario).
Riflettendo sulla smidollaggine dei nostri ragazzi confrontata all’energia “che non sanno dove dirigere” dei giovani africani, Siti scrive di essersi rimproverato di cadere nel cliché “colonialista” del viaggio (in Madagascar), “da turista decadente che si illude di trovare, in un mondo povero e pre-industriale, la vera radice della vitalità e con essa la poesia”. Poi, a partire da un libro di geopolitica, si sofferma su come le aree extra-occidentali siano oggi abitate soprattutto da giovani, mentre l’Occidente è demograficamente vecchio. Questo passo (nel capitolo intitolato “Ahmed dagli occhi scuri”) dialoga in modo diretto con l’immaginario pasoliniano dell’”altrove vitale”, con Ali dagli occhi azzurri, con la poesia che racconta l’emigrazione e il sogno di un Sud povero e giovane che irrompe a devastare l’Occidente consumista. Pasolini, soprattutto negli anni Sessanta, coltivava un esotismo visionario: nell’Africa, nell’Asia, nel Sud del mondo, egli intravedeva non solo una riserva di autenticità, ma anche un’energia capace di redimere l’Europa corrotta. Siti, al contrario, mostra uno sguardo più autocritico e disincantato. Ammette esplicitamente la tentazione di riprodurre quel luogo comune, ma lo smonta, lo mette sotto accusa. Dove Pasolini cercava nell'”altro” geografico e antropologico la radice di una possibile rinascita poetica e rivoluzionaria, Siti vede il rischio di una proiezione nostalgica, turistica, che non regge di fronte alla complessità della realtà globale. Anche nei dati demografici si nota questa differenza: Pasolini affidava al giovane subalterno – il sottoproletario romano, il ragazzo africano, l’immigrato – un potenziale di purezza e di rivolta. Siti invece constata che sì, il Sud del mondo è giovane, ma non è il posto dove cercare un mito salvifico; lo guarda con lenti geopolitiche pulite, come fenomeno numerico e strutturale. L’Africa, la “più grande collettività adolescenziale mai esistita” non è più promessa messianica, ma fatto demografico, da osservare con lucidità e senza proiezioni utopistiche. Siti indulge a una retorica molto diffusa tra gli intellettuali della sua generazione: quella che distingue tra i saperi “alti”, puri e speculativi, capaci di formare coscienze critiche, e i saperi “bassi”, quelli applicati o ibridi, ridotti a tecniche comunicative o a linguaggi professionali. È un automatismo polemico che oggi suona usurato: perché i giovani non confondono più Marx con il PowerPoint, né pretendono di sovvertire il mondo attraverso i social. Se qualcosa emerge, semmai, è il riflesso di un malessere più profondo, che non riguarda dove si studia ma la sensazione collettiva di vivere in un’epoca senza progetto, senza possibilità di riscatto. L’utopia, insomma, non è morta per colpa di Scienze della comunicazione; sarà morta (forse) perché l’immaginario del futuro è stato sostituito da una gestione amministrativa del presente, che interessa di più. E questo (forse) Siti lo sa benissimo: le sue stoccate, più che ai giovani, sono indirizzate a sé stesso, e alla malinconia di chi ha visto passare troppi funerali delle idee (“L’utopia, da noi, è morta per sempre: l’hanno uccisa gli anni di piombo, l’accelerazione tecnologica, la socialdemocrazia e le convergenze parallele, le famiglie con l’ascensore sociale, i figli unici considerati preziosi germogli da proteggere, le facoltà di Scienze della Comunicazione e le proteste degli studenti come sfoggio di slogan autoreferenziali”).
È stato Siti a ricordare come per Pasolini i giovani non fossero soltanto figure letterarie, ma interlocutori reali di un progetto etico e culturale. Nei loro corpi, nei loro linguaggi e nei loro comportamenti lo scrittore friulano vedeva la traccia viva delle trasformazioni antropologiche della società italiana, e proprio per questo li caricava di una responsabilità che era insieme pedagogica e poetica, non una pedagogia scolastica, ma una “didattica della vita”, un tentativo di far emergere la verità dei processi che li attraversavano, anche quando loro stessi non ne erano consapevoli. Nei giovani Pasolini scorgeva al tempo stesso le vittime e l’indizio delle nuove forme di omologazione culturale, della mercificazione del desiderio, della colonizzazione dei corpi: un amore doloroso, mai pacificato, che si traduceva in un dialogo continuamente in tensione. Una prospettiva che torna, in forma traslata, nell’ultimo romanzo di Siti, uscito l’anno scorso, I figli sono finiti (Rizzoli, 2024). L’incontro fra Augusto, vecchio professore umanista, e Astòre, ventenne fragile e geniale, sembra costruito per verificare se un dialogo pasoliniano sia ancora possibile. Astòre incarna un presente ferito – la pandemia, la tecnologia invasiva, la sessualità digitale – che rifiuta i modelli tradizionali e sogna di diventare “insensibile come un robot”, pur restando inchiodato alla sua sensibilità estrema. Augusto, vedovo e malato, rappresenta un umanesimo consunto, incapace di dare risposte, ma non del tutto privo di pietà. Tra i due non c’è riconciliazione, ma un fragile spazio di riconoscimento reciproco: l’orrore del vecchio verso il giovane si accompagna alla commozione (che c’è anche in La fuga immobile), la solitudine di uno si riflette in quella dell’altro. In questa trama Siti riprende, a modo suo, la lezione di Pasolini: i giovani non sono semplici oggetti di osservazione, ma diventano la possibilità su cui si misura la verità dello sguardo adulto, con tutte le contraddizioni del desiderio, della colpa, della nostalgia. Se La fuga immobile sposta l’attenzione sulla condizione generazionale collettiva, I figli sono finiti ne aveva offerto l’allegoria narrativa: un dialogo difficile, talvolta impossibile, fra due mondi che si riconoscono soprattutto nella comune esperienza del dolore e del disagio.
Infine, due parole sull’editore di questo libro: molti hanno gridato allo scandalo che Siti avesse accettato di dare lustro con il suo nome a una casa editrice che Marina ha voluto dedicare al padre, Silvio Berlusconi. Secondo me, invece, questo libro è perfetto per quel catalogo: Berlusconi è stato il grande inventore della giovinezza come mito nazionale, incarnata e protratta nei suoi lifting, nei suoi trapianti di capelli, nella potenza sessuale chimicamente procrastinata; Siti non riesce ad appassionarsi alla Generazione Z ma se c’è un luogo giusto dove la giovinezza stanca e consumata di questi ragazzi trova accoglienza, forse è proprio nella casa (editrice) di Silvio Berlusconi.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente

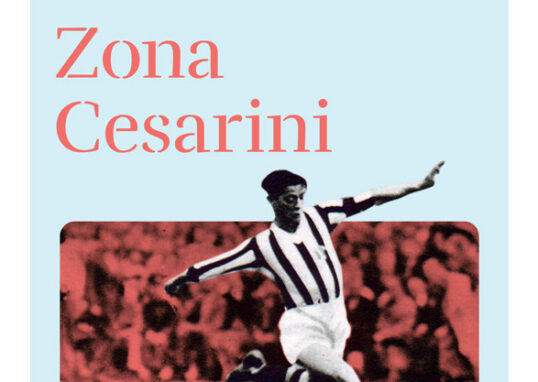


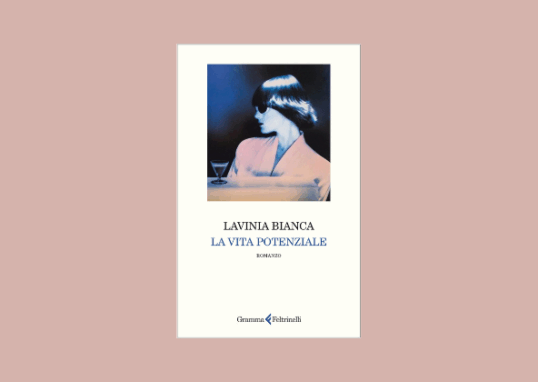


Condivido il pensiero di Paolo Landi e ammiro la sua capacità di scrittura alta eppure accessibile. Quanto alla Generazione Z mi chiedo se a qualcuno di tale generazione interessi il continuo rovistare che si fa, da parte di noi adulti/ anziani, nei loro gesti e comportamenti, cercando di carpirne i segreti. Ma soprattutto cercando di essere coinvolti nella loro vita, come dei genitori che non si rassegnano all’emancipazione dei figli. Si metta il cuore in pace anche Siti, “ quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia”….
PIER PAOLO PASOLINI UNA VITA PER LA MORTE
Un grande atleta, fu pure P.O., probabile olimpico come si dice in gergo sportivo, mi diceva sempre prima di ogni regata: “Danilo, la pelliccia è fatta di peli, di tanti peli” volendo dire che l’Insieme è concretizzato da tante piccole cose, anche accidentali, aleatorie, traduzione per speculum in aenigmate, all’inverso dunque, del detto: “il diavolo sta nei dettagli”.
Ho fatto amarcord stamani quando mi è capitato a tiro un pezzo cinefilo che traccia seppur a grandi linee, a maglie larghe – del resto si tratta di un articolo di pura critica cinematografica – una visione (parzialmente) inedita della figura assai più enigmatica di quanto si possa pensare del poeta al cubo, P.P.P., il notorio Pier Paolo Pasolini.
Scriviamo “parzialmente” in quanto questa singolare esegesi, è proprio il caso dirlo visto il carattere peculiare “para-religioso” dell’opera di Pasolini, era stata scritta da un carissimo amico del Poeta stesso, il pittore Giuseppe Zigania. Ne diamo un sunto qui onde scrollarci di dosso l’opacità, la melassa infida, il pensiero tutto-comfort zone che da sempre avviluppa (quasi) chiunque abbia trattato l’argomento: una trattazione che sempre, colla sola eccezione di Zigania è stata elaborata all’insegna del più bieco e trito conformismo.
«Se l’opera […] potesse diventare una rappresentazione […] in questo caso potrebbe essere un giallo assolutamente straordinario. […] per quanto allucinatoria possa sembrare, è una realtà in atto che […] affascina e talvolta sconvolge come solo può farlo l’esperienza del numinoso, ossia quel qualcosa di misterioso e tremendo che ci ispira diffidenza e venerazione insieme ed essendo, questa realtà, vicina e incombente, come lo è sempre ad esempio il pensiero della morte, nessuno, o quasi, riesce a coglierla nella sua interezza. Perché quest’ombra che cade su di noi è un valore che distrugge ogni altro valore». Così scrive con lungimiranza Giuseppe Zigania nel suo Hostia. Trilogia della morte di Pier Paolo Pasolini (Marsilio, Padova 1995, p. IX).
Vediamo di chiarire le tesi di Zigania. Non è certo per accondiscendere a quella Serpe in Seno al Pensiero della tarda Modernità che risponde al cognome di Adorno ed al nome di Theodor Wiesengrund ma quell’apologo riportato in un suo testo, Il gergo dell’autenticità. Sull’ideologia tedesca ci dà il destro per affrontare quanto andremo a scrivere. La pièce teatrale riporta che una signora esprimesse il suo ardore nei confronti di Heidegger e del suo concetto di morte, al che, uno degli astanti la freddò rispondendole che il generale nazista Ludendorff era stato davvero più incisivo in quel campo!
Alla stessa stregua, si potrebbe parafrasare l’intero susseguirsi della collana dell’Abbé, Roberto Calasso, chiosando che ci fu un figuro il quale è stato invero più incisivo di quest’ultimo incarnandosi nel Praticante della Morte: niente di meno che il torvo Pier Paolo Pasolini. Il poeta friuliano rappresenta una sorta di avatar dell’Abbé, ma un avatar che ha trasposto tutta la cosmogonia calassiana in una punta sincretistica dell’iceberg rappresentata dal Nulla Lucente, la Morte. Pasolini ebbe il triste merito, si immedesimò di persona nella Triste Scienza, del Nichilismo Assoluto, in carne ed ossa: stirneriamente, fondò la sua causa sul Nulla.
Queste non sono parole nostre ma quelle del pittore Giuseppe Zigania. Ripercorrerne qui le linee essenziali dei suoi compositi lavori non ci può non esser d’ausilio per capire dove sfociano i miasmi del pensiero calassiano oltre la soglia faconda delle color-pastellate copertine adelphiane dalle delicate nuances quando sono messi in Opera davvero. Un’Opera al Nero ovviamente. Zigania sostanzialmente afferma che tutta la vita del poeta friulano sia ruotata, sebbene con una codificazione fortemente cifrata, come un cuscinetto attorno al suo perno, attorno al Culto della Morte. Morte che il poeta si dette come forma deliberata di auto-sacrificio commista ad una possessione profondamente erotica. Basti dir questo, basti evocare questa trinità inversa, morte, sacrificio, possessione, per riconoscervi niente di meno che Shiva, su cui poggia l’intero impianto teoretico calassiano. Difatti Zigania così traduce l’opus alchymicum pasoliniano ponendo in bocca al poeta nero-vestito queste singolari parole:
«Il senso della mia opera-vita, comprensiva della morte, non potrà mai essere colto da un critico tradizionale se non a patto che la sua ricerca sia fondata sulla storia delle religioni, del mito, dell’alchimia, della magia, della cabala, dell’astrologia, insomma di tutte quelle non-scienze del grande e poetico Periodo Gnostico»
Forse questo schema ermeneutico potrebbe esser impiegato anche nel caso del Nostro? La passionalità morbosa, eroticizzante, che ebbe il poeta dalla P al cubo per il mito/teatro (teatro nero e delirante) che risponde al nome «di Medea, a quelle scene raccapriccianti […] oltre che con i sacrifici umani dei primi agricoltori» non risuona forse nei nodi gordiani dell’opus alchemico del Calasso e nella sua ricorrente rappresentazione, eslège quanto ancipite, di un mondo sordido ed abietto? La consonanza tra l’Abbé e la P al cubo è sin troppo evidente:
«dobbiamo ricordare che [P.P.P.] ha girato un film, Medea, per mostrare al mondo l’origine arcaica del sacrificio umano […] perfino un Manifesto per un nuovo teatro è stato da lui “emanato” per spiegare il significato della morte […] come rito culturale»
Alfine così fa e cosa ha fatto il Nostro se non girare un film letterario sull’origine arcaica del sacrificio umano? Di nuovo ritorna alla luce il significato recondito che ha il Teatro per le liturgie calassiane, quasi fossero tracciate dall’ago di un esiziale sismografo: un’emanazione del rito culturale della Morte, null’altro. Zigania chiosa Porcile di Pasolini così:
«orge sacre che nessuno capisce. […] durante i sacrifici umani tutti compivano devotamente questi riti. […] L’Uomo […] indossati degli indumenti femminili […] facendo buon uso della morte, si impicca»:
Tali e quali le filigrane sparse in bella evidenza ne L’impuro folle di Calasso le (ri)troviamo nel nerbo principale di un altro film pasoliniano: Porcile ovverossia l’invito ai tanatofili di tutto il mondo ad unirsi! gridando nel climax eiaculatorio, mentre la corda si stringe attorno al collo dell’impiccato, novello Marx faustiano! Viva la Muerte! La Decima Mas dei satanfedisti ha trovato la sua ammucchiata nell’immonda, sozza partouze del secolo! Sembra di vederli, confraternita di Fedeli devoti a Dioniso, novello Tiaso. Assembrati ebbramente sulla Zattera di Medusa, verosimiglianza del Ponte dell’Ultimo Titanic del caso, ennesimo bateau ivre, all’insegna della demenzialità, su cui svetta il Palo alla cui sommità garrisce la bandiera col Teschio e le Tibie, adornati da dildi di plastica, l’antico olisbos, i fianchi cinti da un sordido spago vermiglio in cui son infilati una sequela di piccoli teschi, latrano a squarciagola: Siam tutti gaiamente anti-vivisezionisti: nessuno di noi è giammai contro quella vivisezione umana che è l’aborto! issando l’ulteriore Bandiera della Fratellanza Universale, quella multicolore Arcobaleno. In tutto ciò P.P.P. avrebbe trovato degni Compagni di Merende o fu un caso isolato, un accidente aleatorio su un percorso che prevedeva ben altro? No, non fu un caso né fu un exploit singolo quello del Poeta: l’Occidente “uccidente”, quello che ben si ritrae nell’immonda opera dei Macellai della Striscia è costellato nel suo piano inclinato che ha come fine l’auto-distruzione: il sinistro Mario Mieli, apostolo dei Riti Uranici più dissoluti, gauche-caviar finito sparato da sé, portato come Idolo neo-san Sebastiano dalla comunità “inversa ed invertita”; il destrorso Mishima, anche lui auto-somministratosi l’eutanasia (a riprova che culto della Mano Destra o Sinistra c’est la meme chose…); il ladro Genet, scribacchino insignificante eppur issato ai podî della suprema letteratura (spazzatura) dalle solite ghenghe della massoneria stesso-sesso; l’umido Bataille che sotto il vestito sinistroverso sbavava lubricamente per le insegne ed i gagliardetti nazi-fascisti. Una sorta di filo rosso intesse intimamente destini e personalità diverse ma unite di una medesima fascinazione per … il Nulla e per la Feccia, per lo scarto evacuato da quel poco che rimane sano della visione dell’Occidente. Coincidenze fortuite queste? … sicuramente… ma del resto tutta la cosiddetta arte moderna è pervasa da una virulenta corrente scatologica, basti pensare all’enorme successo che ebbero due figuri quali Gilbert & George con le loro opere (?) The Naked Shit Pictures: un tempo l’Arte tentava di celebrare l’elevazione dell’essere umano alla Sommità Celestiale, oggi essa lo ricaccia verso la feccia del suo essere infimo.
L’equazione comparativa tra pensiero pasoliniano ammorbato dal Dio Morte e fascinazione dello stesso per la Funerea, devastante, ideologia Nazista trova riscontro in ADOLFO BELARDINELLI nel suo Stili dell’estremismo. Critica del pensiero essenziale, Editori Riuniti, Roma 2001, p. 94, il quale aveva notato sagacemente che esisteva una spina dorsale comune di fascinazione tra il pensiero ex-nazista nient’affatto abiurato e l’intellettualità di sinistra italiana: questa spina, questa cerniera, è nient’altro che il Nichilismo, ovverossia le edizioni Adelphi spiegate ai Bambini… ci torneremo sopra, nel frattempo, basti dire che sfogliando la cipolla di cui i veli multipli costituiscono l’Inganno Totale vediamo sempre più distintamente barbagliare una lucina in fondo al tunnel della Menzogna che rapporta indissolubilmente l’operato venefico dei Macellai della Striscia coll’osservanza stretta di dettami cabalistici esoterici: uomo avvisato mezzo salvato; bisognerebbe farlo risuonare nelle orecchie del quasi sterminato gregge che bela (le capre belano…) ad ogni apparizione delle leziose paginette multicolori: chi non si rende conto d’essere affatturato da ciò, chi – gli stessi medesimi – che non si avvedono di essere preda di uno sciorinare della Cabala Erotica dei nostri tempi, sono spettatori esterni allo Sterminio. Non serve Heidegger per capirlo.
Se fosse ancora in vita la squadra della Questura, la BuonCostume dei casini, dei bordelli, avrebbe il senso dell’humour di incolparli a mo’ di boutade di Concorso Esterno in Sterminio. Pasolini l’ebbe a capire e cercò disperatamente la Fine nell’Ostia, nel doppio-senso di cittadina ma anche di paramento (de)sacralizzato. Se l’ebbe a capire Pasolini è ora che lo capiamo pure noi.