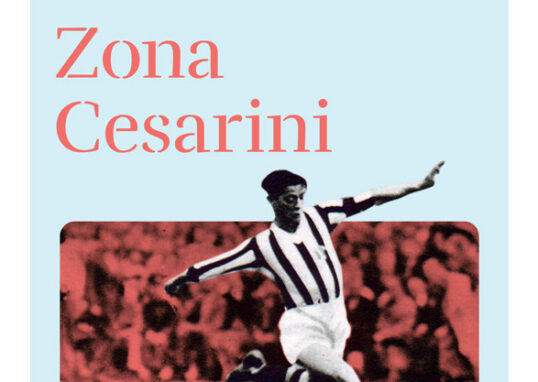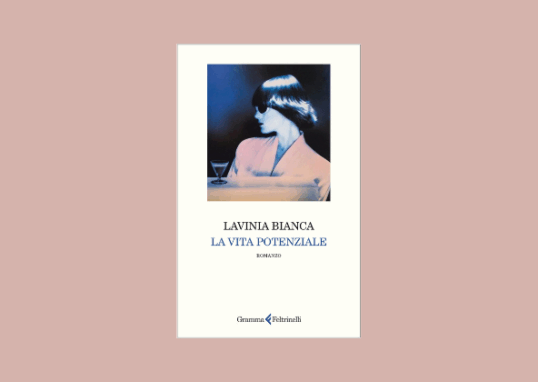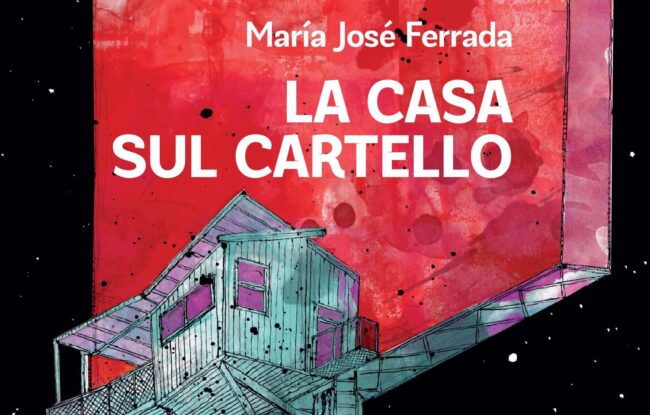
Quale è l’idea che un ragazzino si fa del confine? Il confine tra ciò che si vorrebbe essere e quello che gli altri vorrebbero noi fossimo, tra la storia che vorremmo avere alle spalle e quella che effettivamente abbiamo, tra la quantità di parole che vorremmo sentire dagli altri e quelle che gli altri ci dicono e poi quali parole? La casa sul cartello, della scrittrice cilena María José Ferrada, edito da Edicola Ediciones e tradotto da Marta Rota Núñez, racconta anche di questo: la voce narrante è quella di un bambino di undici anni Miguel, lui guarda al suo microcosmo circostante e lo racconta, mostrandoci in esso alcune caratteristiche ricorrenti in tutto il resto di mondo: la paura del diverso, lo stigma della follia, il rifiuto della povertà, la smemoratezza sulle proprie origini.
La storia è quella di Ramón, a suo tempo ragazzino felicemente solitario che crescendo cerca di andare incontro al desiderio di normalità degli altri socializzando e tenendo una parvenza di normalità. Finché non ce la fa più, non riesce più a vivere nel “rumore del mondo”, il mondo degli altri. Così lascia la casa dove vive con Paulina, lascia il suo lavoro, e costruisce la sua casa su una insegna enorme della Coca-Cola, lungo la strada e di fronte alle palazzine in cui abita tutta la sua gente. Viene pagato per fare il custode dell’insegna e così ci vive attaccato, in solitudine, facendosi portare cibo e bevande, soprattutto birra, che tira su con uno sgangherato sistema di carrucole.
Pochi lo vanno a trovare, Paulina e Miguel, che insieme prima e separatamente poi, affrontano la ripida scala fino alla casa sul cartello. Inizia un viaggio speculare tra ciò che vede Ramón, le stelle, le luci sulla collina e sull’acqua, le luci delle finestre delle palazzine di fronte, e ciò che tutti gli abitanti delle palazzine vedono: Ramón che vive sul cartello senza scendere mai.
Le palazzine sono state costruite in grande economia, tra i vari appartamenti anche senza alzare la voce tutti sentono tutto, nel bene e nel male, ma poi tutti compaiono con la faccia del decoro alla riunione condominiale mensile in cui uno dei 4 punti da discutere è sempre Ramón: il diverso che mai è stato in fin dei conti accettato e che a un certo punto ha scelto di saltare il confine, in verticale, ed essere quello che voleva essere lontano dal rumore del mondo, lo strano che da ragazzino veniva etichettato come stupido fino a diventare il pazzo sul cartello della Coca-Cola.
Miguel, giorno dopo giorno, per due mesi, segue questa partita tra gli abitanti delle palazzine e Ramón, scoprendo umane viltà e pochi sentimenti: i sentimenti positivi paiono passare solo attraverso il volto di Paulina che «Aveva deciso di starsene zitta e concentrata sui saponi perché non si fidava delle parole, o meglio, aveva notato che ciascuna di loro – la parola “amore”, per esempio – aveva i suoi ripiani. Non si poteva aggiornare l’inventario a ogni frase. Invece di chiarirle, finivi per complicare le cose».
La partita a cui Miguel assiste precipita alla comparsa di un altro nemico che sbilancia il già fragile equilibrio: dopo Ramón, sono i senzatetto che cercano di costruire le loro povere baracche poco distante dalle palazzine. L’odio si rimpolpa, i bambini vestiti di stracci vengono scacciati quando si avvicinano per giocare, i vecchi evitati senza pietà; nessuno delle palazzine sembra avere memoria delle proprie origini, pure loro arrivano da là, anche loro erano dei senza tetto. Così il mondo si capovolge sotto gli occhi di Miguel, un mondo in cui le tragedie del passato non insegnano nulla ma aiutano alcuni a ricordarsi che si può ricominciare altrove, che si può rifiutare un modello basato sull’odio, che si può volare via.
La casa sul cartello è un racconto sull’irresponsabilità degli adulti e sulla vulnerabilità dei bambini, di come il collettivo possa divenire pericoloso e il singolo possa decidere di staccarsene, di come il passato ignorato non dia respiro al presente e al futuro; è un libro di lucida poesia, una storia piena di ironia che svela il sudiciume dell’umanità e narra la speranza di chi vuole svoltare e trovare un proprio posto nel mondo. María José Ferrada in questo libro, come nel precedente, – Kramp, una storia narrata in prima persona da una ragazzina che diviene una sorta di romanzo di formazione, tanto stralunato quanto realistico – a un certo punto della narrazione mette sotto la lente di ingrandimento l’“insetto della sorte”, uno di quegli insetti che si posano nel punto preciso in cui la vita cambia il suo corso, quella frazione di secondo in cui un personaggio decide di cambiare la sua sorte, nel bene o nel male. Andare a vivere in una insegna pubblicitaria, o volare via, o prendere un autobus per un altrove.
Anna Toscano vive a Venezia, insegna presso l’Università Ca’ Foscari e collabora con altre università. Un’ampia parte del suo lavoro è dedicato allo studio di autrici donne, da cui nascono articoli, libri, incontri, spettacoli, corsi, conferenze, curatele, tra cui Il calendario non mi segue. Goliarda Sapienza e Con amore e con amicizia, Lisetta Carmi, Electa 2023 e le antologie Chiamami col mio nome. Antologia poetica di donne vol. I e vol. II. Molto l’impegno per la sua città, sia partecipando a trasmissioni radio e tv, sia attraverso la scrittura e la fotografia, ultimi: 111 luoghi di Venezia che devi proprio scoprire, con G. Montieri, 2023 e in The Passenger Venezia, 2023. Fa parte del direttivo della Società Italiana delle Letterate e del direttivo scientifico di Balthazar Journal; molte collaborazioni con testate e riviste, tra le altre minima&moralia, Doppiozero, Leggendaria, Artribune, Il Sole24 Ore. La sua sesta e ultima raccolta di poesie è Al buffet con la morte, 2018; liriche, racconti e saggi sono rintracciabili in riviste e antologie. Suoi scatti fotografici sono apparsi in guide, giornali, manifesti, copertine di libri, mostre personali e collettive. Varie le esperienze radiofoniche e teatrali.