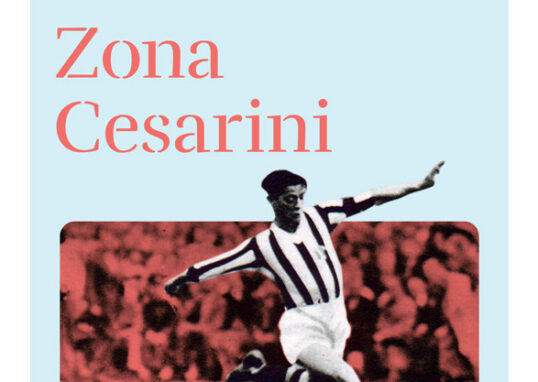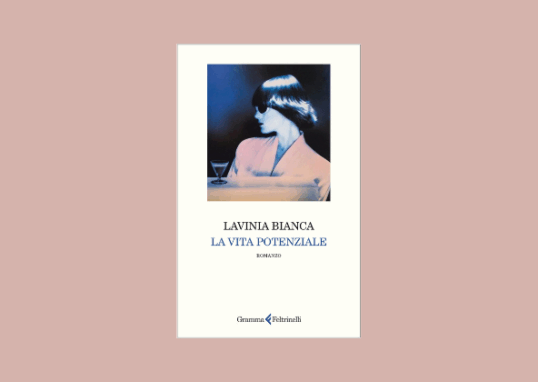L’articolo che segue è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.
“Dopo quindici anni di vita urbana, l’uomo ritorna alla selva. A essa lo legano indissolubilmente il suo modo di essere, di pensare, di agire. Un giorno ha lasciato la selva con la stessa drastica urgenza con cui oggi ci torna”.
Horacio Quiroga scoprì il suo dovere di uomo nel 1903, a venticinque anni, accompagnando a Misiones il celebre poeta Leopoldo Lugones. Era stato, fino allora, uno scrittore di talento e un dandy inseguito dall’ombra della tragedia, ma lontano dalla selva non aveva ancora trovato se stesso. Aveva cercato di inserirsi negli ambienti letterari con alterne fortune.
Era partito per il classico viaggio di formazione a Parigi con l’eredità ricevuta dal patrigno suicida e tuttavia era tornato indietro senza nulla, senza neppure la più blanda illusione, solo una barba destinata a renderlo famoso. Il 1900 era dietro l’angolo. Ma Quiroga doveva perdere ancora due fratelli uccisi dalla febbre tifoidea e doveva uccidere accidentalmente il suo migliore amico pulendo una pistola, per decidersi a lasciare l’Uruguay dove era nato nel 1878 a Salto.
Il richiamo della foresta pluviale però doveva ancora attendere. Era cresciuto su Edgar Allan Poe, soprattutto, ma anche su Kipling e Maupassant. Aveva affinato le armi di uno stile sobrio, naturalista e modernista. Ma imparò a renderle definitivamente incisive nella selva. Qui, come scrive Ernesto Franco, introducendo la magnifica raccolta di racconti che appare in libreria (Tigre per sempre. Racconti 1917-1935, trad. e cura Jaime Riera Rehren, Einaudi, pp. 349, euro 24), Quiroga scoprì che “per poter accedere alla “vita integrale” è necessario diventare “padrone delle parole” che possono definirla.
Le parole, prima ancora di essere belle, “consonanti o assonanti”, devono essere vere. Non è una volontà estetica, in quei territori, ma una “necessità vitale”. Le parole dei trentatré racconti contenuti in questo libro ce lo mostrano di continuo. Costituiscono un esempio celebrato da infiniti autori, su tutti Cortázar. Ci troveremo dentro il nucleo della tragedia umana, scavando nel misterioso intreccio che lega animali umani e uomini animali, passando dai famosi racconti in cui gli animali parlano e si comportano come uomini a quelli in cui gli uomini parlano e si comportano come animali.
Del resto l’ombra della tragedia non smise di accompagnare Quiroga. Nella selva dove aveva portato a vivere la prima moglie, dovette ritrovarla suicida. Era il 1915 e con i due figli Quiroga tornò a Buenos Aires, vide crescere la propria fama, visse nella precarietà, si innamorò di una compagna di classe della figlia, la sposò, tornò ancora nella selva nel 1932, visse l’abbandono della seconda moglie, si ammalò.
All’inizio del 1937 fu ricoverato a Buenos Aires. Fece in tempo a scoprire nei sotterranei dell’ospedale un uomo affetto da mostruose deformazioni che lo rendevano spaventosamente inumano, quasi animale. E fu di fronte a lui, dopo aver costretto i medici a liberarlo dalla prigionia, che ingurgitò una tazza di cianuro e andò incontro al suo destino.
Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha pubblicato con Ponte alle Grazie i romanzi Sono comuni le cose degli amici (2009, finalista al Premio Strega), Il toro non sbaglia mai (2011), È giusto obbedire alla notte (2017, finalista al Premio Strega), e il saggio narrativo L’abisso di Eros (2018). Con Einaudi ha pubblicato traduzione e commento del Simposio di Platone (2009) e i saggi narrativi Le lacrime degli eroi (2013), Achille e Odisseo (2020), Il grido di Pan (2023). Per HarperCollins sono usciti il romanzo Sono difficili le cose belle (2022) e il saggio narrativo Sognava i leoni. L’eroismo fragile di Ernest Hemingway (2024). I suoi racconti sono apparsi in riviste, antologie e ebook (come Mai, Ponte alle Grazie 2014), mentre i reportage di viaggio e le cronache letterarie escono su La Stampa e L’Espresso. Cura un sito di cultura taurina: www.uominietori.it