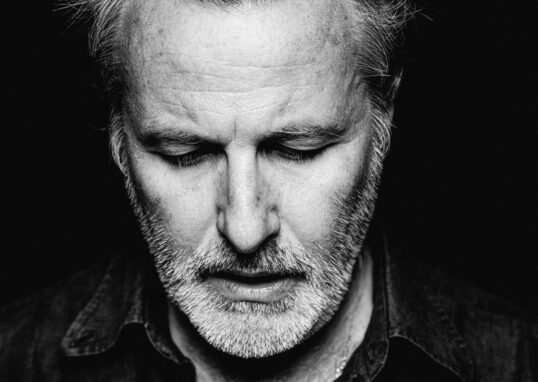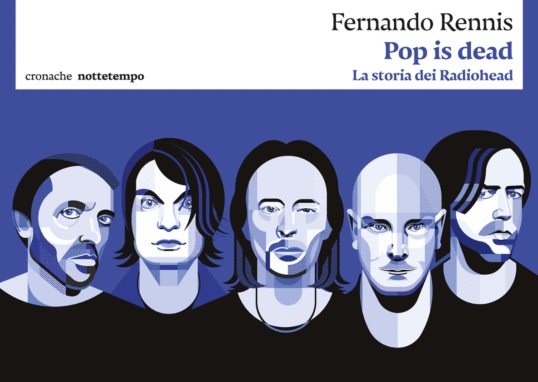Pubblichiamo, ringraziando l’autore Daniele Piccione e l’editore Mimesis, un estratto da “La lunga notte dell’Idroscalo. Il delitto Pasolini” di Daniele Piccione.
***
I prodromi di un assassinio
La mia giovinezza è trascorsa nell’incubo di essere uncinato o impiccato. Ho sempre avuto il terrore di una morte violenta. Ecco, quelle piazze vuote con i camion dei fascisti, quell’angoscia di morte, sono tra i motivi ispiratori di Salò.
Inverno 1975. L’attenzione sul poeta ha passato il livello di guardia da quasi un triennio. Dal 1972, Pasolini ha fatto sapere a tutto volume di un nuovo percorso di scrittura intrapreso con slancio: Mi sono caduti per caso gli occhi sulla parola “Petrolio” in un articoletto credo dell’“Unità”, e solo per aver pensato la parola “Petrolio” come il titolo di un libro mi ha spinto poi a pensare alla trama di tale libro. In nemmeno un’ora questa “traccia” era pensata e scritta.
Si può dire poi che la voce dello scrittore abbia fatto segnare un progressivo crescendo su questo argomento. Ha parlato spesso – e senza lesinare dettagli – di questo suo vivo interesse per la politica energetica, per le vicende e il ruolo dell’Eni. Lo ha collegato a qualcosa che sta scri- vendo. All’inizio, il progetto era informe, poi è divenuto tutt’altro che oscuro. Pasolini aveva smesso di nascondere quanto vicino si stava por- tando alla traumatica rottura degli equilibri nell’Eni, dovuta all’incidente di Bascapè in cui era perito Enrico Mattei. Era una storia che, in mano al suo potenziale divulgativo e alla sua capacità di immergerlo, pur visibile, nella storia dello sviluppo del potere in Italia, non andava bene affatto.
E poi, sul finire del 1974, le antenne avevano già fatto registrare vibrazioni intense, quando Pasolini aveva pubblicato Che cos’è questo golpe? “Io so”. In molti si erano preoccupati, perché tra le righe dello scritto erano apparsi nomi e addebiti precisi: “Io so i nomi delle per- sone serie e importanti […] che stanno dietro ai personaggi grigi e puramente organizzativi come il generale Miceli”.
La tensione era ulteriormente salita quando nel mirino del poeta, nel febbraio del 1975, era finito proprio e direttamente il presidente della Montedison e, prima ancora, successore di Mattei alla guida dell’Eni. Eugenio Cefis era dunque destinato ad avere un ruolo in quello che Pasolini annunciava come “una sorta di Satyricon moderno”.
A primavera, la cosa era diventata ancora più preoccupante, perché si avvertiva un certo legame con le voci che si rincorrevano circa il girato del film ormai vicino alla conclusione, appunto Salò o le 120 giornate di Sodoma. Come spesso accade, la stretta osservazione degli scarti e delle evoluzioni della vena artistica di Pasolini finisce per con- centrare contro di lui le forze che temono la sua dirompente capacità persuasiva. È un processo di psicologia collettiva da non sottovaluta- re. Mettere al centro dell’attenzione un intellettuale capace di calcare una tribuna alta e al contempo rivolta a masse di lettori implica co- stanti contatti, rapporti, scambi di vedute.
Si consolidano così preoccupazioni comuni e solidarietà tra chi è ostile alla via intrapresa dal poeta bolognese. E questa ostilità trasmigra dalle opere e dalle scelte artistiche alla persona. I termini del di- scorso si fanno gradatamente più duri. Si cerca un modo per depotenziare il clamore di quello che Pasolini produce con crescente intensità. E, in fondo, non ci sono molte strade da percorrere. Esiste solo il modo definitivo.
Minima&moralia è una rivista online nata nel 2009. Nel nostro spazio indipendente coesistono letteratura, teatro, arti, politica, interventi su esteri e ambiente